-
Categoria principale: RIVISTA online HELIOPOLIS
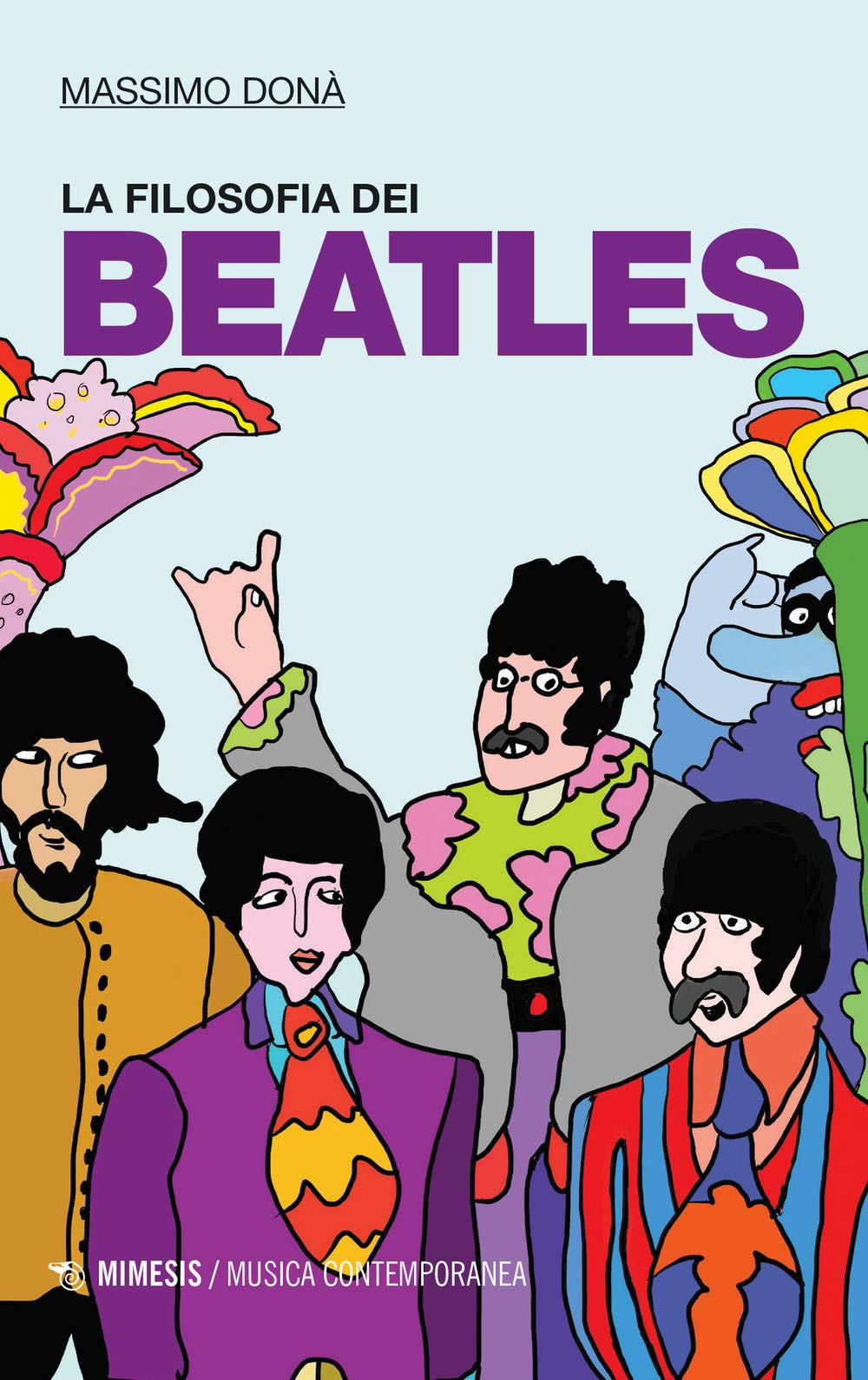
I Beatles e la filosofia- La verità della musica
- di
- Giovanni Sessa
- Ci sono epoche della storia in cui il vento del cambiamento si impone agli uomini. Il Novecento è stato un secolo di grandi speranze, ma anche di immani tragedie. Per due volte l’idea della realizzazione di una vita piena e persuasa, fece irruzione tra gli uomini, creando sconcerto e diffondendo un afflato utopico inusuale. Ciò avvenne nei primi decenni del «secolo breve», con l’affermarsi delle avanguardie, il cui momento apicale si dette nella musica grazie alle innovazioni introdotte da Schonberg, Stravinsky, Bartok e Satie, e all’inizio degli anni Sessanta, quando comparvero, dapprima sulla scena inglese e poi internazionale, i Beatles, i quattro favolosi ragazzi di Liverpool. La loro musica, ancor oggi, è icona di istanze di cambiamento: personale e politico ad un tempo e centrato sulla costruzione di un nuovo sguardo sul mondo. A ricordarcelo è Massimo Donà nel suo ultimo lavoro, La filosofia dei Beatles, nelle librerie per Mimesis (per ordini: mimesis@mimesisedizioni.it, 02/24861657, euro 10,00). Il volume, peraltro, è impreziosito da tavole dipinte dall’autore.
- Ad immetterci nelle vive cose della produzione musicale del quartetto inglese, non poteva essere che Donà, filosofo e jazzista, ma soprattutto protagonista di un percorso di ricerca che lo ha condotto a recuperare al filosofare l’originaria vocazione museale. L’interesse per i Beatles ci pare nascere, nel filosofo veneziano, da una considerazione storica sugli anni Sessanta e quelli immediatamente successivi. In tale epoca era in atto il tramonto degli immutabili, per dirla con Severino, espedienti creati per tacitare l’angoscia del divenire, baluardo costruito dal prevalere della logica identitaria. Tutto era in crisi e, come già nel XIX secolo aveva insegnato Nietzsche: «la verità non era altro che un grande inganno» (p. 37). Nella musica dei Beatles si mostra così, dato il clima nel quale fu creata, una «questione di verità». Dai loro pezzi si evince che i quattro giovani, appassionati lettori degli esistenzialisti e degli autori della Beat generation, ma anche, in particolare McCartney, cultori dell’arte ultima, dalla pittura metafisica al surrealismo e di Magritte (la mela di quest’ultimo ispirò il simbolo della casa discografica Apple), andavano alla ricerca di qualcosa di «più vero». Innanzitutto: «Non ci si poteva più accontentare dei dati di fatto, ossia della verità empirica» (p. 34).
Si diressero verso un altrove, trascritto nella loro musica e nei loro testi, forzando le barriere ossificate dell’esperienza di senso comune, anche grazie alla sperimentazione psichedelica, cui furono introdotti da Bob Dylan nel 1964. Un testo emblematico in tal senso è, Got to get You into My life, scritto da Paul McCartney. Non può essere sottaciuto neppure l’incontro con le filosofie d’Oriente delle quali si occupò, primo tra i quattro, George Harrison, così come il loro interesse per la cultura dei nativi americani. Ne trassero uno stimolo profondo che li portò, nell’approccio al reale, a privilegiare l’immaginazione. La loro è musica per immagini. Pertanto: «La verità dei Beatles non si sarebbe mai lasciata definire dal ‘cogito’ cartesiano, e neppure dalla metafisica aristotelica» (p. 35). Le composizioni attestano una doppia verità, testimoniata dalle personalità musicali di John e Paul. Ritmica, quella del primo, melodica quella del secondo. L’esistenzialismo tragico di Lennon, memore della lezione heideggeriana e sartriana in tema di «gettatezza» dell’Esserci, fa il paio con la segnatura ottimistica e positiva di McCartney. In ciò si dà il vero: nel doppio, nella contraddizione, nel metamorfico.
Tale acquisizione teorica trovò configurazione musicale in Nowhere Man, sorta di manifesto dadaista-surrealista lasciatoci in eredità da Lennon, uomo inesistente. L’inesistenza era tema già attraversato da Kojève: «in contrapposizione alla tradizione parmenideo-cartesiana» (p. 44). Solo pensando il reale alla luce dell’inesistente, sarà possibile guadagnare una via atta a condurci di fronte al mistero della vita. Lungo tale percorso si impara con lo Jago shakespeariano, con John Cage e Pirandello che l’Io, non essendo né questo né quello, in realtà si concede come continua metamorfosi: «John era realmente un’identità di opposti, così come erano opposti tra loro anche le identità musicali di Paul e John» (p. 52). Tutta la produzione dei Beatles attesta il rapporto Uno-Molti, anche se nei diversi periodi creativi, tale relazione ha assunto modalità espressive divergenti. In Sgt. Pepper, del 1966, il quartetto di Liverpool riuscì a comporre in uno i differenti interessi musicali, le articolate fonti d’ispirazione e le passioni non comuni. Il sound dell’LP, testimoniante l’armonicità conseguita dai Fab Four, si tradusse in metafora della nuova armonia che si sarebbe potuta realizzare nel mondo. Le ricerche sonore messe in atto in Revolver, conseguirono la ‘grande forma’, agognata dagli artisti tra Otto e Novecento, solo in Sgt. Pepper. I quattro musicisti miravano, anche attraverso la particolarità della copertina, ad un’arte totale, capace di coinvolgere tutti i sensi. - Al contrario, White Album testimonia la rottura dello specchio di Dioniso, l’impossibilità di ricomporre in uno il molteplice, come nell’esperienza della Lettera di Lord Chandos di von Hofmannsthal, nella quale il molteplice si dà in elementi irriducibilmente individuali: «Le singole personalità dei Beatles non si sarebbero più lasciate comporre ed iscrivere entro una cornice in grado di determinare un vero e proprio disegno unitario» (p. 75). L’opera complessiva era ormai ridotta ad un semplice ‘foglio bianco’, quello dell’album in questione, su cui ognuno di loro trascriveva musicalmente il proprio racconto incondivisibile. White Album rappresenta l’ingresso in quella che Derrida ha definito l’età della pura differenza. Un mondo, esattamente come quello cantato dai Beatles, sempre diverso da sé. Con Abbey Road, infine, tutto si sarebbe distinto perfettamente, ma rendendo evidente il medesimo: «mostrando che si trattava ancora una volta dei Beatles» (p. 148).
- Un mondo, quello dei baronetti, in cui nessuno può stupirsi di essere diventato altro, pur continuando a rimanere il medesimo. La loro musica è invito ad essere sempre uomini nuovi, a comprendere come eternità e divenire si lasciano: «riconoscere solo nel pulviscolo generato dal tempo» (p. 93). La medesima visione si palesa nei film Magical Mystery Tour, viaggio psichedelico a bordo di un bus colorato, e in Yellow Submarine, in cui venne recuperata l’idea di ‘durata’, un tempo di qualità oltre la spazializzazione moderna. La vocazione dei quattro musicisti, ricorda Donà, fu chiasmatica. Merleau-Ponty con chiasma indica un plesso in cui in ogni opposto emerge ciò che esso ‘non è’. Oggi, ascoltare le loro canzoni, risveglia la possibilità dell’impossibile, è un invito a realizzare Pepperland , Città del Sole, oltre i confini, tracciati dalla logica eleatica e difesi dai Biechi Blu.
I Beatles e lo stesso Donà, con la proposta di una filosofia musicale, ci sollecitano ad aprirci all’irruzione del nuovo: «solo così, potremo fare esperienza dell’infinita ricchezza di un’identità in senso proprio “vivente”» (p. 95). Ci stimolano a ricordare, con il Paracelso di Borges e, più in generale, con il pensiero ermetico, che noi siamo, già da sempre, in Paradiso.
