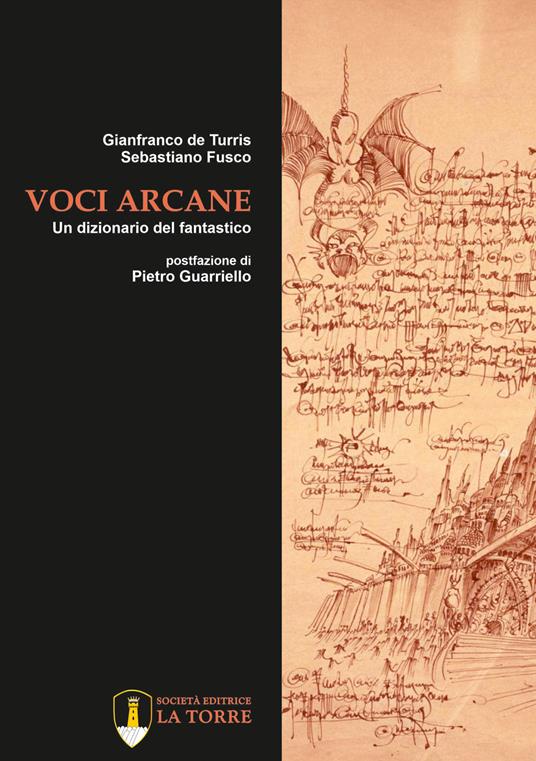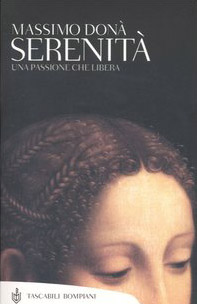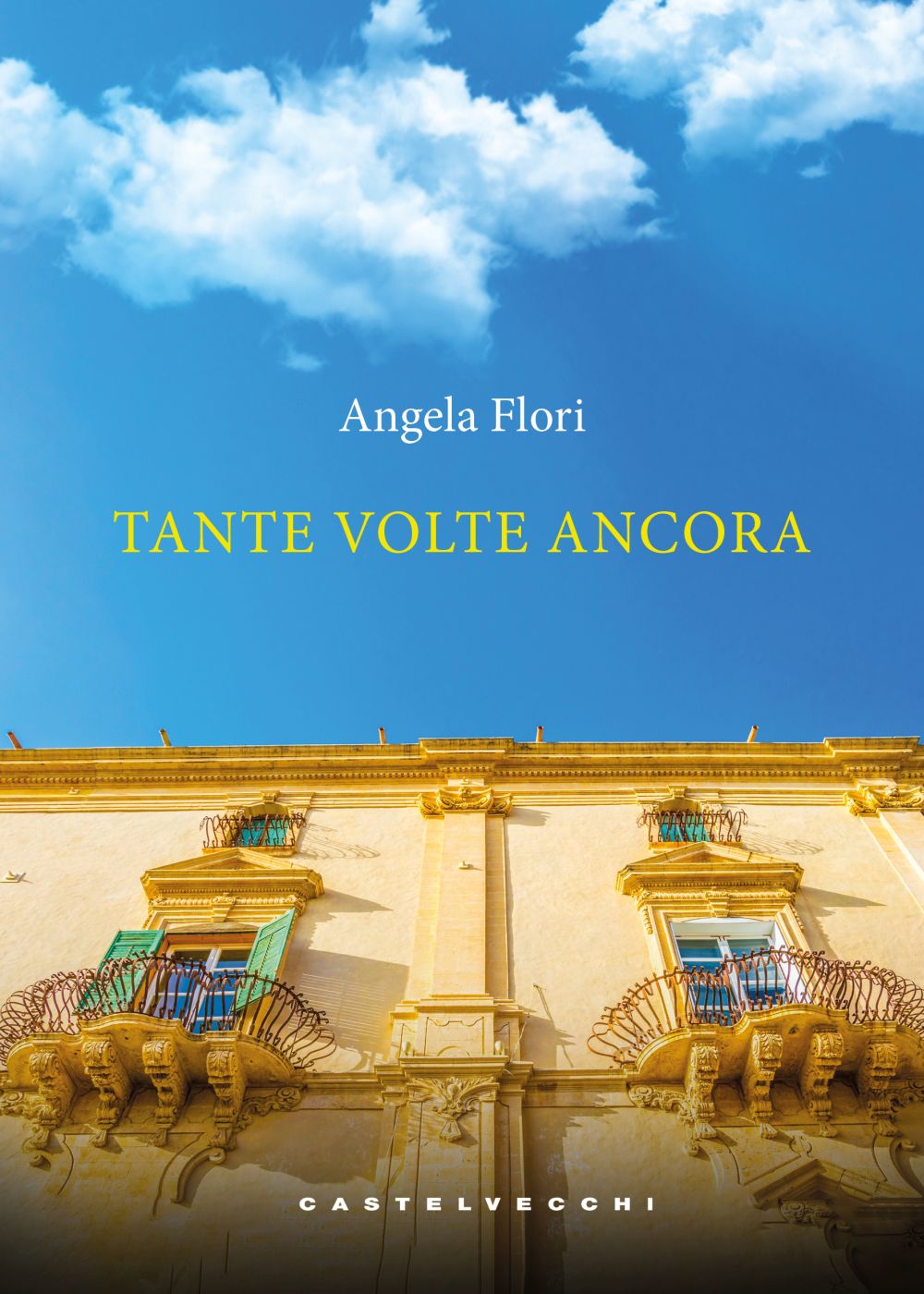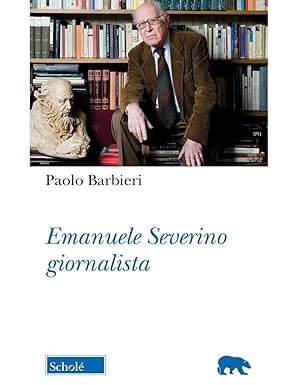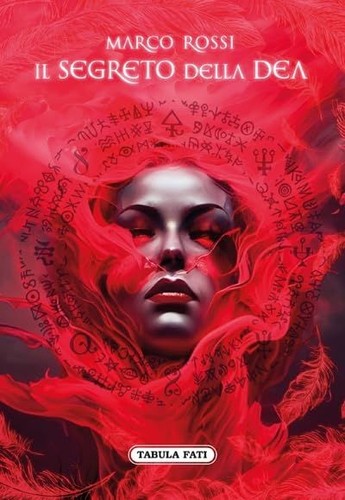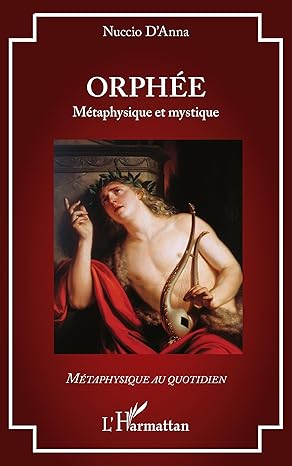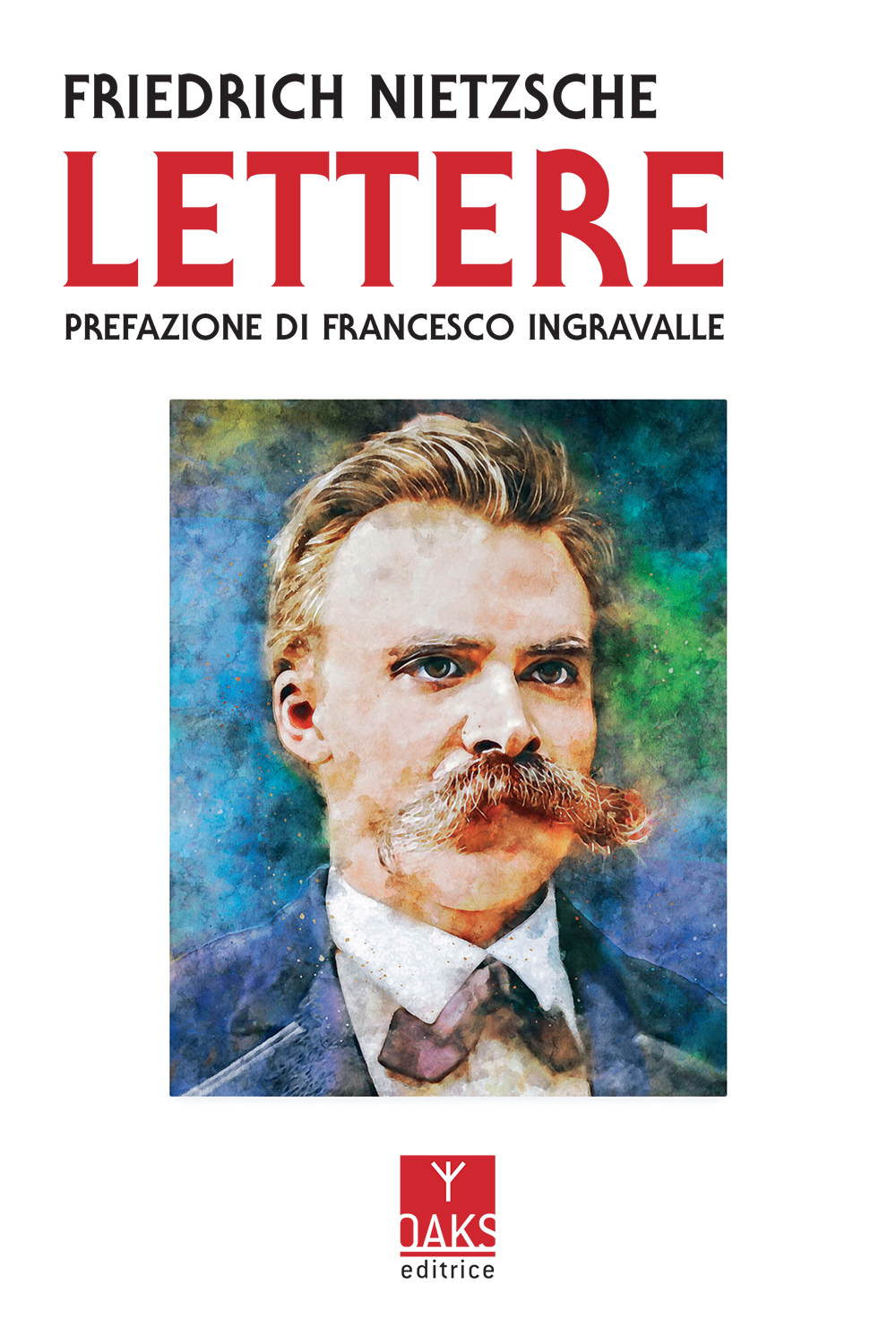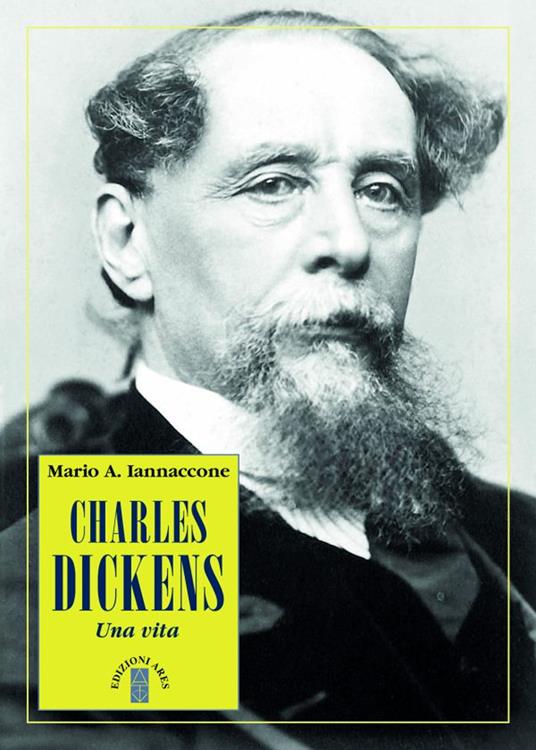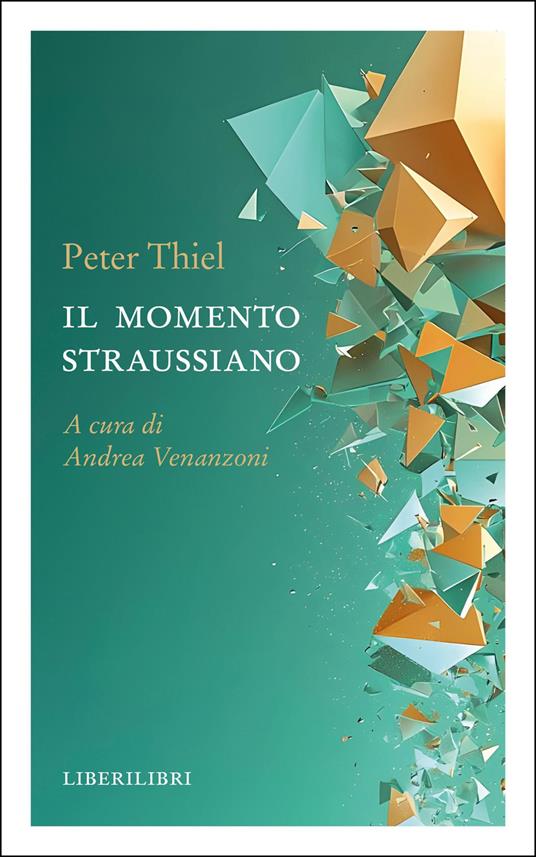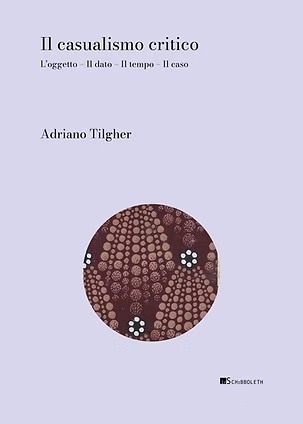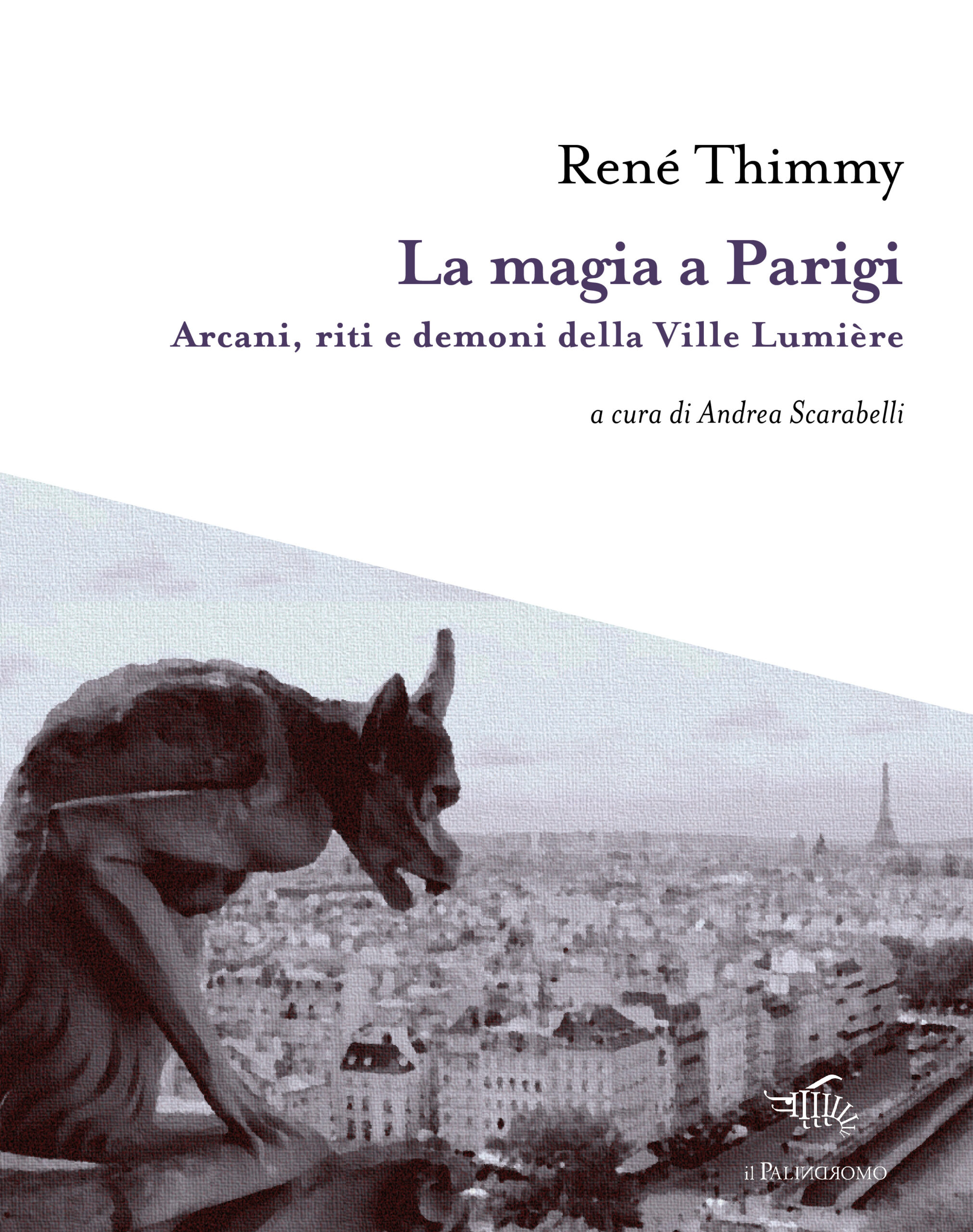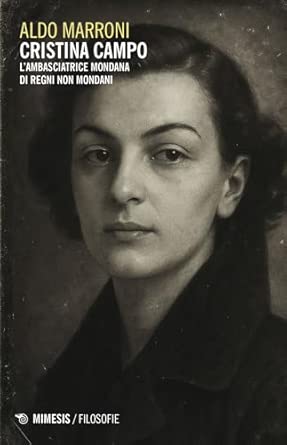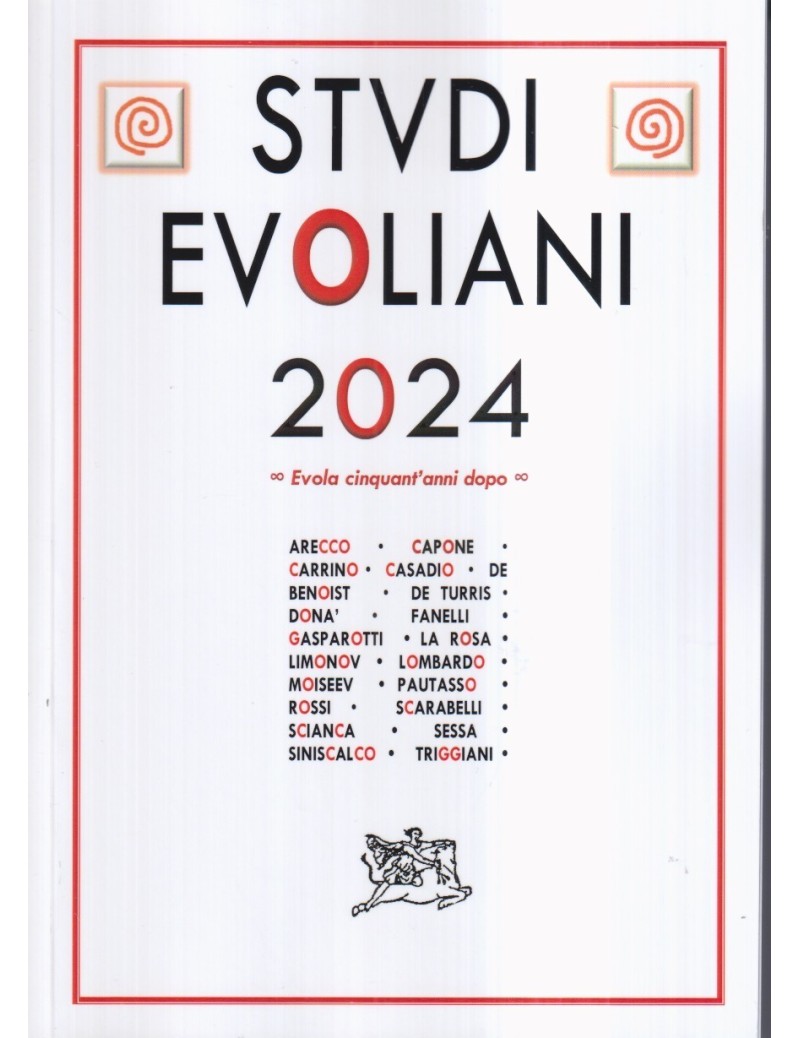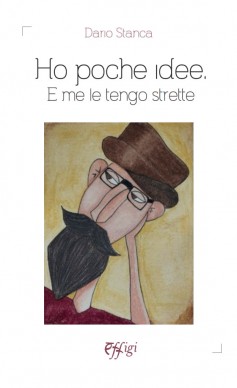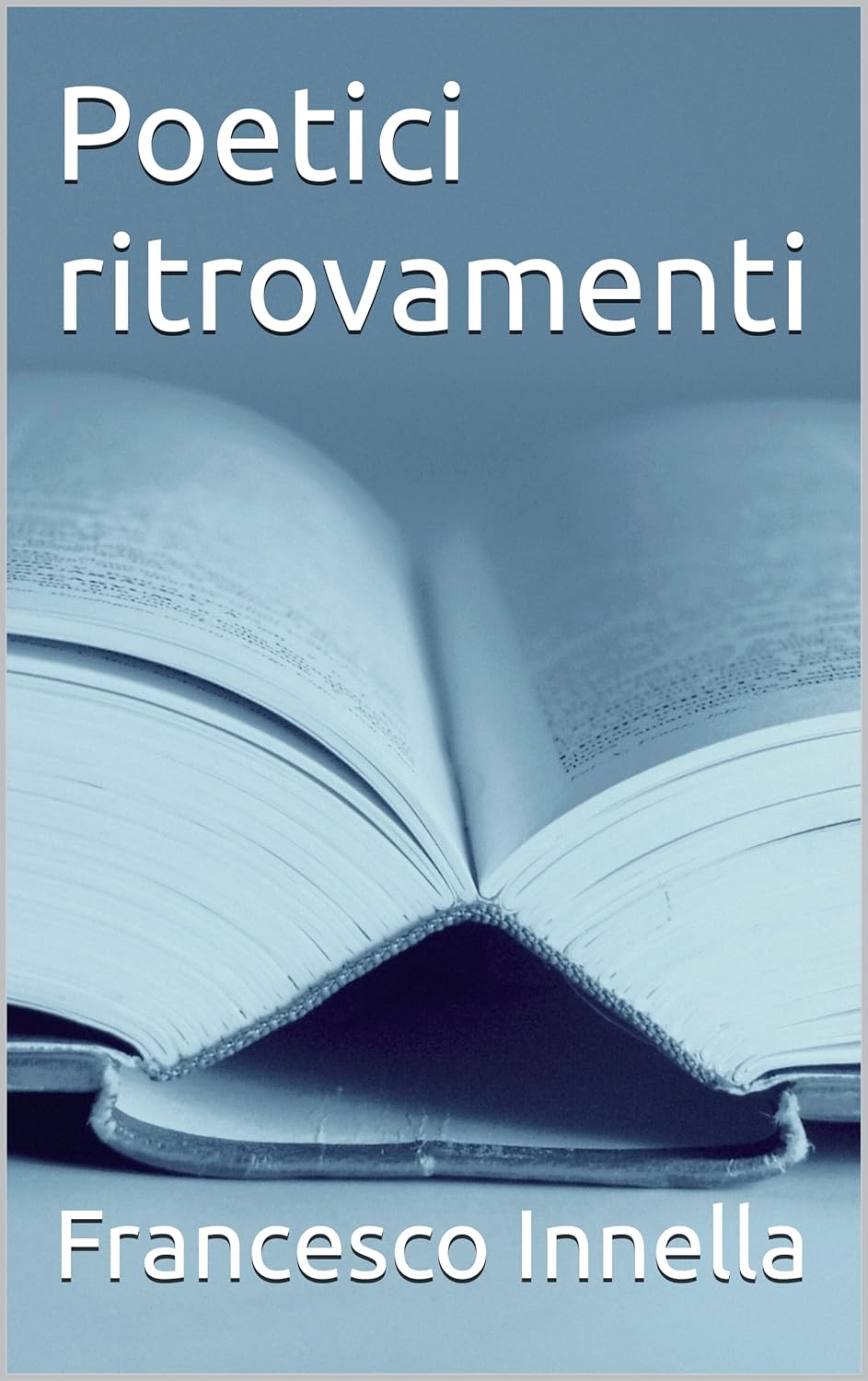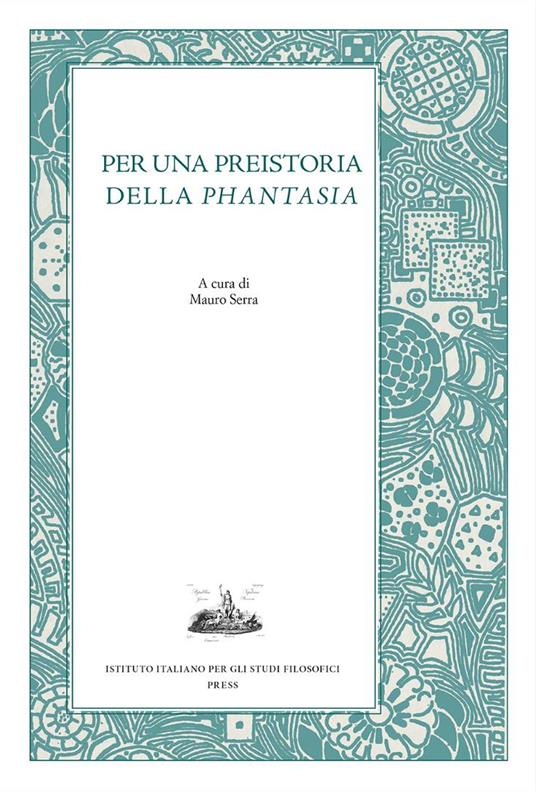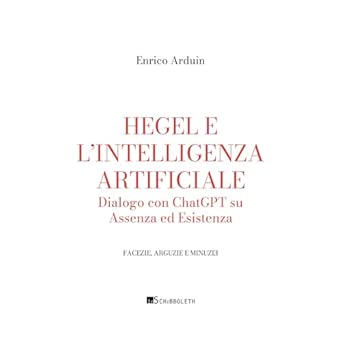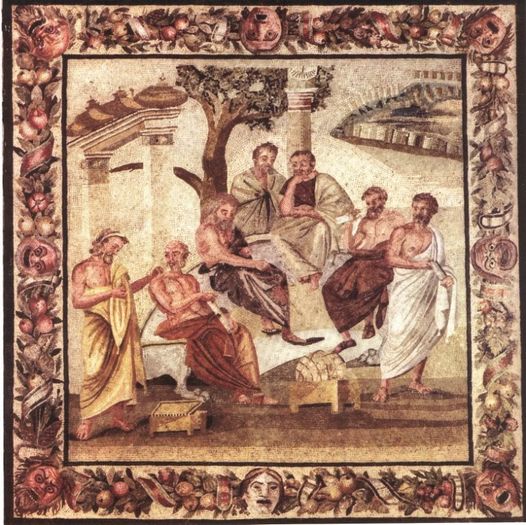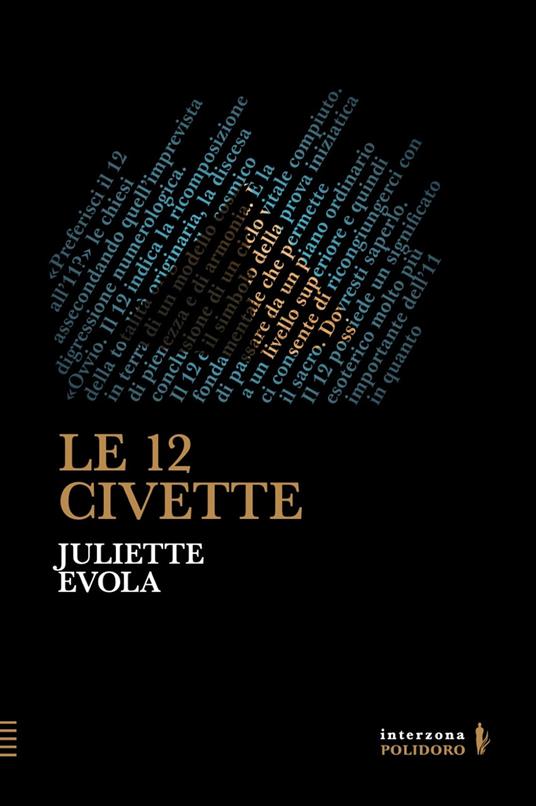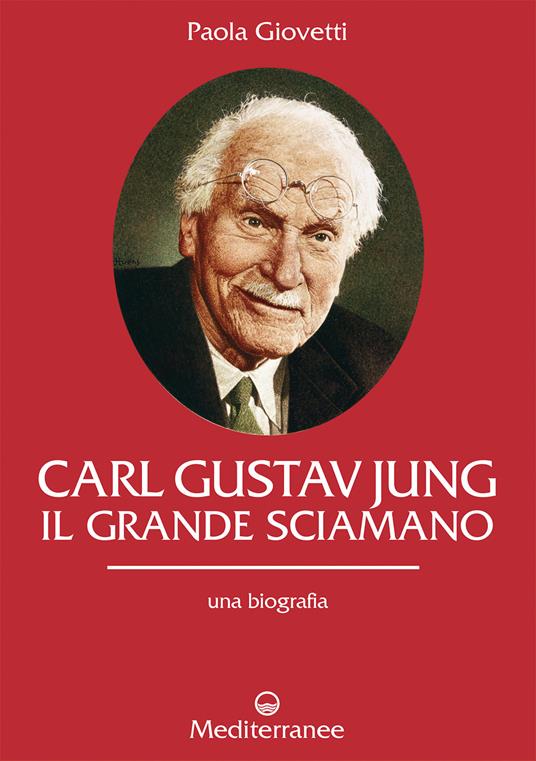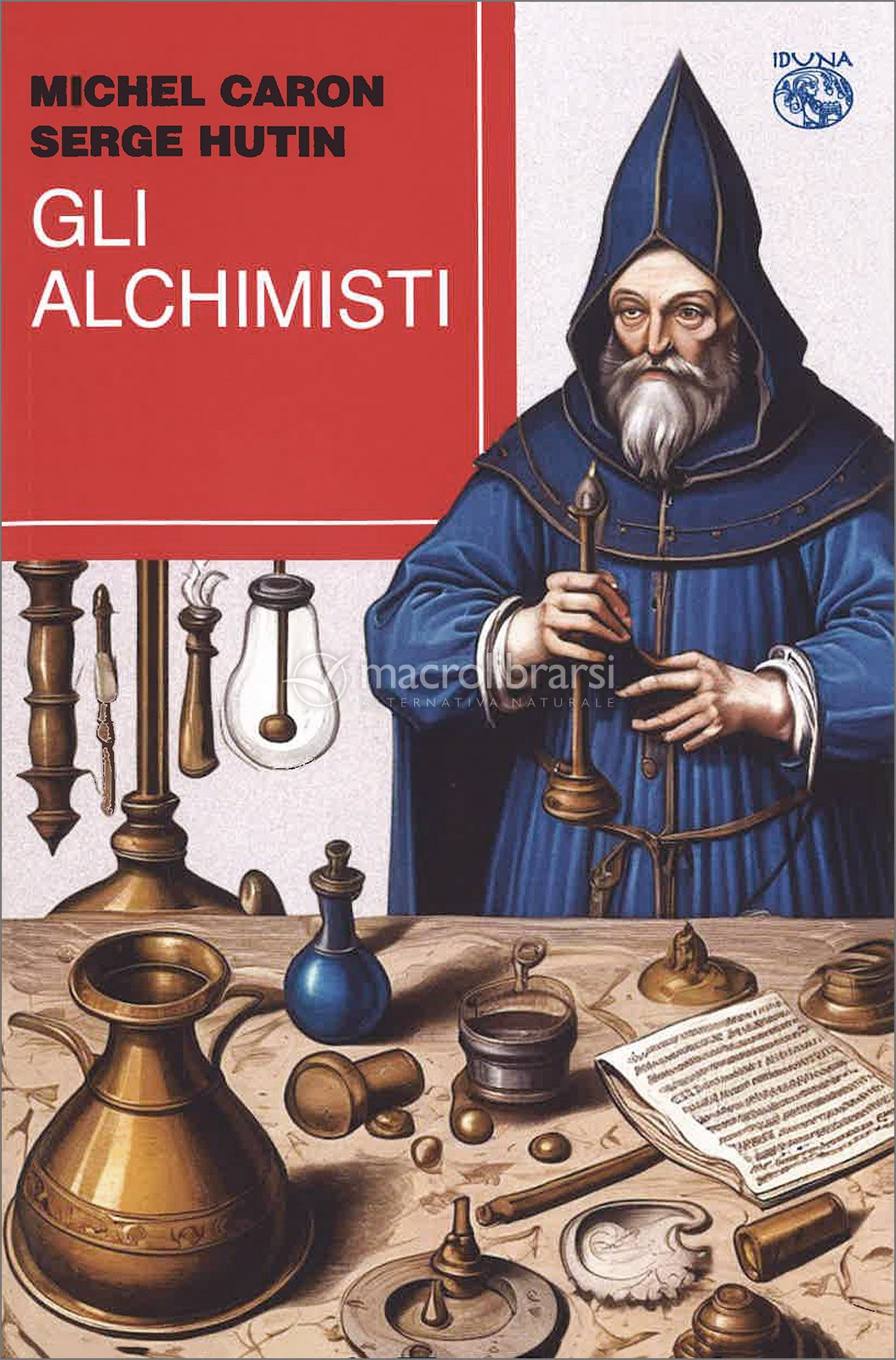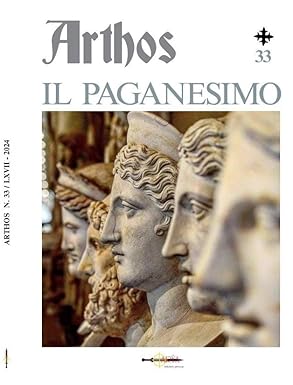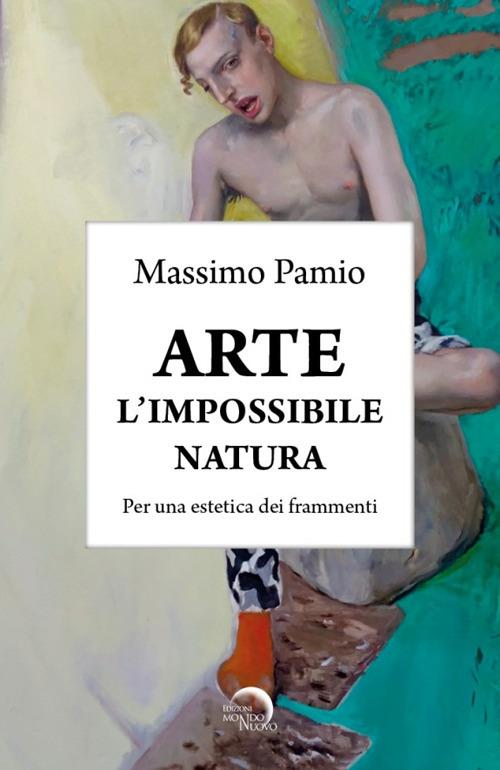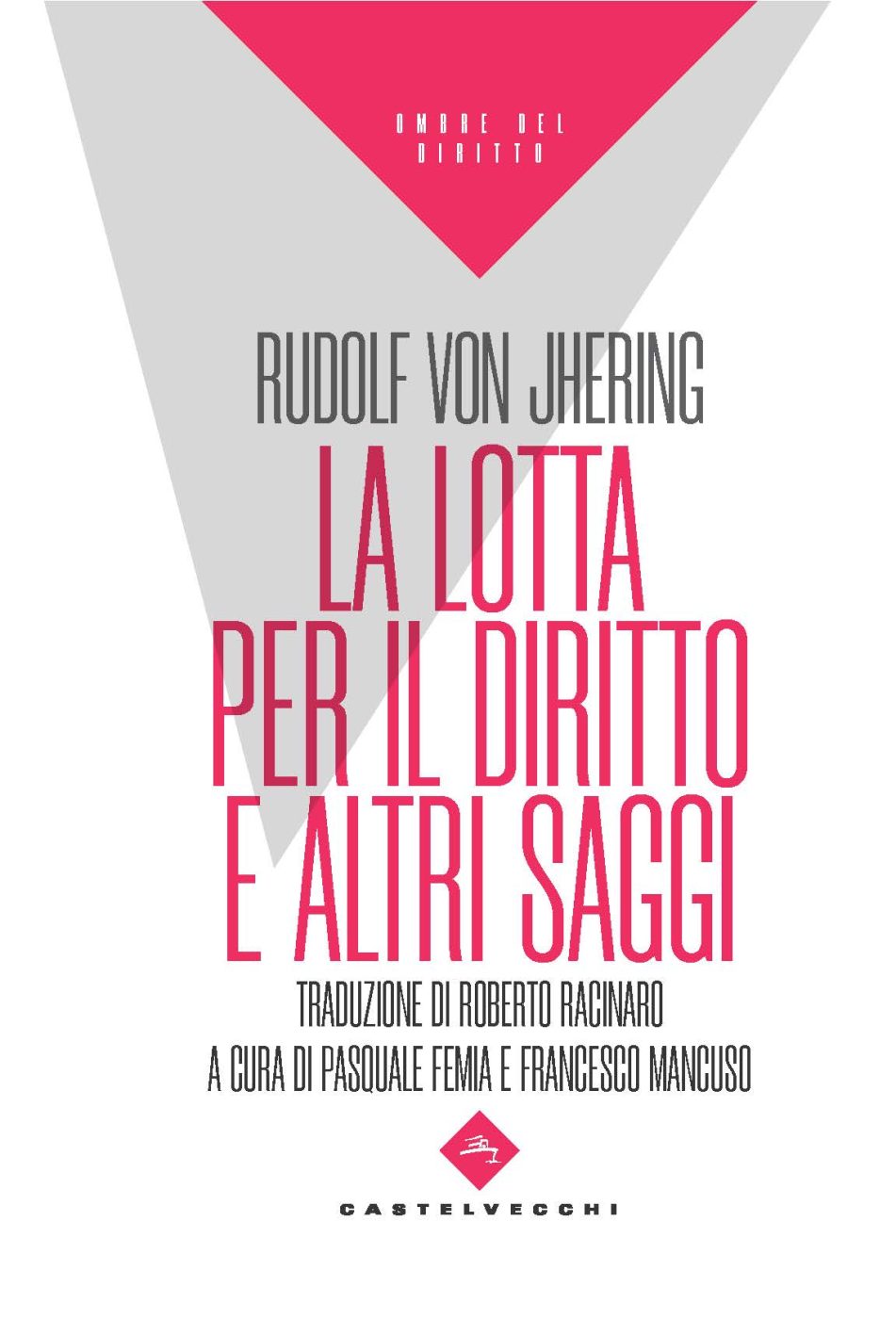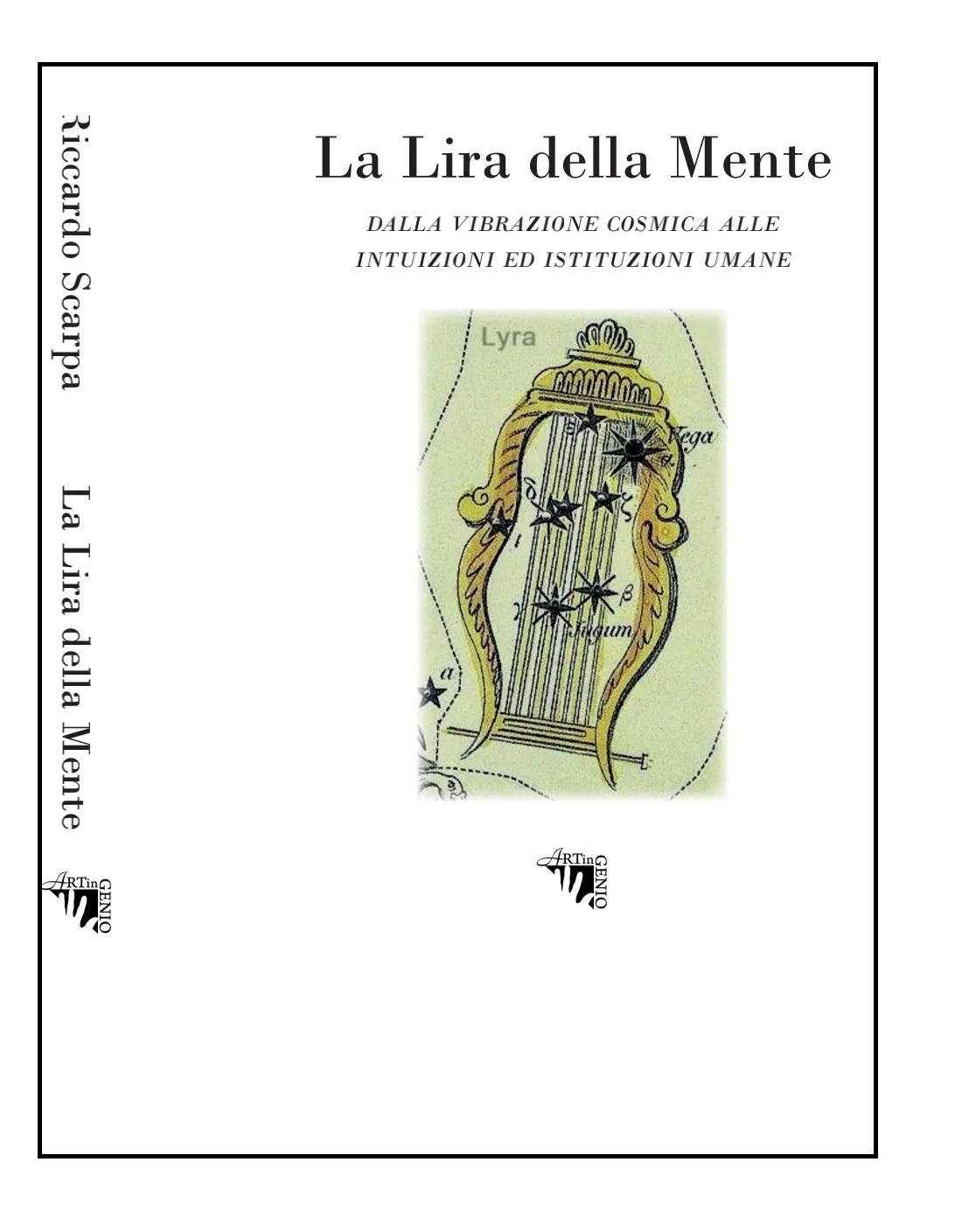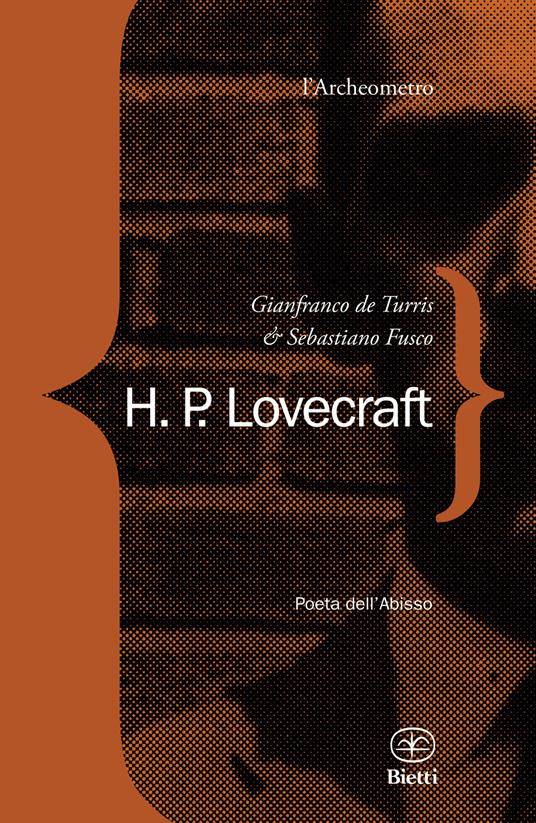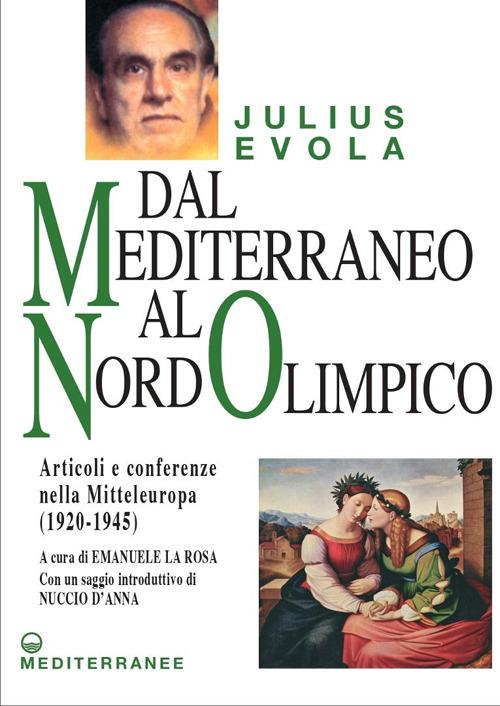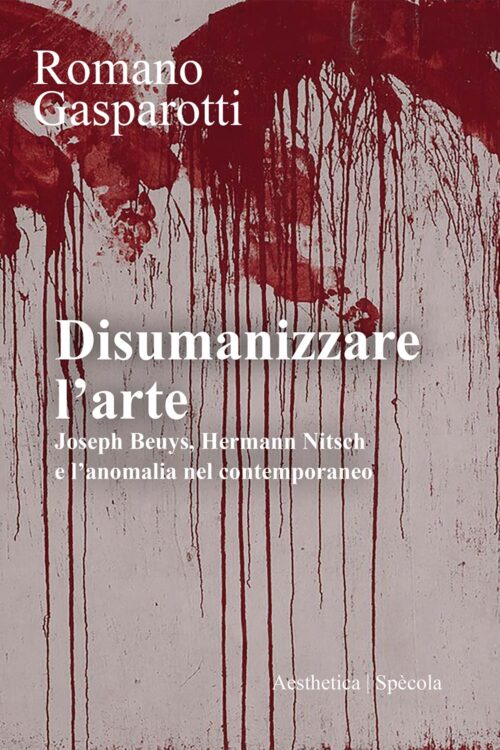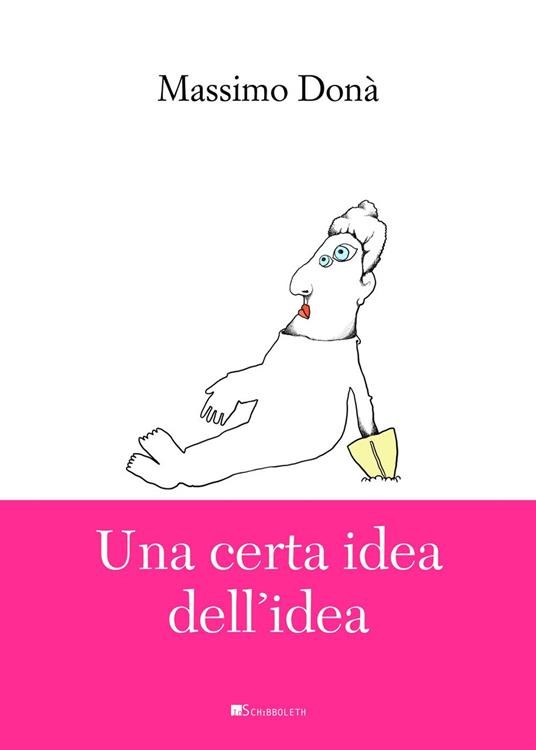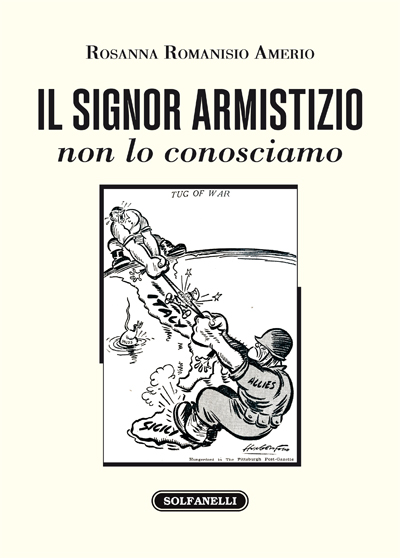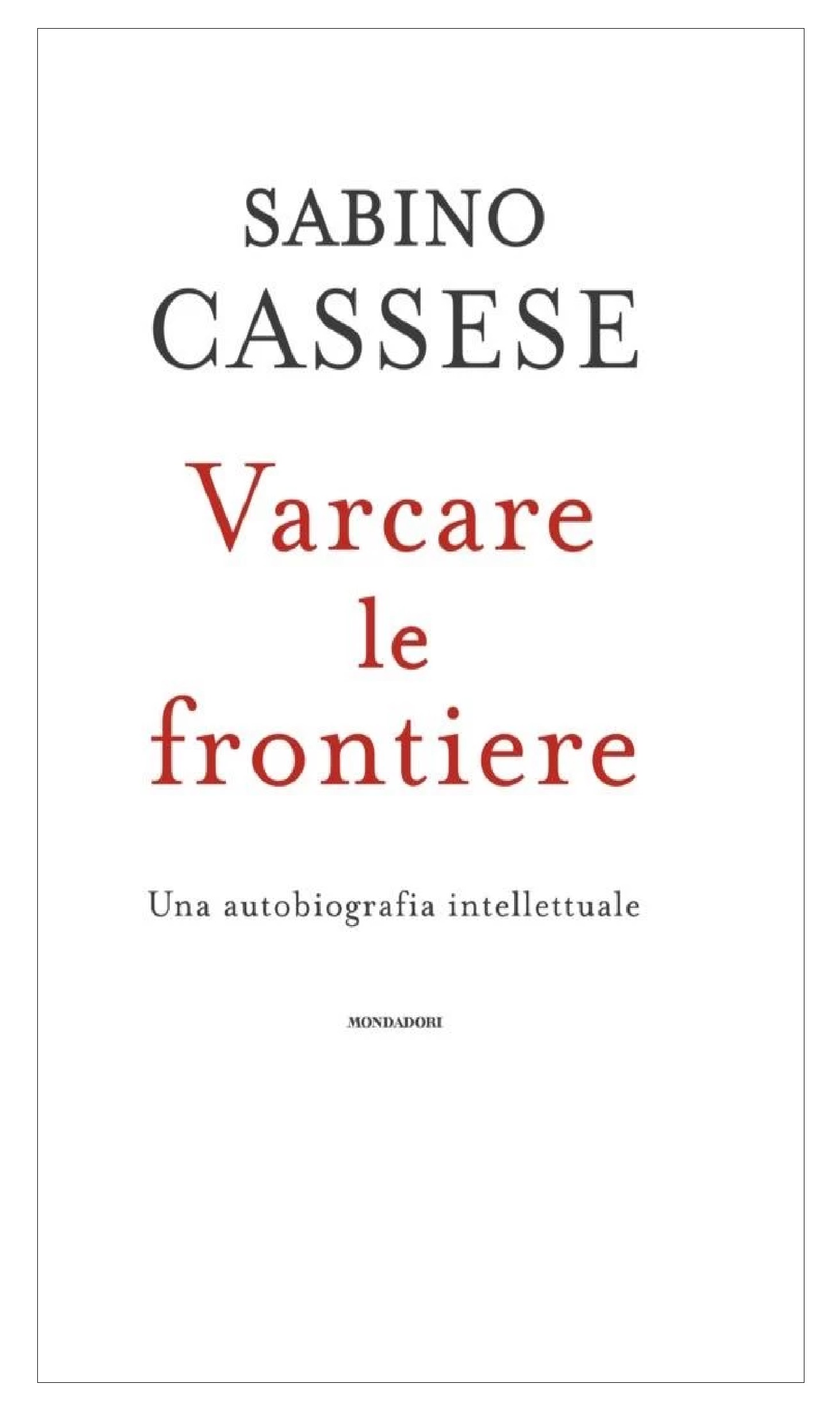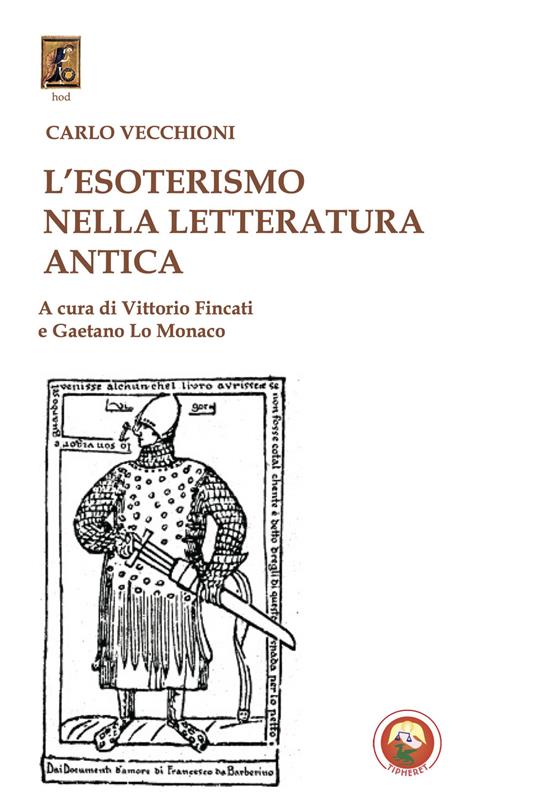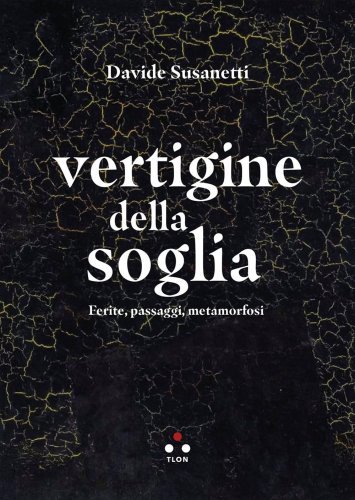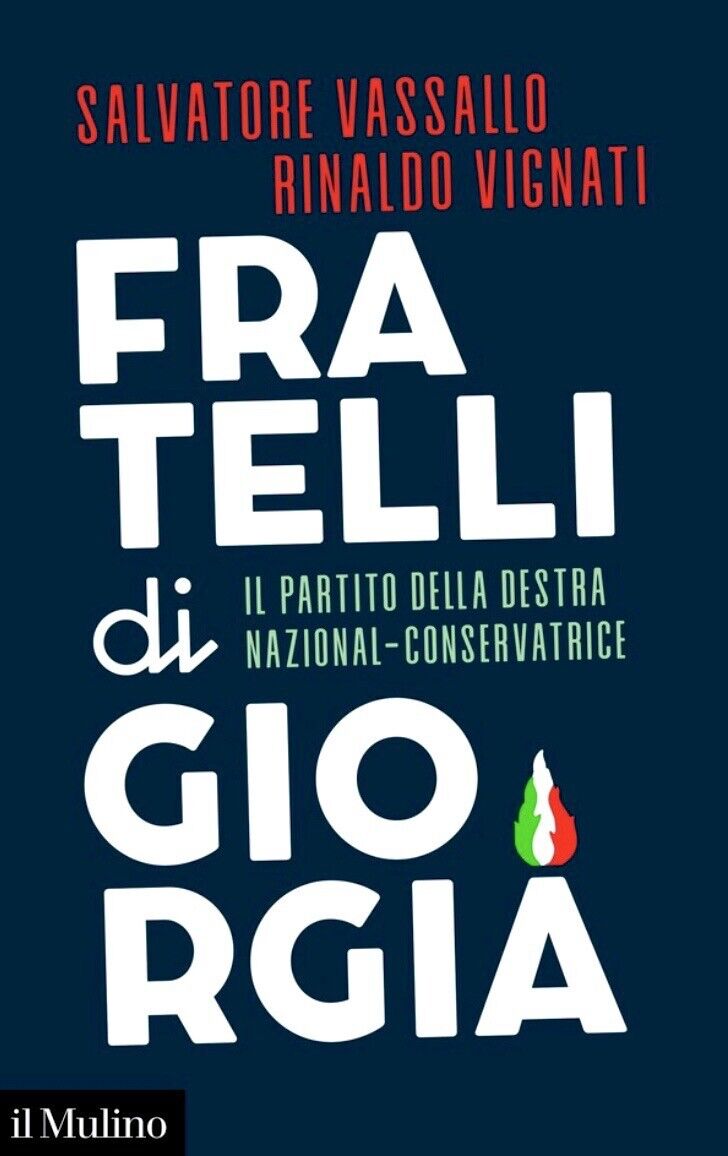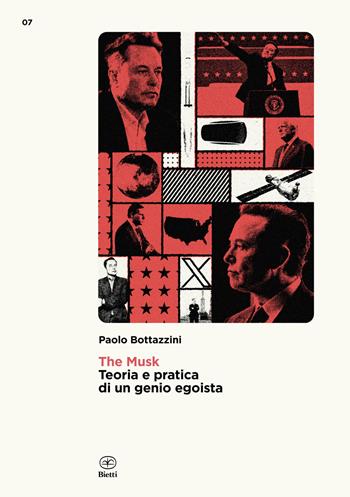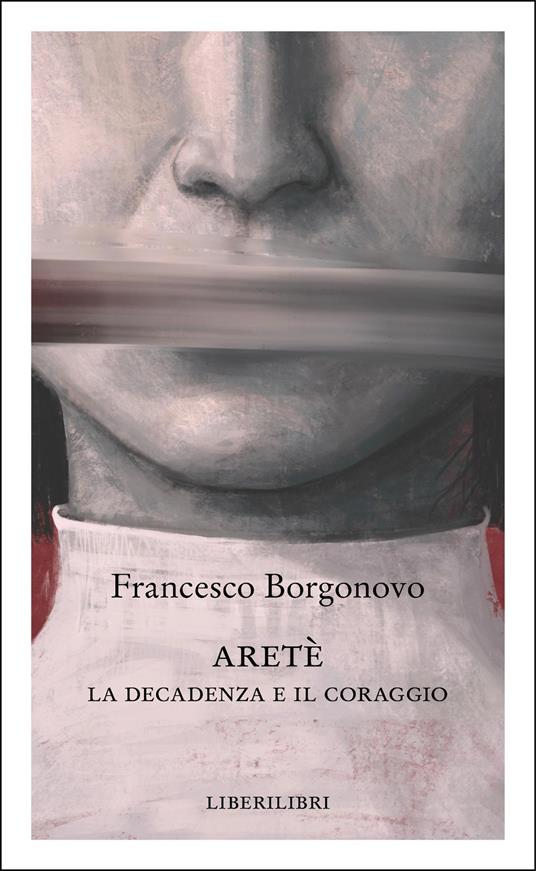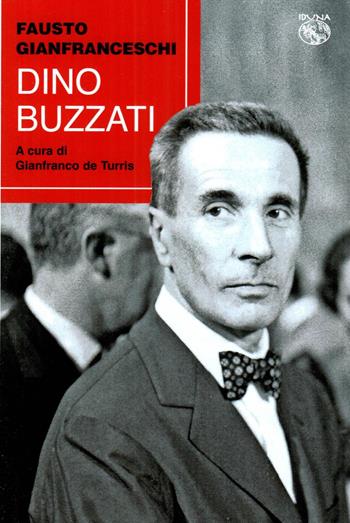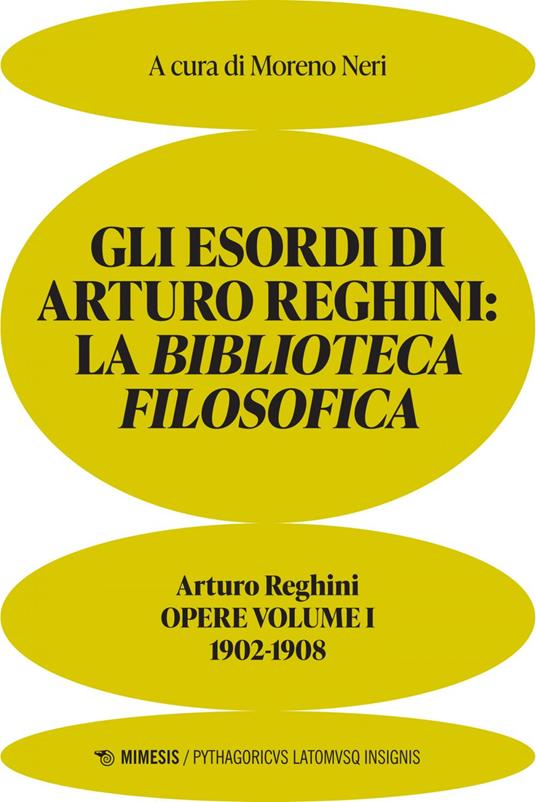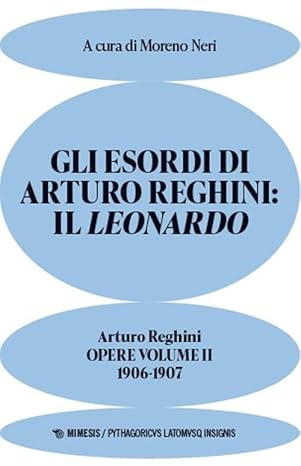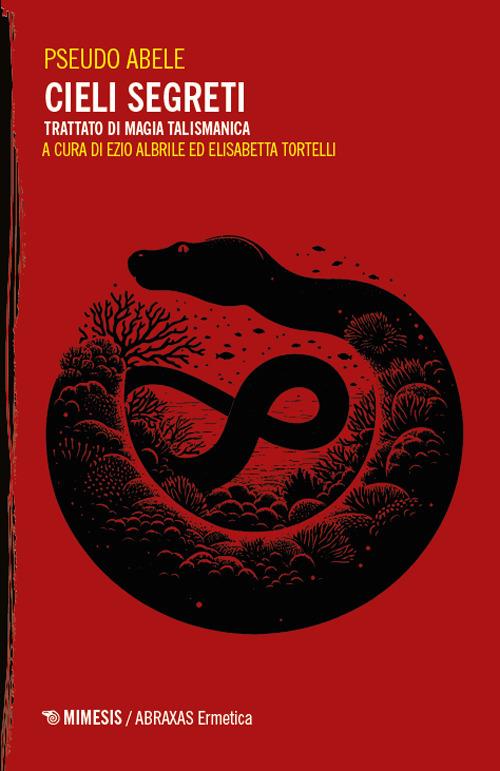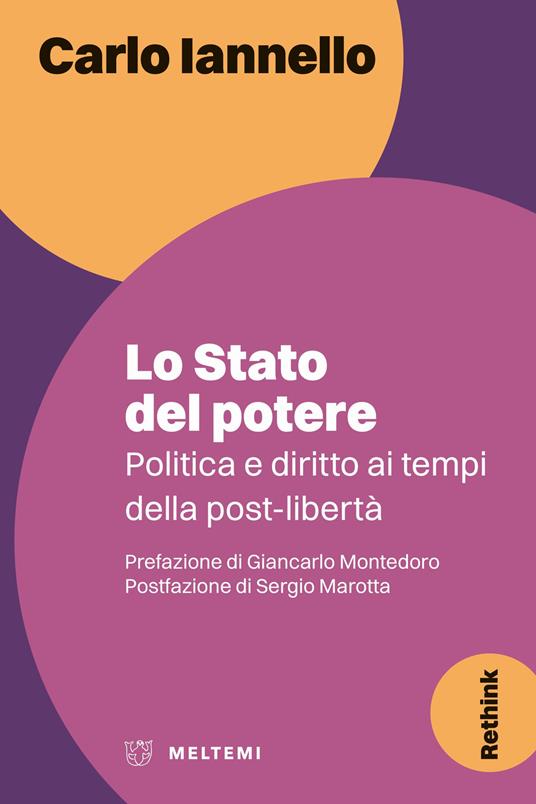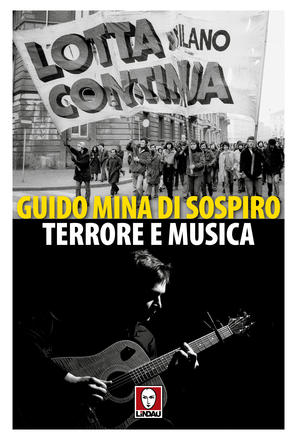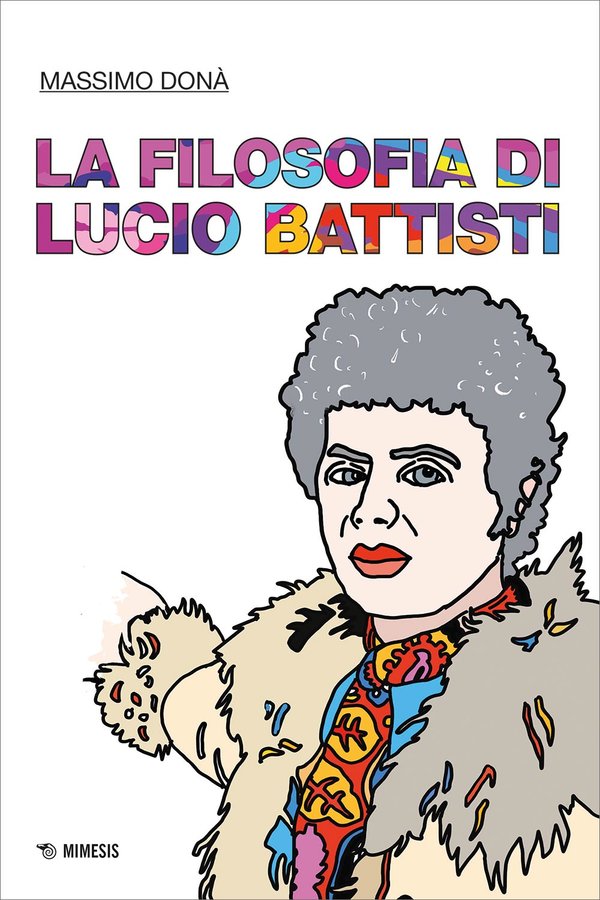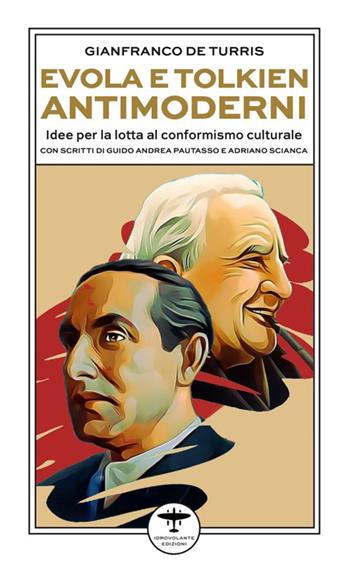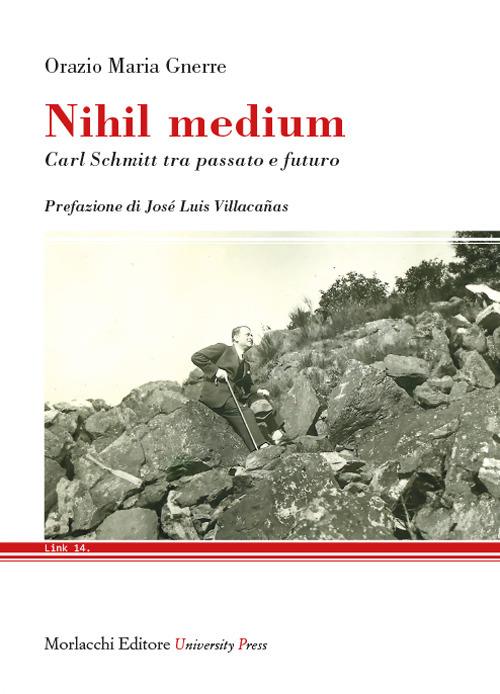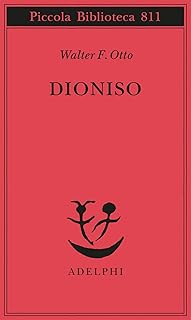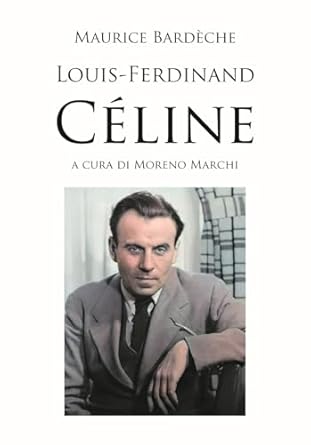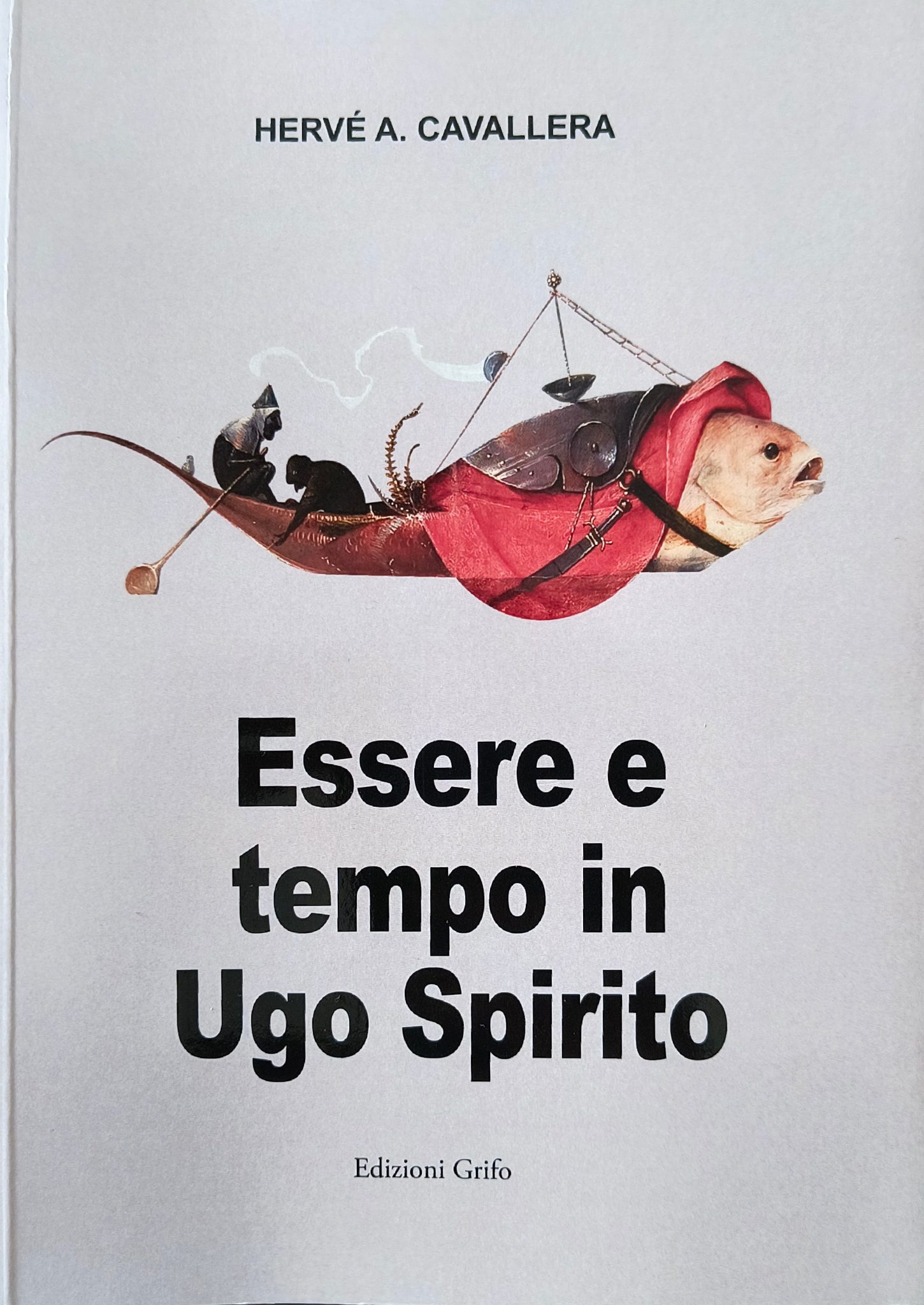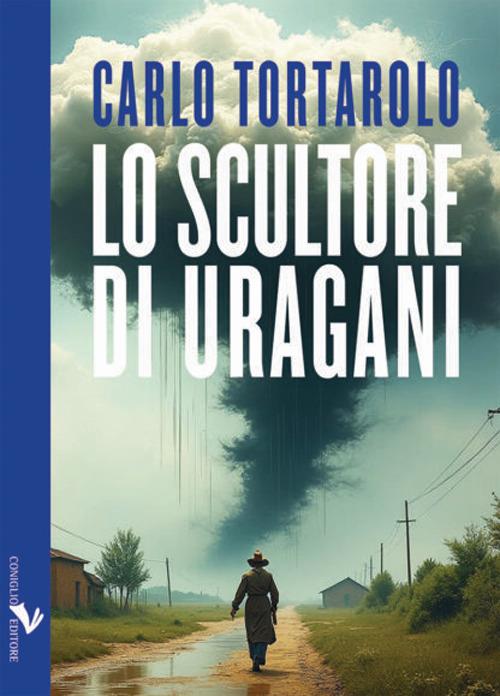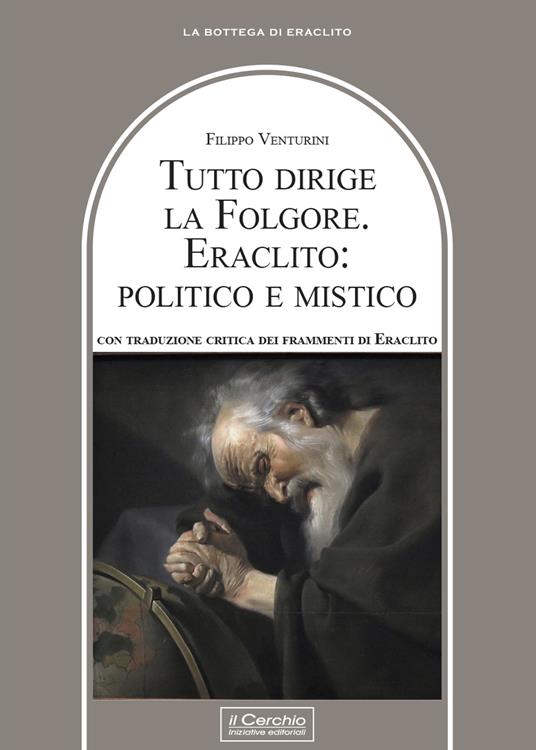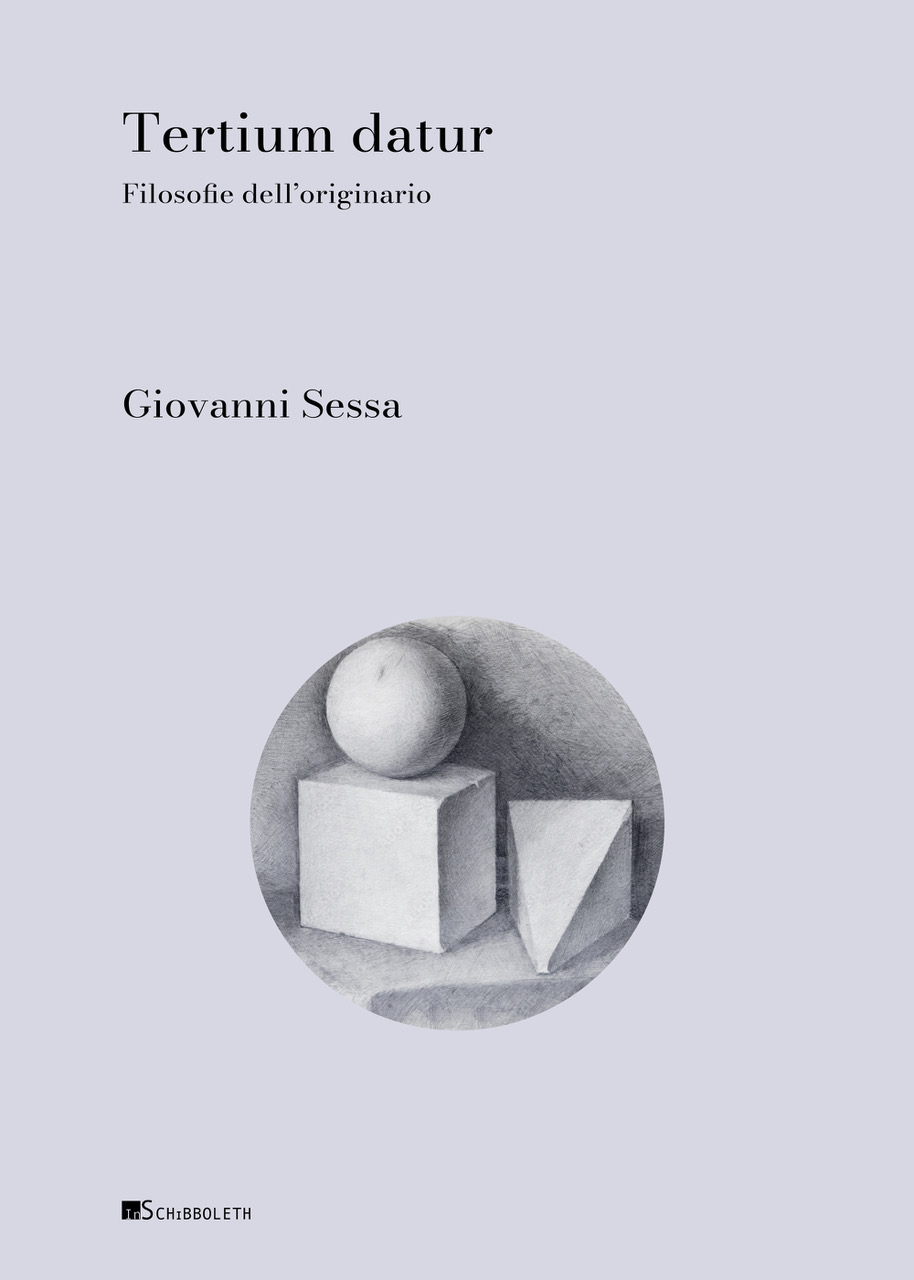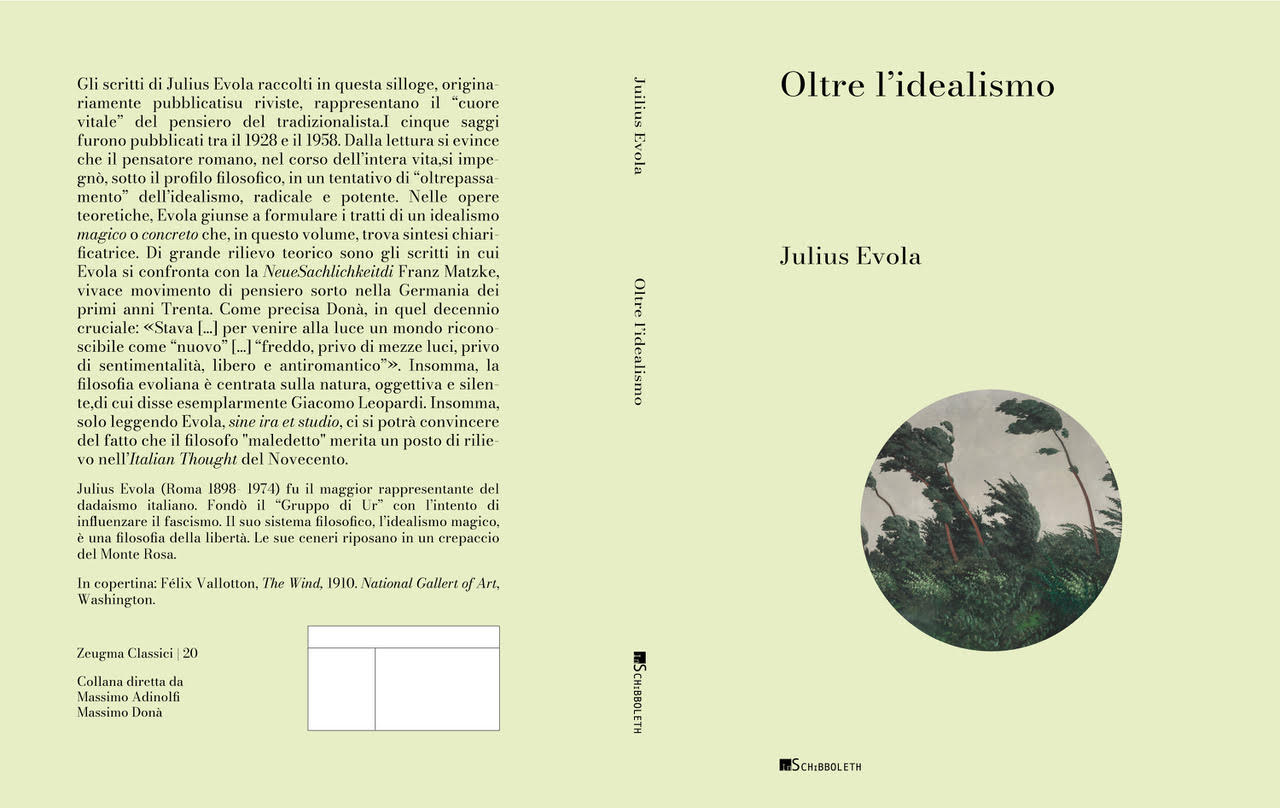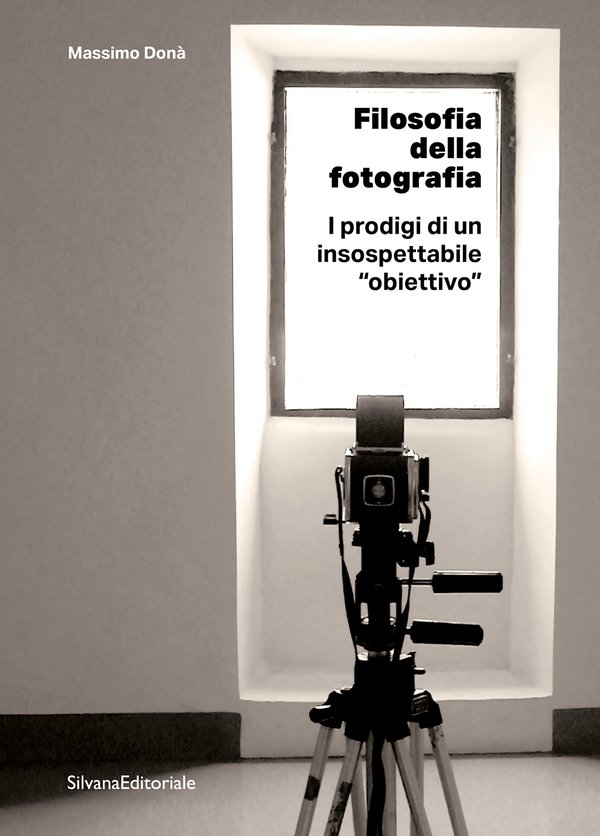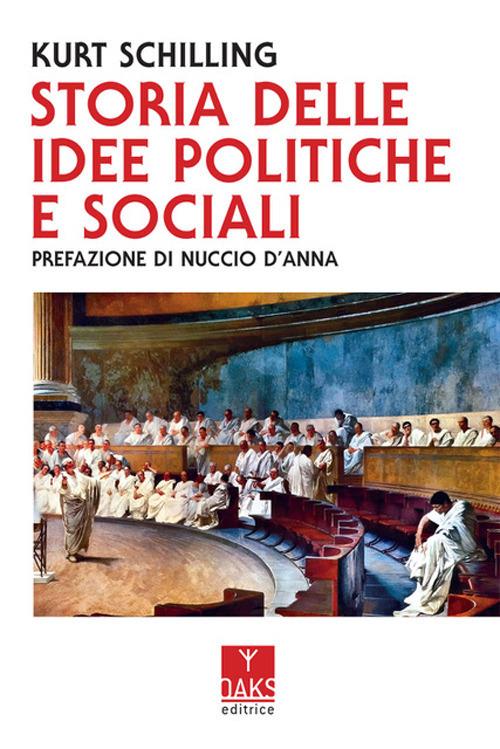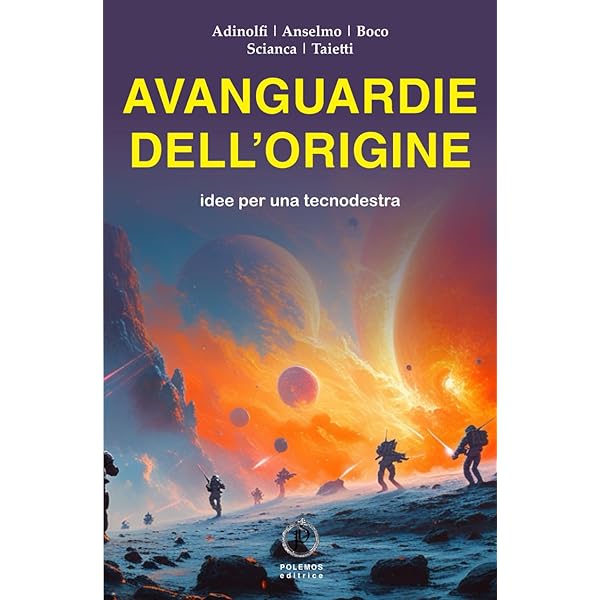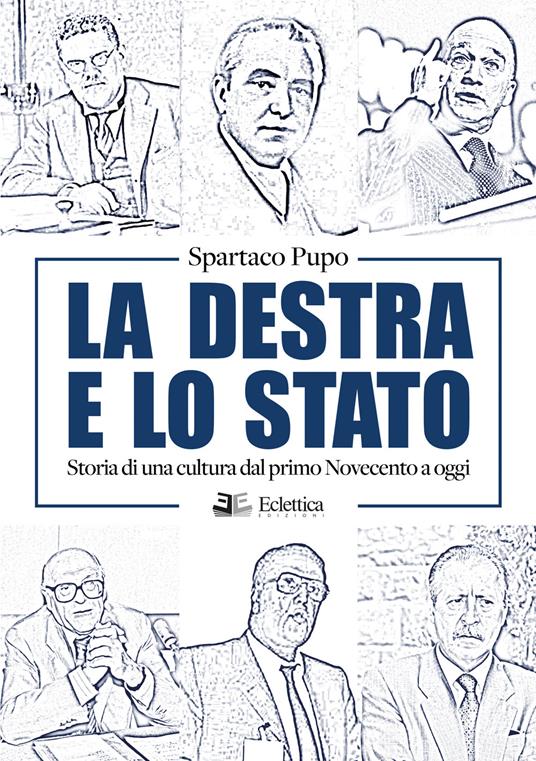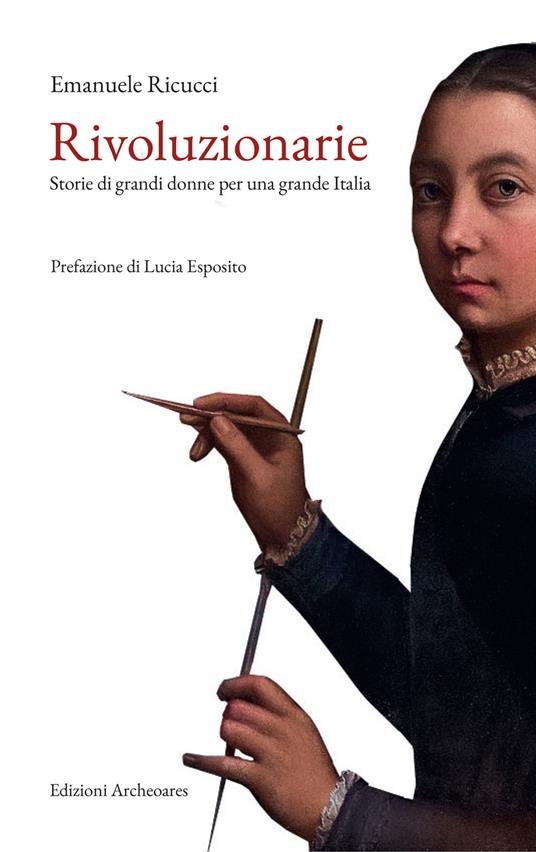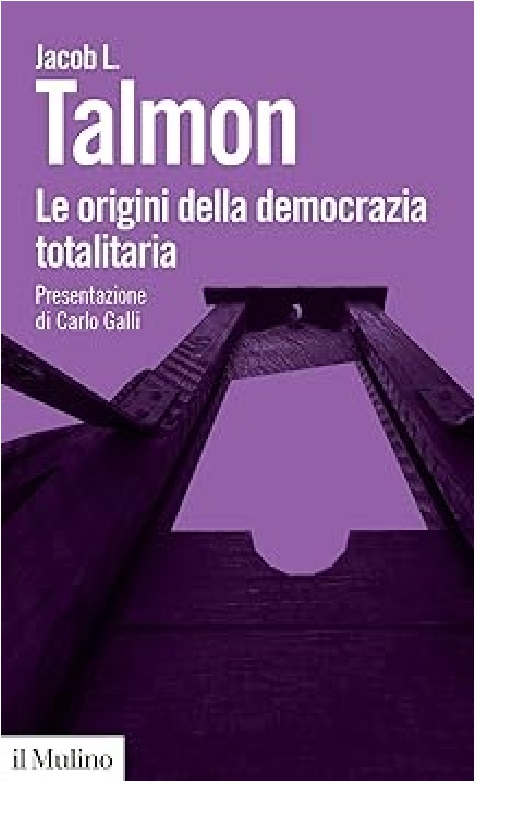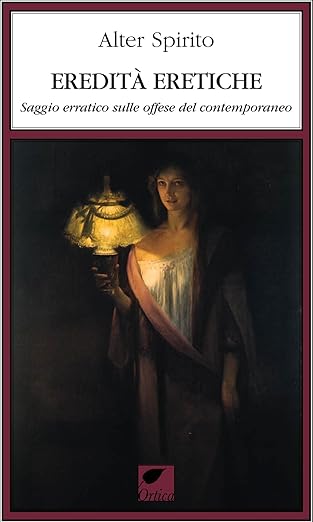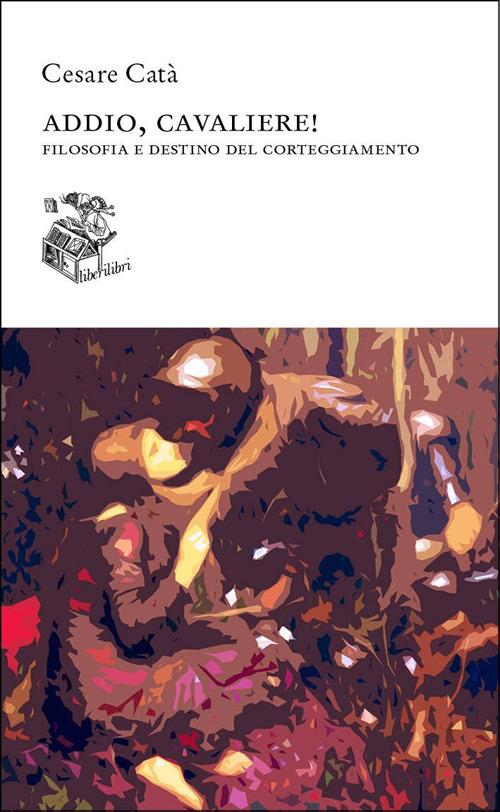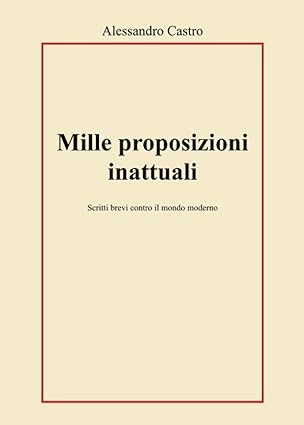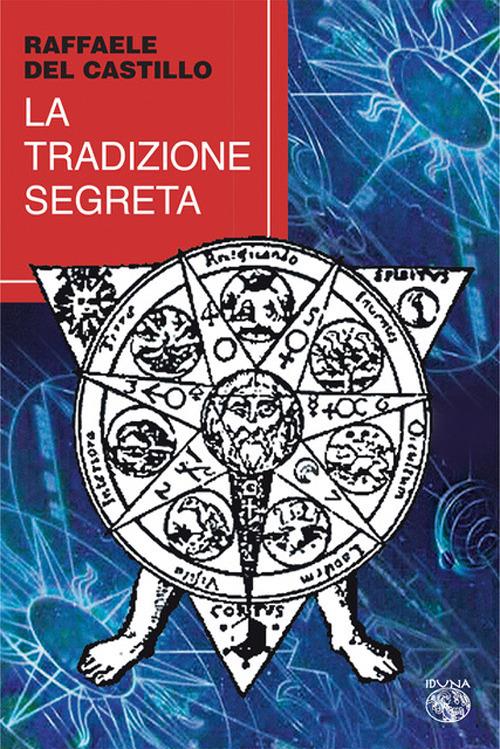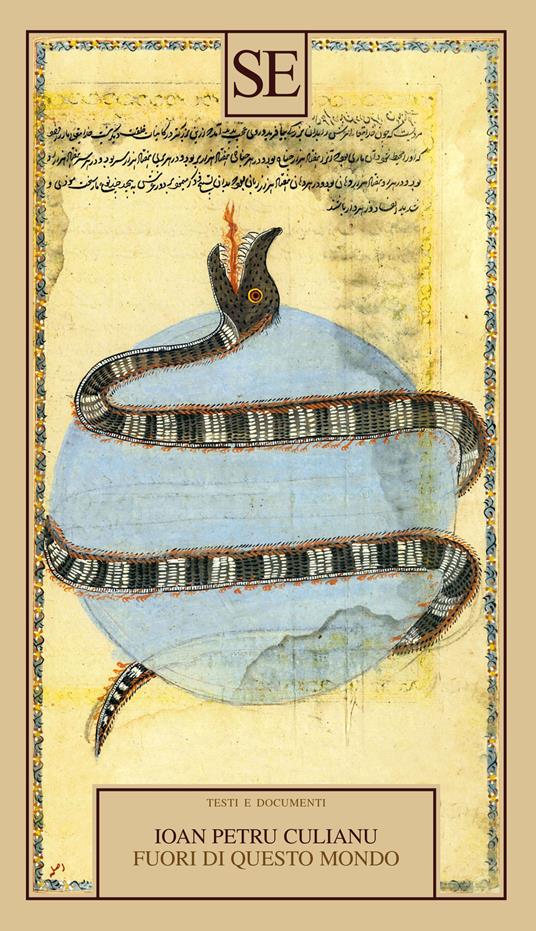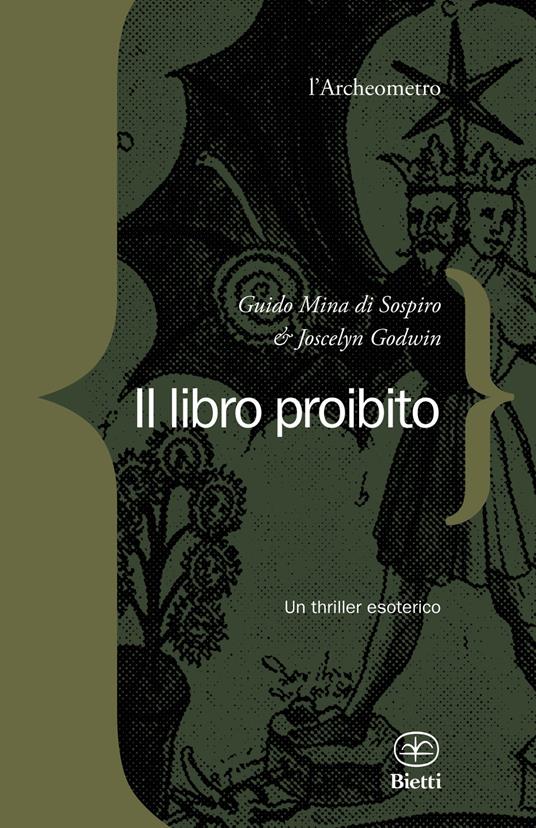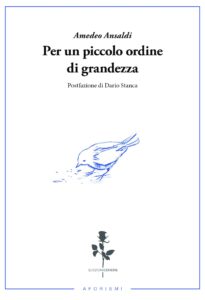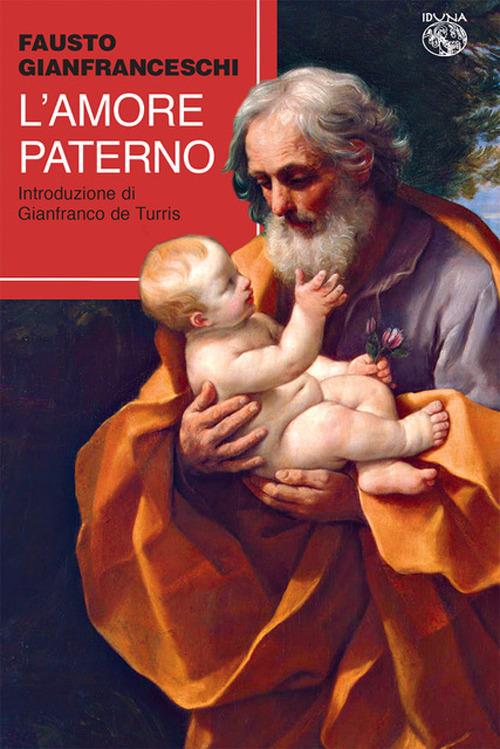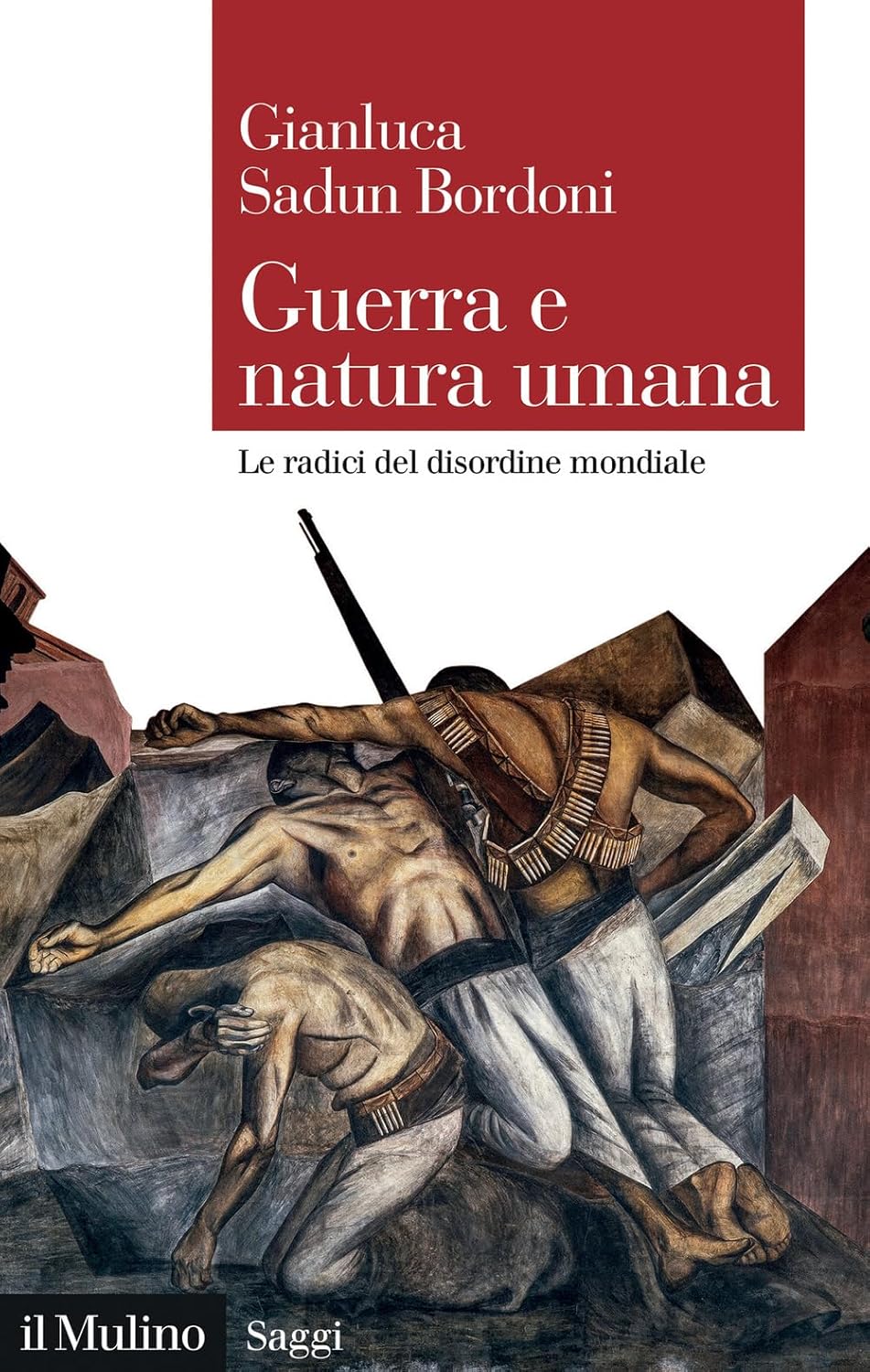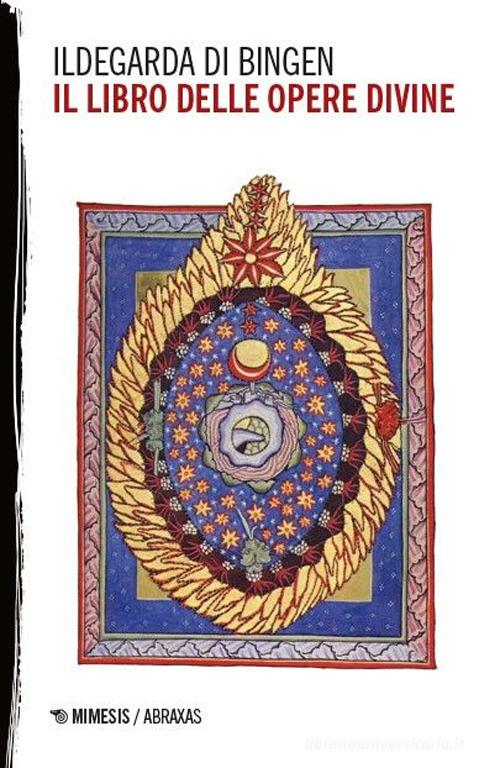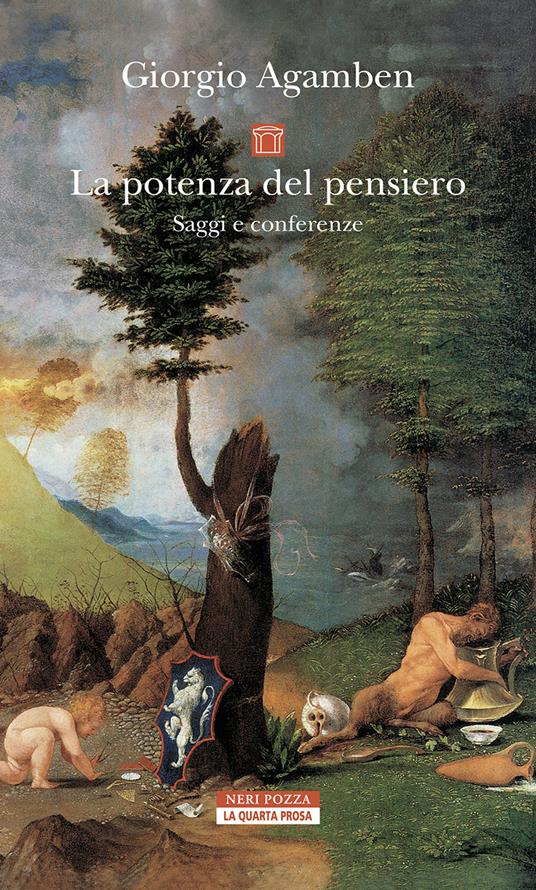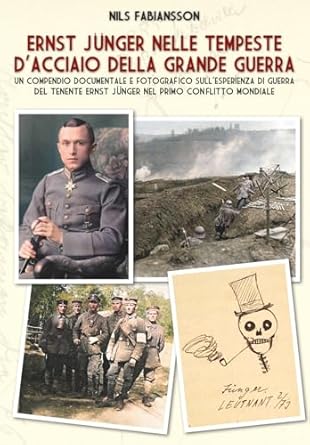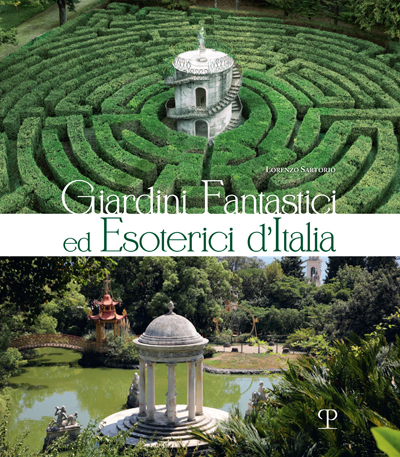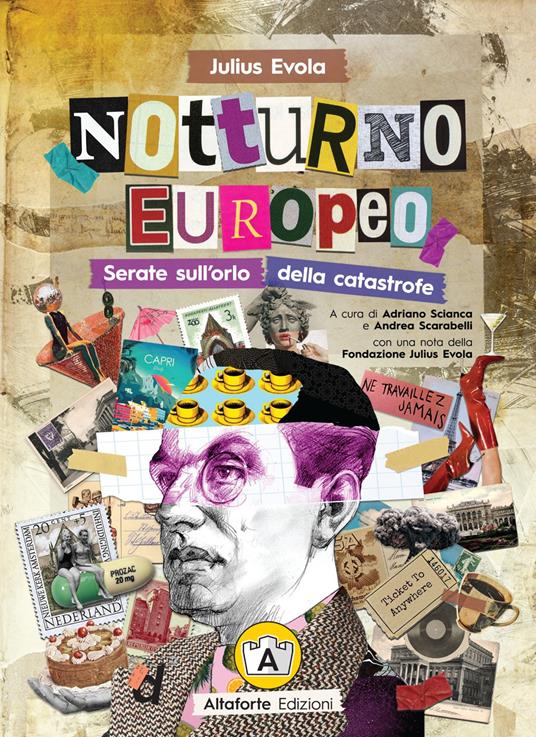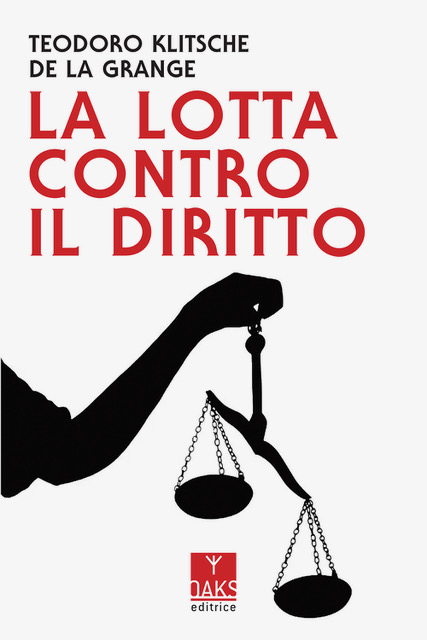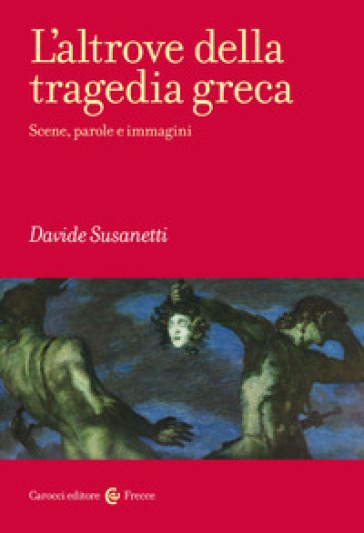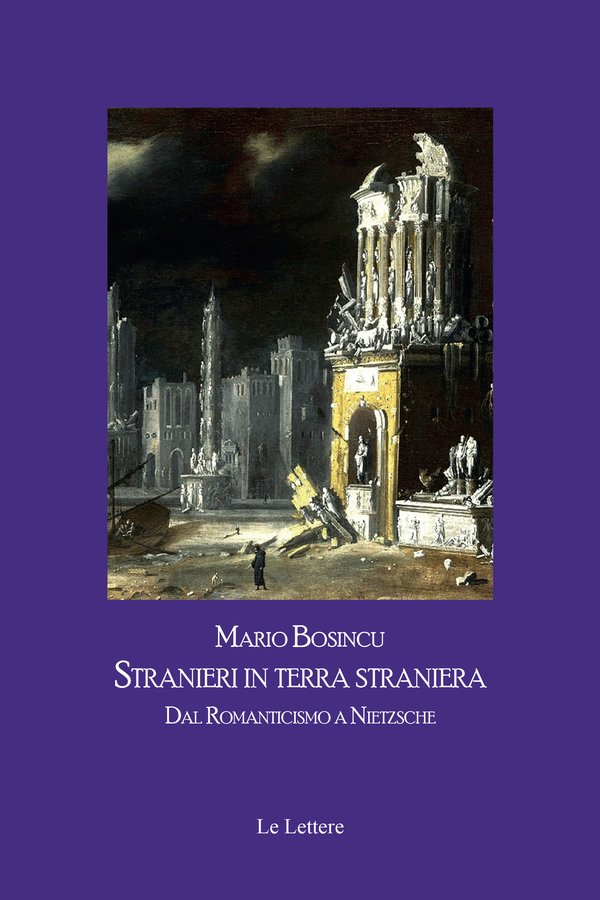"Scuola Romana di Filosofia politica"
è diretta da
Giovanni Sessa
La S.R.F.P. fondata, a suo tempo, da Gian Franco Lami ed Emiliano Di Terlizzi, docenti alla “Sapienza”, è oggi un forum critico di filosofia e metapolitica.
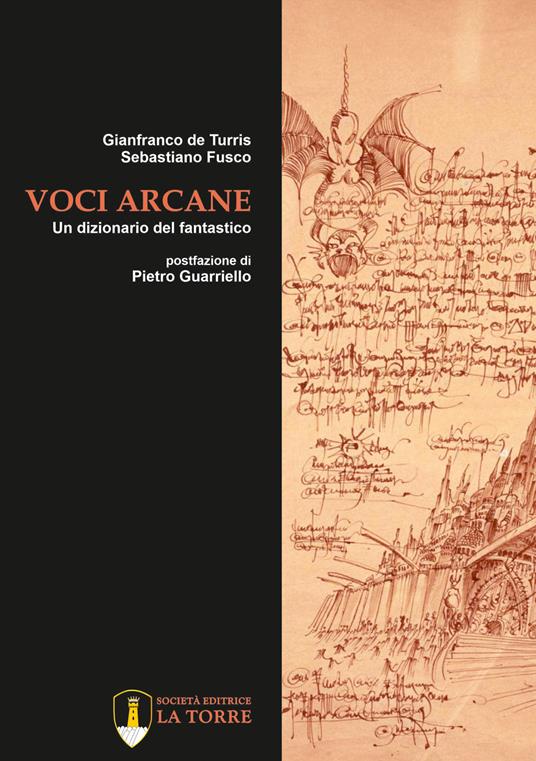
"Voci Arcane"- Il dizionario del fantastico di
- de Turris e Fusco
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Nel 1969 e nel 1971 comparvero nel catalogo dell’editore Sugar, della quale allora era direttore Massimo Pini, due significativi volumi enciclopedici intitolati Arcana, dedicati a “il meraviglioso, l’erotico, il surreale, il nero, l’insolito”. Il primo volume si occupava di tali contesti inusuali nell’ambito letterario, il secondo nell’ambito delle arti figurative. Si tratta di un vero e proprio dizionario dell’insolito e del fantastico le cui voci furono scritte da noti studiosi di tale generi letterari e pittorici. Non potevano mancare nel novero degli autori, Gianfranco de Turris e Sebastiano Fusco. Entrambi giovanissimi, erano animati dall’intenzione di rinnovare nel profondo l’esegetica dominante nelle patrie lettere, che riduceva fantasy e fantascienza a espressioni creative d’evasione, a forme espressive “marginali”. Per i due volumi, de Turris e Fusco composero a quattro mani un’ottantina di voci, ma ne furono effettivamente pubblicate sessantacinque, alcune delle quali in modalità parziale. La società editrice La Torre ha da poco raccolto in volume questi scritti del “fantastico duo”. Ci riferiamo a, Voci Arcane. Un dizionario del fantastico, arricchito dalla contestualizzante postfazione di Pietro Guarriello (per ordini: info@editricelatorre.it). In esso, laddove possibile, sono state ripristinati nella loro integrità i contributi dei due autori.
- ...
- Il libro è di godibilissima lettura, impreziosito da un apparato iconografico composto da ritratti fotografici degli autori di cui, di volta in volta si tratta, e da eleganti illustrazioni. Un’opera preziosa anche sotto il profilo editoriale, quindi, della quale consigliamo vivamente la lettura, alla luce di questa constatazione di Guarriello: «Recuperare queste “voci” nella loro forma originaria, significa rendere omaggio a due pionieri che continuano a fare scuola, ma anche e soprattutto riscoprire le fondamenta su cui si è edificata gran parte della moderna esegesi del fantastico nel nostro paese» (p. 402). De Turris e Fusco scrivendo le “voci” si sono fatti latori di un’ermeneutica innovativa, “neo-simbolica”, centrata sul mito, aperta alla pluridisciplinarità, alla psicologia del profondo e ai contributi forniti in tema dalla storia delle religioni e dal pensiero di Tradizione. Di ogni autore, i due intellettuali ricostruiscono, con acribia investigativa inconsueta, tanto gli aspetti biografici più rilevanti e la bibliografia, senza trascurare il senso profondo, in alcuni casi riposto, della loro opera. Tale rigore critico è dedicato tanto agli autori più noti, tra essi Tolkien e Lovecraft, quanto ai meno noti al grande pubblico: «Ogni “voce” è un piccolo saggio compiuto» (p. 409), si sostiene nella postfazione.
- ...
- Il saggio più ampio è riservato a Lovecraft. Si tratta di un’analisi attenta del “materialismo cosmico” del solitario di Providence, espressione filosofica del tragismo che sta alla base della sua narrativa, produttore dell’“orrore cosmico” nel quale l’uomo vive, il più delle volte inconsapevolmente. Si badi, la “materia” della quale dice Lovecraft, nulla ha a che fare con la materia meramente quantitativa della modernità, in quanto essa è “animata”. L’orrore è il prodotto della: «sospensione […] di quelle leggi fisse della Natura che sono la nostra unica salvaguardia contro gli assalti del caos» (p. 411). Oltre il mondo staticizzato dai concetti e dalla scienza, vige la realtà dell’impossibile, che irrompe all’improvviso nelle nostre esistenze. De Turris e Fusco, a proposito di Tolkien, la cui opera principale nel 1969 non era stata ancora pubblicata in Italia, ricostruiscono la lunga gestazione de, Il Signore degli anelli. In essa, il docente di Oxford: «ha dato a ogni personaggio, a ogni luogo, una sua credibilità, creando dal nulla una “storia” per ognuno di essi, una vera “fanta-mitologia”» (p. 262). L’intera produzione narrativa tolkieniana è “fantasia eroica”, fantasia “mito-poietica”.
- ...
- Medesima visione del mondo è rilevabile nelle pagine di Bradbury. Questi era dotato di uno stile particolare che mirava, in modalità fiabesca, all’«umanizzazione del futuro dell’uomo» (p. 53). Gli occhi dello scrittore guardarono il mondo in modalità infantile, attraverso la meraviglia propria dell’infanzia, in un rapporto immediato, di vera e propria immedesimazione con la vita profonda delle cose. Fahrenheit 451: «dimostra come il suo pessimismo si risolva poi in una posizione fondamentalmente ottimistica nei confronti dell’uomo del futuro ma di decisa condanna verso tutto quanto ne comprometta l’individualità» (p. 57). Anche Borges, ricordano i due autori, colse nella lingua lo strumento atto a concedere momentanea forma al caos del mondo: «gran parte della narrativa di Borges sembra avere il fine unico di corrodere i fili maestri del tessuto connettivo del continuum spazio-temporale» (p. 46), al fine di mostrare la possibilità dell’impossibile. L’uomo, come la realtà, è doppio, ambiguo e, solo nella pluralità e nella dimensione temporale gli è dato di attingere la propria identità. Ma, si badi: «il sogno si stempera nel reale e non è distinguibile alcuna linea di divisione fra i due domini» (p. 48). Per questo, come seppe il nostro Leopardi, le cose non sono mai quello che dicono di essere, mera datità, positività, ma sono abitate da un non, da un principio negativo.
- ...
- Della Seconda parte del libro, dedicata alle arti figurative, ci limitiamo a segnalare, tra gli altri, i “medaglioni” riservati a Buzzati e Escher. Lo scrittore bellunese ebbe, da sempre, un’evidente propensione per la figuratività. Ciò è rilevabile dal suo, Poema a Fumetti del 1969. I suoi disegni testimoniano la ferma volontà di evadere dalla realtà sorda e grigia, messa in scena anche nelle opere letterarie. Il fumetto di Buzzati si pone oltre la pop art, in quanto ha valenza liberatoria, pur non avendo la pretesa di: «raggiungere […] l’elaborazione di un “messaggio” compiuto e articolato» (p. 274). Escher, in particolare nell’incisione in legno, Tre sfere, non avverte il bisogno di inventare altri mondi: «per suggerire il senso dell’illusorietà del reale» (p. 299). Egli ha contezza che l’altrove è sempre qui, ci abita.
- ...
- Voci Arcane mostra che de Turris e Fusco sono intellettuali che: «hanno dedicato la loro vita a esplorare e a difendere un Immaginario che consideravano non una fuga dalla realtà, ma uno strumento per comprenderla più a fondo» (p. 415).
Gianfranco de Turris-Sebastiano Fusco, Voci Arcane. Un dizionario del fantastico, postfazione di Pietro Guarriello, pp. 416, euro 24,50.
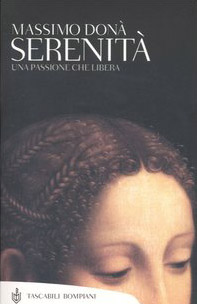
Una passione che libera- Massimo Donà
- e la
- serenità
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
In queste brevi note ci occuperemo di un libro importante, uscito già da qualche anno, che abbiamo letto per la seconda volta. Ci riferiamo al volume del filosofo e musicista Massimo Donà, Serenità. Una passione che libera, comparso nel catalogo dell’editore Bompiani e ancora acquistabile nelle librerie on-line. La crucialità delle sue pagine è data, in prima istanza, dal mostrare come l’iter dell’autore non abbia tratto meramente teoretico, non si riduca a ennesima riproposizione sistematica del primato degli universali. Al contrario, la sua visione del mondo rinvia a un ethos, a una possibile modalità di ex-sistenza pensata in termini di singolarità. In questo senso, quella di Donà, è filosofia in grado di parlare agli uomini della post-modernità, agli “abitatori del tempo” e dell’età della Tecnica, in modalità rasserenante, ponendosi oltre le logiche dell’esclusione che distinguono radicalmente l’essere dal nulla, l’esistenza dall’essenza, l’uno dai molti.- ...
- Come si evince dal titolo, Donà si interroga sull’aspirazione alla serenità che, da sempre, ha connotato la vita dei mortali e sulla quale si è interrogata, a più riprese, la tradizione filosofica. Ogni uomo, infatti, vorrebbe essere sereno, vorrebbe beneficiare di uno stato di appagata conciliazione con sé e con le cose del mondo. Il problema è che, a muovere almeno dalla filosofia classica platonico-aristotelica, la vita è stata pensata alla luce delle idee, degli universali: «Platone sapeva cosa poteva rendere buona ogni cosa» (p. 24), riteneva che il Bene fosse l’Uno, un’entità assolutamente astratta, in grado di unificare il molteplice. L’uomo è un animale che, oltre a possedere il lógos, è animato da passioni. Tra queste passioni va annoverata quella per la conoscenza, per l’astratto: «quella capacità di connettere, di legare insieme, senza la quale mai potremmo rinvenire fattori comuni […] tutti quelli che la filosofia chiama gli universali» (p. 26). Il grande Ateniese seppe anche (Settima lettera) che la passione conoscitiva dell’autentico filo-sofo tende a spingersi, attraverso un processo meta-intellettuale, oltre le barriere statuite dal logo-centrismo, al fine di cogliere, in una sorta di epopteia, l’effettivo darsi dell’origine solo nella cosa singolare. Platone sostenne, inoltre, che il nous avrebbe dovuto agire sulle passioni evitandone gli eccessi. Da allora, l’Occidente fece della ragione uno strumento etico, in forza della quale avrebbe tentato di: «costruire una vera e propria geometria delle passioni» (p. 28). Il filosofare è stato così inteso quale strumento terapeutico, otre che diagnostico, del “mal di vivere”.
- ...
- In realtà, siamo stimolati a patire tanto dall’esterno, dalle cose del mondo, quanto dall’interno: «Nella passione ognuno di noi fa […] esperienza di una “passività” che viene […] avvertita come negazione» (p. 29) della nostra autonomia. Nei desideri sperimentiamo di essere mancanti di qualcosa, a essa aneliamo in un movimento incessante. Il desiderio: «Ci fa prendere coscienza del fatto che siamo finiti, ma che potremmo non esserlo - per il fatto stesso che tentiamo continuamente di superare tale condizione» (p. 30). Ogni volta che, attraverso un oggetto finito, riusciamo a soddisfare un desiderio, torniamo tra le braccia del dolore o della noia. Ben lo seppero Schopenhauer, Leopardi e Michelstaedter. Per tale ragione, Donà, con acribia esegetica non comune, discute con persuasività di accenti le principali vie alla serenità proposte dai filosofi, dall’antichità alla modernità. Egli muove da una convinzione di fondo decisamente anti dualista. Tutti noi, per il fatto di aver contezza della finitudine che ci abita, a ben vedere nella soddisfazione del desiderio: «non possiamo fare a meno di esperire la nostra insuperabile e originaria infinitudine» (p. 31). In che senso siamo infiniti? Di certo, non in termini meramente quantitativi: tale idea dell’infinito è stata inaugurata in Grecia nel V secolo a. C. ed è stata ereditata dal Ge-stell tecnico-scientifico. Essa è centrata sulla distinzione di essenza ed esistenza, di soggetto ed oggetto. Per uscire da tale gabbia concettuale è, come comprese Colli, necessario abbandonare la struttura meramente rappresentativa del conoscere, oltre la quale si scopre che l’origine si dice solo nei molti, nella vissutezza. Tale principio, stante la lezione di Emo, è un non, una negazione che si positivizza e vive nelle perpetue metamorfosi della physis: «Se questa è la cornice ontologica e strutturale dell’umana esistenza, allora il non-essere costituisce per ognuno di noi quanto può essere sempre guadagnato» (p. 33) nel presente.
- ...
- Il filosofo veneziano inizia la propria disamina a muovere dalla esegesi dello stoicismo greco e romano e dell’epicureismo: «Mentre per gli Epicurei è solo il vizio a condurre alla non-verità e al dolore» (p. 48), a non farci essere sereni, gli stoici si fecero latori di un intellettualismo etico di matrice socratica, che, con Seneca, pervenne alla consapevolezza che la tranquillità d’animo la si impara e sperimenta solo di fronte alla morte. L’inquietudo nella quale viviamo è data dalla conoscenza. Questo ci dicono le Sacre Scritture, le quali posero in termini teleologici, in termini di scopo, il conseguimento della serenità. Solo la staticità della morte, placherà il “movimento” insoddisfatto della vita, il suo mai “stare”. La Redenzione concederà all’uomo la pace serena dell’inizio edenico, mai sperimentabile nella concretezza dell’esistere. La fede è risoluzione: credo quia ad absurdum. Gli utopismi politici, immanentizzazione del fine della storia cristiano, non faranno che rinviare a un futuro incerto tale compimento, da perseguirsi anche attraverso l’uso della violenza. Donà lo mostra, in tutta evidenza, nella seconda parte del volume, articolata in sette densi capitoli. L’autore si interroga, inoltre, sul contributo fornito dall’umanesimo tragico italiano, intrattenendosi su Petrarca e Leon Battista Alberti. Discute, in sequela di tale prospettiva, le posizioni espresse da Cartesio, Spinoza e Leibniz, ma anche le significative intuizioni di Nietzsche, Proust e Kafka, San Francesco e Balzac, e sull’impossibile divenire ciò che si è tematizzato da Fichte.
- ...
- La serenità per Donà ha a che fare con un’impossibile. Essa in realtà altro non è che tensione esistenziale atta a concedere “spazio” alle nostre vite: «spazio, sì, questo vorremmo tutti. Spazio per poter respirare sereni. Spazio che ci liberi dagli affanni che offuscano la vista […] che rendono troppo “oggettuale” il chaos originario» (p. 230). Donà ci dice che l’aporia vive nella vita, non è data dall’inciampo della morte. Per questo la “verità” ha tratto “errante”, nomadico. Tale visione è aliena dal contemptus mundi delle escatologie religiose e politiche. È visione euforizzante, rasserenante. È propria di quanti abbiano contezza di essere appesi a un principio infondato e, per questo, capaci di sintonia con il perpetuo incipit vita nova. Una serena inquietudo, un’indeterminatezza che: «non dice nulla di misterioso, di là dall’esistere delle quotidiane fatiche cui tutti ci sottoponiamo per raggiungerla» (p. 231).
Massimo Donà, Serenità. Una passione che libera, Bompiani, pp. 236, euro 8,00.
- SORTEGGIO SÌ, SORTEGGIO NO (2.0)
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Tra i tanti argomenti adotti contro la riforma Nordio sull’ordinamento della giustizia (e sul sorteggio dei componenti del CSM), uno è particolarmente interessante, laddove si afferma che i magistrati sorteggiati non avrebbero capacità ed attitudini per contrastare i condizionamenti politici, specie quelli provenienti dai sorteggiati non-togati. L’argomento ha il difetto da un lato di provare troppo, dall’altro di non considerare uno dei principali caratteri dello Stato moderno.
- ...
- Quanto al primo aspetto se è vero che l’elezione è (anche) un modo di scegliere i migliori (nel senso dei più adatti) è anche vero che principio fondamentale della democrazia è l’accesso di tutti i cittadini alla funzione pubblica. E così anche all’elettorato passivo agli organi costituzionali. Molti hanno ironizzato sulla possibilità che così un ignorante (o un demente, o un inadatto in genere) potrebbe accedere agli organi e uffici politici più importanti della Repubblica (Parlamento, Governo, Presidenza della Repubblica): ma è un rischio che una democrazia deve correre, se vuole essere tale. D’altra parte la storia è piena di governanti, scelti con qualsiasi sistema (la nascita, l’adozione, l’elezione, e così via) che avevano i medesimi difetti di coloro (pochi) scelti con il sorteggio. Ad applicare coerentemente l’argomento criticato si dovrebbe pre-selezionare i candidati, magari prevedendo dei requisiti severi limitanti l’accesso e restringere a quelli la lista degli eleggibili. Superando poi il dubbio che, se questi requisiti dovessero essere determinati non da criteri oggettivi (anzianità, reddito, nascita) ma dal giudizio di un ufficio, questo sarebbe stato imparziale e opportuno. Quindi l’inconveniente criticato è a maggior ragione (dato il maggior potere) pertinente anche agli eletti agli organi costituzionali. E la scelta dei “migliori” – sottintesa all’elezione – può ridurre il rischio, ma non eliminarlo.
- ...
- Sotto un secondo aspetto (non meno importante) l’argomento in esame presta il fianco ad una critica. Scriveva Max Weber che uno dei caratteri peculiari della burocrazia moderna è il possesso del “sapere specializzato”, cioè «acquisito mediante istruzione specifica e cioè “tecnico” nel senso vasto della parola». Nel caso, tutti i componenti del CSM devono essere esperti di diritto quali giudici, avvocati o comunque professori universitari di materie giuridiche. Al contrario degli organi costituzionali “politici” in cui l’accesso è illimitato; questo lo è (anche e soprattutto) per garantire la padronanza della materia e dall’altro per escludere o limitare drasticamente, come è opportuno, il controllo del vertice politico (non specializzato) sull’insieme dei magistrati; al contrario della regola di ogni ente, dai Ministeri ai consigli municipali, dove un vertice politico (non professionale) indirizza e controlla la burocrazia (professionale). Nella specie la larga maggioranza del CSM è sorteggiato tra i funzionari: quindi il vertice non è politico.
- ...
- Tuttavia i critici delle riforme sostengono che i sorteggiati tra i funzionarti non garantirebbero di essere in grado di fronteggiare il drappello minoritario dei “laici”. Ma, a parte che non è detto che siano poco capaci, essendo degli specialisti, anzi sembra piuttosto improbabile, la ridotta capacità di gestire il potere attraverso contrapposizioni ed accordi può capitare in ogni organo collegiale, compresi quelli che contemplano la presenza di membri d’estrazione burocratica e non. E’ un rischio cui si può ovviare sopprimendo una delle due categorie. Ma se non lo si fa, si deve correre.
-
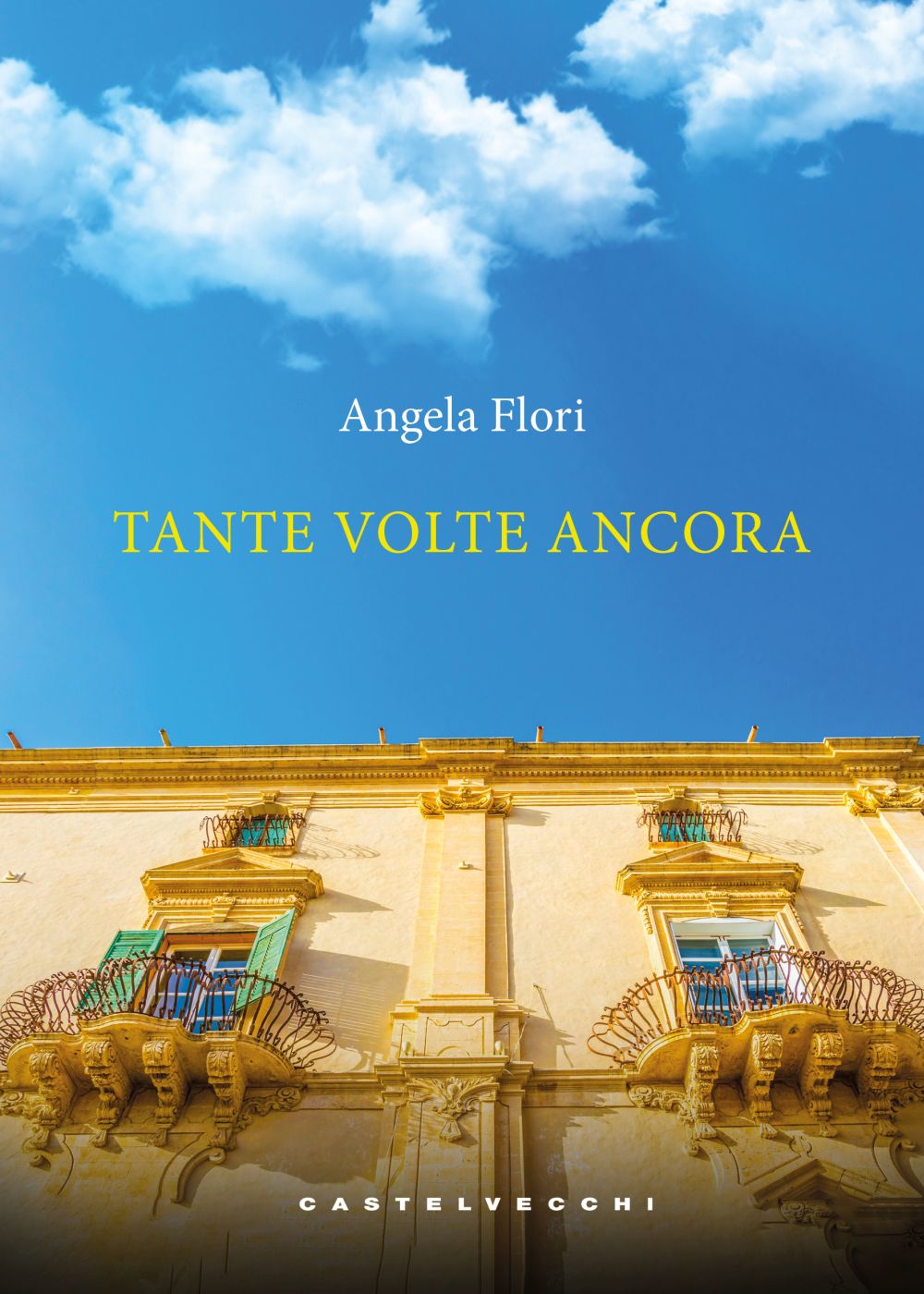
Tante volte ancora- Un romanzo di
- Angela Flori
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- È da poco nelle librerie, per i tipi di Castelvecchi, l’ultima fatica di Angela Flori. Ci riferiamo al romanzo, Tante volte ancora (per ordini: info@castelvecchieditore.com, 06/8412007). L’autrice ha alle spalle una serie considerevole di pubblicazioni dalle quali si evincono una non comune capacità di scandaglio psicologico dei personaggi e un chiaro interesse per il quotidiano, in particolare per l’intreccio, che in esso si realizza, degli eventi della grande storia con fatti che segnano le esistenze dei singoli. Tale propensione emerge, in tutta evidenza, dalle pagine di, Tante volte ancora. Si tratta, infatti, di un romanzo di memorie famigliari non solo perché al centro delle vicende narrate sta la famiglia siciliana dei Mascagni, ma anche perché alcuni personaggi sono stati pensati, per ammissione esplicita della Flori, grazie al ricordo di passioni e scelte di vita di suoi consanguinei. Per chi scrive, Tante volte ancora, è soprattutto un romanzo al femminile e sul femminile.
- ...
- Le sue pagine ci hanno confermato nella convinzione che il “gentil sesso”, per natura, è dotato di una particolare qualità esistenziale: l’innata capacità di sopportare il senso profondo, ammagliante e tragico in uno, del nostro ex-sistere, del nostro essere espressione di un principio infondato, che i Greci chiamarono dynamis, libertà-possibilità-potenza. Esso dice dell’instabilità, della precarietà, della fragilità di tutto ciò che è. Dice, inoltre, che le cose del mondo e della nostra vita, sarebbero potute andare diversamente da come sono andate, che nulla è determinato a priori. Queste pagine, dunque, sono centrate attorno alla dimensione del possibile. La protagonista, nonna Bice, ama non solo i suoi simili ma gli animali, le piante, la natura, nella quale tutto è in relazione simpatetica. L’ambientazione siciliana e mediterranea non ci pare casuale. È in tale contesto geografico che, in antico, sorse il senso della pietas, del com-patire, dell’accogliere le sofferenze proprie e altrui, con stoica serenità. Le donne amano, sono madri, esposte, per questo, al perpetuo incipit vita nova. Il nipote di Bice, l’amatissimo Luca, è l’io narrante che, attraverso ricordi personali e la lettura dei diari della nonna, ricostruisce la trama della vita della donna e quella della famiglia. La prosa è incalzante, centrata sul parlato dei protagonisti, sulla vocalità immediata del “dialetto” siciliano che, in alcuni lemmi, ha tratto onomatopeico, atto a trascrive il mouvant, il fluxus, nel quale gli eventi si danno. Il linguaggio, la parola, hanno tratto terapeutico, leniscono l’angoscia che il divenire, la malattia e la certezza della morte, inducono negli uomini. In, Tante volte ancora, è possibile ravvisare l’eco di altre testimonianze letterarie al femminile e sul femminile. Tra le altre, quelle di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg e di, Vestivamo alla marinara di Susanna Agnelli.
- ...
- Il ricordo è, nelle pagine della Flori, rispetto agli esempi citati, carico di pathos, perché Bice è donna di grandi passioni, il più delle volte, contrastate dalla madre Gisa. La passione che, fin da giovane, l’attrasse e la fece sognare, fu il teatro. Incurante delle chiacchiere del paese, dapprima, interpretò, dietro al Cristo, durante la processione del Venerdì Santo, il dramma di Maria e, successivamente, spinta dall’amore per il cinema, fuggì di casa in cerca di fortuna a Roma, dove visse di stenti al fine di procacciarsi qualche scrittura a Cinecittà. Nella Capitale incontrò i primi palpiti d’amore. Conobbe Nando, pizzicagnolo di Via Giolitti, con il quale trascorse una giornata solare, indimenticabile, a Ostia. Bice, quel giorno: «pensò a quanto tutto fosse così intimo: l’arsura condivisa, l’umido delle labbra che si poggiavano assetate a combaciare sull’altro umido, il sole rigoglioso» (p. 100). Di quel giorno conservò vivida memoria. Nando le aveva, infatti, infilato una conchiglia nella borsa, preziosa reliquia di un amore mai definitivamente sbocciato. Del resto, il padre Giuseppe, stimato medico di ideali comunisti, le aveva detto, il giorno nel quale le aveva donato un “dammuso”, un casale in campagna: «Il tempo […] lascialo alla vita. E ai piccoli miracoli di cui è capace» (p. 67). Il “dammuso”, immerso in un campo di papaveri, era uno di questi miracoli: «Regalo e lascito di vita, che scoppiava nella linfa di piante ed erba. Regalo e lascito di profumi, fruscii, orizzonti, regalo che era se stesso e tant’altro» (p. 65). Fallito il tentativo di inserirsi nel mondo del cinema, Bice tornò a casa a seguito dell’incidente stradale nel quale furono coinvolti i suoi genitori. Il padre perse la vita, alla madre fu amputato un braccio. Bice non si rassegnò alla potenza perturbante del dolore, ai silenzi della madre, più loquaci delle parole, in quanto una potenza più forte l’animava, l’amore.
- ...
- La vita di Bice proseguì all’insegna di Eros: il casale, ben presto, fu trasformato in ricovero di animali feriti o sofferenti, tra i quali la tartaruga Ugo e la cagnolina “Purpiddu”, “piccolo polipo”, trovata malmessa, arruffata, sulla spiaggia dei Normanni, in una giornata di intima complicità con Luca. Poco dopo, la donna trasformò l’ambulatorio nel quale il padre aveva ricevuto i pazienti, nella prima biblioteca pubblica della cittadina. Bice era consapevole che, solo il sapere, è in grado di liberare davvero gli uomini da qualsivoglia soggezione. La pietas la indusse a ospitare, nascondendola al marito violento, una puerpera. L’uomo, dopo il parto, raggiunse la donna uccidendola a colpi di fucile. Divenuta maestra elementare, Bice amò, d’amore sincero, partecipato, i propri alunni. Tentava di avvicinarli alla conoscenza, per loro così ostica, drammatizzando storie e racconti. Cercò di salvare dal duro lavoro di contadino, cui lo aveva destinato il padre, uno di quei “carusi”, “Merichetto”, che riportò a scuola, ospitò presso di sé e accudì come un figlio, non badando alle maldicenze di paese. Il piccolo, dopo essersi inopinatamente ubriacato in Chiesa, fu spedito dal padre a Milano.
- ...
- In, Tante volte ancora, vengono rievocati, il matrimonio di Bice con Aldo Ortega, la morte della madre durante l’allunaggio dell’Apollo 11, l’apertura del teatro nella cantina della nuova casa, la nascita di Mara, madre di Luca, e l’aborto spontaneo, lancinante per l’animo della donna, di un figlio maschio. L’incipit del romanzo è dato dalla descrizione di un furto subito da nonna Bice che ricevette, in quell’occasione, un colpo alla testa. L’evento fece precipitare la sua situazione di salute già precaria e connotata da amnesie tipiche della demenza senile. Luca, che era stato amorevolmente accudito dalla nonna, si prodigò nell’aiutarla a ricostruire brandelli della sua vita. Era lui, ora, a raccontare storie del passato all’anziana congiunta.
- ...
- L’origine vige sempre nel tempo, seppur in modalità non evidente. Il senso del romanzo è, pertanto, esemplificato da questa frase di Pavese, che Flori pone in esergo: «L’uomo è mortale. “Di immortale non ha che questo: il ricordo che porta e il ricordo che lascia”». Il filosofo Andrea Emo, ha sostenuto che oblio e memoria sono due tendenze che la vita ha sempre inscritte nelle sue perpetue metamorfosi.
- Angela Flori, Tante volte ancora, Castelvecchi, pp. 345, euro 22,50.
-
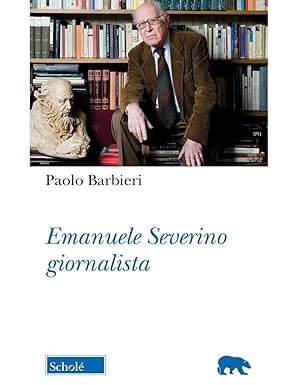
Emanuele Severino giornalista- Un saggio di
- Paolo Barbieri
- rec.di
- Giovanni Sessa
- Paolo Barbieri è giornalista e saggista. Ha fondato la rivista «Qui Libri» e ha partecipato alla costituzione dell’«Associazione Emanuele Severino». Al filosofo bresciano ha dedicato la sua ultima fatica, Emanuele Severino giornalista, nelle librerie per i tipi di Scholé. Il libro si articola in nove capitoli densi, organici, facilmente leggibili. Ognuno di essi è dedicato a un tema specifico del quale il filosofo scrisse su quotidiani o riviste. Si passa da tematiche politiche alla discussione del senso della guerra, dall’analisi del terrorismo italiano a quello islamico, dai problemi della scuola e dell’Università a interrogativi etici. Non mancano, inoltre, riferimenti ad articoli nei quali Severino si dedicò all’esegesi dei suoi autori: Parmenide, Eschilo, Leopardi, Nietzsche, Gentile ed Heidegger. Il volume è chiuso da un capitolo, rilevante e rivelatore, che mostra l’interesse severiniano per musica e cinema.
- ...
- Barbieri, nell’introduzione, ripercorre l’iter teorico del filosofo. Questi pubblicò il suo primo libro nel 1948, quando aveva diciassette anni. Si tratta de, La coscienza. Pensieri per un’antifilosofia, volume di ascendenza schopenhaueriana che individuava nella musica la possibilità di portarsi oltre la significazione concettuale. Per questo, nella fase matura, l’intellettuale bresciano palerà del suo primo libro come di “un peccato di gioventù”. Ottenuta, in giovane età, la docenza all’Università del Sacro Cuore di Milano, i primi scritti teoretici di Severino, in particolare Ritornare a Parmenide, suscitarono vive polemiche negli ambienti cattolici e neo-scolastici. La sua filosofia fu sottoposta al vaglio della Congregazione per la dottrina della fede che la giudicò incompatibile con il cristianesimo. Severino fondò, quindi, a Venezia il Dipartimento di filosofia dell’Università Ca’ Foscari. Ha accompagnato, da allora, la docenza e la pubblicazione delle opere teoretiche a un’intensa attività giornalistica. Collaborò a quotidiani quali «Bresciaoggi» e il «Corriere della Sera» e alle riviste «Spirali», di Armando Verdiglione, e «Liberal», di Ferdinando Adornato. Al primo quotidiano, fu introdotto da Bruno Boni, già vicesindaco democristiano di Brescia e allievo, come Severino, di Bontadini. Al «Corriere», suoi mentori furono Giulio Nascimbeni e Gaspare Barbiellini Amidei. La sua collaborazione al quotidiano milanese si intensificò quando Armando Torno assunse la direzione delle pagine culturali.
- ...
- Il primo articolo del filosofo comparve, in realtà, nel 1974 sul quotidiano il «Giornale di Brescia». Il primo articolo su «Bresciaoggi» uscì lo stesso anno con il significativo titolo, I piani del fascismo. Si trattava di un’analisi delle ragioni che avevano portato alla strage di Brescia e che, di fatto, stavano a monte della “strategia della tensione”. Rileva Barbieri che, a solo quattro giorni dalla strage, Severino, sostenne quanto, molti anni dopo, rilevarono nel giudizio finale i magistrati inquirenti: «i fascisti di Ordine Nuovo volevano provocare una reazione violenta delle sinistre al fine di giustificare un intervento dell’esercito» (p. 16). Tesi questa che, chi scrive, non condivide del tutto. Qualche tempo dopo, in un successivo articolo in tema, il pensatore mostrò, per un verso, apprezzamento su quanto, in merito alle stragi, aveva scritto Pasolini ma, d’altro lato, rinvenne nelle posizioni dello scrittore la tendenza omissiva tipica degli intellettuali italiani, che avevano ormai rinunciato a dire pienamente il vero: «Con tutta la simpatia che si può avere per lui, egli rappresenta, con la sua istanza morale, gli intellettuali che non hanno ormai più nulla da obiettare al potere» (p. 17). Si badi, Barbieri ribadisce, a più riprese, che il valore della pubblicistica giornalistica del filosofo è data dal fatto che la sua lettura transpolitica della contemporaneità (altra rispetto a quella di Del Noce), non è prodotto di engagement, del prender parte per una data famiglia politica. Al contrario, Severino mantenne, anche in questi articoli, la propria vocazione filosofica, riproponendo di fatto, in un linguaggio semplificato adatto al pubblico di non specialistici, la sua visione delle cose.
- ...
- Per questo, nell’affrontare il tema della guerra, non si richiama al moralismo pacifista. Di contro, discutendo l’asserzione eraclitea «Polemos è padre di tutte le cose», finì per ribaltarla quando sostenne: «che la cosa, ovvero il senso greco della cosa, […] è madre di tutte le guerre» (p. 43). La storia dell’Occidente, i suoi drammi, sono l’inevitabile esito cui l’uomo europeo è giunto nel ritenere gli essenti oscillanti perennemente dal nulla all’essere e dall’essere al nulla. Tale senso degli essenti, tratto costitutivo del nichilismo, è stato portato a estrema coerenza teorico-pratica dalla Tecnica e dal suo Apparato. Nel mondo contemporaneo: «Le ideologie (capitalismo, socialismo, cristianesimo e democrazia) ritengono di poter utilizzare l’Apparato come mezzo per realizzare dei loro scopi, senza rendersi conto che […] sarebbero (saranno) destinate ad adeguarsi e a subordinare i loro fini a quelli dell’Apparato» (p. 46). Le guerre contemporanee, il terrorismo fondamentalista islamico, lo stesso marxismo, non rappresentano che l’ultimo illusorio tentativo di salvarsi dall’angoscia del divenire in nome degli Immutabili, ormai al tramonto. Risulta, pertanto, dirimente pensare in modalità altra da quella platonica il “parricidio” parmenideo, al fine di lasciarsi alle spalle il senso greco della cosa e pervenire a una visone non più centrata sulla totalità dell’Essere-Uno, ma sull’eternità degli essenti, di ogni essente, sottraendolo alla violenza della volontà di potenza.
- ...
- Negli articoli dedicati alla riforma di scuola e Università il filosofo bresciano difese, per tale ragione, l’autonomia e la centralità della filosofia teoretica, capace di dis-velare il senso riposto del contemporaneo e di condurre al “Sentiero del Giorno”. Il mondo greco individuò, con Eschilo, in Zeus, la verità e il rimedio all’angoscia del divenire: in tal modo sorsero gli Immutabili a cui guardò il cristianesimo nel suo bisogno di una conoscenza salvifica ed epistemica. Eschilo è stato l’iniziatore di tale percorso, ricorda Barbieri, mentre Leopardi, non solo poeta sommo ma insigne filosofo prossimo a Nietzsche, avrebbe aperto: «l’ultimo tratto di quel sentiero» (p. 147). Il Recanatese, in tal senso, sarebbe, con Gentile, il pensatore cruciale dell’età della Tecnica. Le sue “illusioni” permettono all’uomo di tollerare: «una vita meno dura» (p. 154). Gentile, del resto: «si è legato al fascismo perché ha creduto di vedere in esso lo strumento più idoneo per rispondere “alle tendenze e ai bisogni degli individui” […] Che non sono quelli dell’individualismo illuministico, ma quelli in cui la vita dell’individuo […] si unisce alla vita dello spirito» (p. 159).
- ...
- Emanuele Severino giornalista è libro di rilievo. Ne abbiamo fornito una ricostruzione parziale. Le sue pagine immettono il lettore, in modalità organica e lineare, nell’universo ideale di uno dei più grandi filosofi del secondo Novecento. Qualità non comune, della quale va dato merito all’autore.
- Paolo Barbieri, Emanuele Severino giornalista, Scholé, pp. 216, euro 20,00.
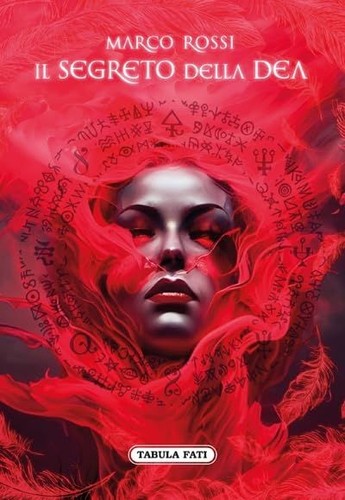
Il segreto della Dea- Un romanzo iniziatico di
- Marco Rossi
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Marco Rossi è autore noto. Ha collaborato alle pagine culturali di diversi quotidiani e suoi scritti sono comparsi su riviste. La sua produzione libraria è significativa, si è occupato, in particolare, di ricerche storiche mirate a individuare nessi tra la cultura esoterica del secolo XX e la storia politica del “secolo breve”. Rossi, si badi, non è solo saggista, è dotato, infatti, di notevole talento narrativo. La sua ultima fatica, da poco nelle librerie per i tipi di Tabula Fati, lo conferma e può essere letta quale sintesi delle due propensioni intellettuali dell’autore, gli studi tradizionali e il racconto fantastico. Ci riferiamo a, Il segreto della Dea (per ordini: 0871/561806; edizionitabulafati@yahoo.it). Il volume è preceduto dalla presentazione di Andrea Marcigliano e dalla postfazione di Andrea Scarabelli, scritti che arricchiscono ulteriormente il testo.
- ...
- Si tratta di un romanzo iniziatico che, nel suo incipit, potrebbe apparire come romanzo generazionale. I tre protagonisti della vicenda, Corrado, Armando e Anna appartengono (come del resto Rossi) alla generazione che visse l’adolescenza negli anni Settanta, gli “anni di piombo”. Un frangente storico che segnò la fine delle speranze rivoluzionarie, dopo il quale, molti dei protagonisti di quella congerie storica conobbero la dimensione esistenziale del disincanto. Tale destino accomuna, in modalità diverse, Corrado, Armando ed Anna. Il primo, durante la giovinezza acceso militante comunista, appassionato cultore del mondo classico, in particolare della tradizione romana, giunto ai quarant’anni, lo ricorda Marcigliano, si era adattato «alla moderazione di una “nuova sinistra” di governo […] e trascina(va) i giorni e gli anni come impiegato dell’Ufficio Tecnico del comune» (p. 5) di S. Miniato in Toscana. Il legame amicale tra Corrado e Armando, molto solido durante l’adolescenza, si era, con il passar del tempo affievolito. Il secondo, infatti, era uomo “vagamente” di destra. In realtà, a dividerli non era stata la diversa scelta politica, ma il grigiore mesto nel quale le loro vite adulte erano precipitate per aver dimenticato, in nome del contingente e degli interessi (Armando era divenuto affermato imprenditore), gli ideali della giovinezza. Anna, infine, protagonista femminile del racconto e docente in un liceo, è in qualche modo, la vera protagonista de, Il segreto della Dea. Amata segretamente dai due giovani, viveva anch’essa una maturità infelice, connotata da un matrimonio senza amore e dalla certezza di non poter generare figli. Un evento drammatico, un cataclisma, fa incontrare di nuovo i tre protagonisti del romanzo: un terremoto del sesto grado della scala Mercalli che devasta, nella notte tra il 1 e il 2 settembre, S. Miniato. La terribile scossa tellurica fa riemergere, dalle fondamenta del Palazzo comunale, delle mura romane e dei sotterranei fino ad allora sconosciuti.
- ...
- Corrado viene chiamato dai primi soccorritori che, consapevoli della sua perizia in antichistica, gli chiedono di tradurre e di interpretare un’iscrizione latina emersa dal sottosuolo. Giunto sul posto, incontra Armando e, poco dopo, Anna: «I tre raggiunsero uno spazio un po’ meno scosceso, dove per terra era adagiata una lapide di marmo nero» (p. 14). Si trattava di un Lapis Niger di forma rettangolare nel quale mancava una parte dell’iscrizione che, nonostante le ripetute ricerche, non fu trovata in loco. La vista dell’iscrizione riaccende nei tre amici l’antica passione per l’insolito, per i Misteri antichi e ha, così, inizio una “cerca” dal tratto iniziatico, che, come si evince dalla conclusione del romanzo, li “riporterà a casa”.
- ...
- Il loro sarà un “risveglio” alla vita vera, oltre la banalità del quotidiano borghese nel quale, fino ad allora, si erano acquietati. Passeranno, pertanto, dallo spaesamento moderno, per dirla con Heidegger, alla ri-scoperta delle loro più profonde e vive radici. Torneranno “a rimirar le stelle”. Da S. Miniato mettono in atto, al fine di seguire le tracce dell’iscrizione, un iter che lì guiderà sui sentieri dell’Etruria. Si fermeranno a Pisa, Populonia, Cosa, Vulci per giungere, infine, alla meta agognata, Roma. A far loro da guida, il testo dell’iscrizione, una vera e propria mappa di geografia sacra. Di volta in volta, il genius loci delle località incontrate li porrà sull’avviso che l’impossibile è sempre possibile ed ha il tratto numinoso delle ierofanie. I veri protagonisti del romanzo sono gli dèi, anzi la Dea Vesta e il suo fuoco sacro, il fuoco della Tradizione, come ricorda Scarabelli nella bella postfazione, custodito sotto le ceneri, ma vigente, in ogni epoca, nella storia.
- ...
- «Corrado, Armando, Anna divengono […] manifestazioni terrestri [… ] imperfette - di Archetipi ideali […] ombre degli dèi stessi e della loro, ancora una volta, misteriosa volontà» (p. 7). Se questa è la sostanza che sostiene il narrato di Rossi, non sorprende che nel testo compaiono, a più riprese, rimandi all’opera di Steiner, Evola, Kremmerz e di altri esponenti del pensiero di Tradizione. La conclusione de, Il segreto della Dea si realizza all’Altare della Patria a Roma, nei pressi del Foro. Corrado e Armando hanno, finalmente, chiara contezza di ciò che sono nel profondo: «Siamo due Littori di scorta a quella Vestale che cammina davanti a noi (Anna) così compresa nel suo ruolo, bella come la luna!» (p. 193). L’Altare della Patria, il fuoco acceso davanti al sepolcro del Milite Ignoto, non va inteso, sic et simpliciter, quale simbolo dell’Italia “patriottarda” cantata con pathos retorico dalle patrie lettere, ma rappresenta «l’anima profonda (Vesta)» del nostro essere italiani, la dimora ospitale apparentemente persa nella storia.
- ...
- Ne, Il segreto della Dea, Rossi mostra, come ricorda Scarabelli, di avere memoria di un saggio comparso sulla rivista «Krur», intitolato la “Grande Orma” e firmato “Ekatlos”. In quelle pagine si faceva riferimento al simbolo della Fenice risorgente dalle fiamme. Il senso di questo romanzo, connotato, peraltro, da prosa accattivante e coinvolgente, sta tutto qui: Roma Renovata Resurgat. L’autore e i tre protagonisti testimoniano che l’origine è sorgente di vita sempre vigente nel tempo.
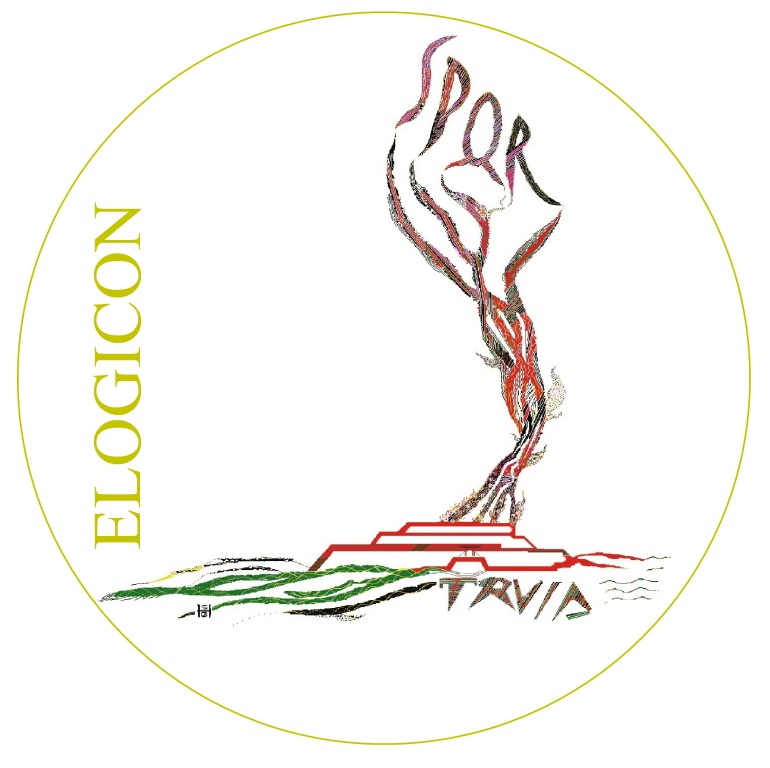
Marco Rossi, Il segreto della Dea, presentazione di Andrea Marcigliano, postfazione di Andrea Scarabelli, pp. 205, euro 15,00.
-
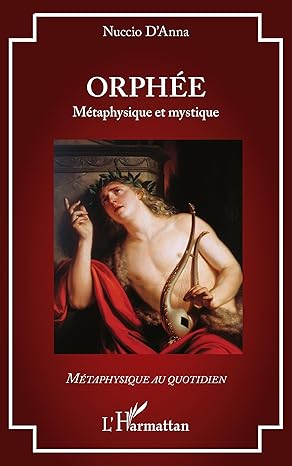
- Orphée.
- Métaphysique et mystique
- di
- Nuccio D’Anna
- Un saggio uscito in Francia
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Gli studiosi italiani della Tradizione hanno avuto e continuano ad avere un’attenzione significativa all’estero. Tra questo sparuto drappello di intellettuali va inserito Nuccio D’Anna che, da tempo, collabora con riviste internazionali ed ha all’attivo una trentina di volumi. È studioso di vaglia, in particolare, di simbolismo e storia delle religioni e, più in generale, di antichistica. La sua ultima fatica è da poco comparsa in Francia, nel catalogo della casa editrice L’Harmattan. Si tratta di, Orphée. Métaphysique et mystique, un saggio ampio e organico, dedicato all’Orfismo e alla figura del suo fondatore. Il volume è articolato in sette densi capitoli. In essi, D’Anna intrattiene il lettore, in prima istanza, sulle origini del movimento orfico, per poi procedere all’esegesi della visione del mondo della quale Orfeo fu latore. Si passa dall’analisi della musica, quale strumento atto a cogliere l’armonia del reale, alla cosmogonia, dall’approfondimento dell’escatologia orfica alla antropologia, per giungere, nella parte conclusiva del volume, alla presentazione delle forme rituali connotanti tale movimento realizzativo.
- ...
- L’autore si avvale, come di consueto, di una conoscenza non comune delle fonti e discute, con pertinenza argomentativa, la vasta bibliografica critica in argomento. Nonostante il tratto erudito del testo, la lettura risulta godibilissima perfino per il lettore non specialista. Fin dall’incipit del saggio, lo studioso italiano chiarisce i tratti essenziali dell’Orfismo: «Gli orfici hanno elaborato un’antropologia che esige un’ascesi rigida per evadere dalla prigione del […] “ciclo della necessità” e un organismo rituale complesso articolato attorno a “forme” iniziatiche sviluppate in forza di un’intensa attività mistico-contemplativa» (p. 7). Per comprendere il fenomeno religioso indagato, è necessario calarsi nella realtà spirituale dell’Ellade arcaica: «Verso l’VIII secolo a.C. il territorio greco fu percorso da un gran numero di estatici erranti e di asceti solitari la cui fenomenologia religiosa resta fondamentalmente incerta» (p. 7). Si trattava di una “forma” autonoma di ascetismo, che si sviluppò in parallelo alla normale attività sacrificale legata alla religione olimpica, ma che non si riferiva ad aspetti religiosi marginali o, addirittura, come alcuni studiosi hanno ritenuto, sovversivi rispetto all’ordine religioso e civile costituito.
- ...
- Gli asceti erranti agirono, attraverso cerimoniali di purificazione, nei momenti di “crisi” della civiltà greca. Tali fenomeni erano indotti, a volte, da epidemie o invasamenti di natura sottile. Diodoro Siculo ricorda che Orfeo emerse da un contesto cultuale nel quale agivano magi e “manipolatori della materia” quali i “fabbri”: «Si ritiene, in effetti, che aspetti importanti della sua (di Orfeo) perizia profetica, creativa e incantatoria, provenissero da questo substrato misterioso coincidente con l’archetipo mitico configurato da alcuni esseri primordiali estranei all’Olimpo» (p. 9). D’Anna, a riguardo, ricorda gli Dèi Dattili, cinque ragazze e cinque giovani, nati, secondo il mito, dalle dita di Rea quando la dèa, per propiziare la nascita di Zeus, appoggiò le proprie mani sul sole. Si tratta di personificazioni del potere di creazione e di trasformazione della condizione originale, magmatica, con la quale Rea ebbe a confrontarsi. Gli Dèi Dattili fanno riferimento ad un contesto religioso e sociale diffuso nel bacino del Mediterraneo orientale e: «testimoniano una percezione cosmica dei ritmi spirituali […] possono essere assimilati a numerosi aspetti dello sciamanesimo siberiano» (p. 11). Secondo una tradizione consolidata sarebbero state le cinque fanciulle ad iniziare Orfeo al culto della Magna Mater. In realtà, precisa D’Anna: «tutto indica che ci troviamo in presenza di una sorta di religio secunda poco ordinata, ma molto diffusa, radicata e fiorente ai margini del culto olimpico e dei misteri ufficiali» (p. 14). Gli estatici rappresentarono la “sopravvivenza” di un’eredità assai antica. Per comprendere l’Orfismo è necessario, pertanto, far riferimento alla figura di Zalmoxis, originario della Tracia.
- ...
- Platone ritiene che la spiritualità afferente ai Traci, ricorda D’Anna, fosse centrata sul “rendere immortali” attraverso una forma arcaica di misteriosofia, nella quale avevano un posto di rilevo la cura e la Salus dell’anima. Una visone del mondo, ha spiegato Eliade, che fa aggio su dottrine escatologiche e su un fondamento iniziatico: «In Tracia sembra essersi stabilito un largo substrato religioso, definito da forme iniziatiche nelle quali i rituali di “morte e rinascita” hanno giocato un ruolo molto importante» (p. 20). Tali rituali si avvalevano di formule sacre di ascendenza apollinea, spesso di natura cosmogonica, che permettevano di realizzare un’ascesa attraverso i diversi stati della gerarchia dell’essere e consentivano di operare un effettivo ritorno alla perfezione dell’inizio, dell’origine. D’altro lato, tali riti si accompagnavano a formule incantatorie e di guarigione. L’orfismo apparve, così, in Grecia alla fine del VII secolo e all’inizio del VI secolo a.C. Presto mise in luce la sua straordinaria capacità diffusiva e divenne: «una componente importante delle celebrazioni nei santuari più venerati della religiosità ellenica» (p. 30): perfino nei Misteri di Eleusi è possibile ravvisare prospettive connotanti la palingenesi orfica. L’Orfismo, platonicamente, prevedeva la restaurazione dell’ordine interiore dei singoli, quale condicio sine qua non, dell’ordine della Città. A dire di D’Anna, pertanto, l’Orfismo non ebbe alcuna intenzione di riformare il corpo sociale delle pōleis.
- ...
- Attualmente, Orfeo viene considerato, almeno dalla critica più accreditata, quale fondatore di una tradizione di grande rilievo, paradigma di una comunità di affiliati a una forma di spiritualità articolata e complessa, annunciata da “cantori” che avevano vissuto realmente stati estatici. L’influenza dell’orfismo fu “sottile”, coinvolse gli strati popolari e quelli aristocratici: «Suo obiettivo è sempre stato la conversione degli uomini e la trasfigurazione spirituale della loro dimensione interiore» (p. 39). Il nome Orfeo non sta tanto a indicare una data persona, un personaggio storico, ma uno stato spirituale: è epiteto di qualificazione tecnica. Gli autentici iniziati orfici, ricorda Platone, si facevano chiamare “Teologi Antichi”. Questi, avendo conseguito, in sintonia con i ritmi musicali del cosmo, l’armonia interiore erano dotati di capacità profetica: «Orfeo è il maestro della musica liberatrice che ristabilisce l’equilibrio primordiale esistente nel mondo delle origini […] È il creatore della “forma” musicale che la lira apollinea […] modula per riprodurre i suoni originali e restaurare il mondo nella sua perfezione primordiale» (p 53).
- ...
- Queste sono solo alcune della ragioni per leggere, Orphée. Métaphysique et mystique. Un libro che rende onore agli studi tradizionali italiani.
Nuccio D’Anna, Orphée. Métaphysique et mystique, L’Harmattan, pp. 237, euro 25,00.
-
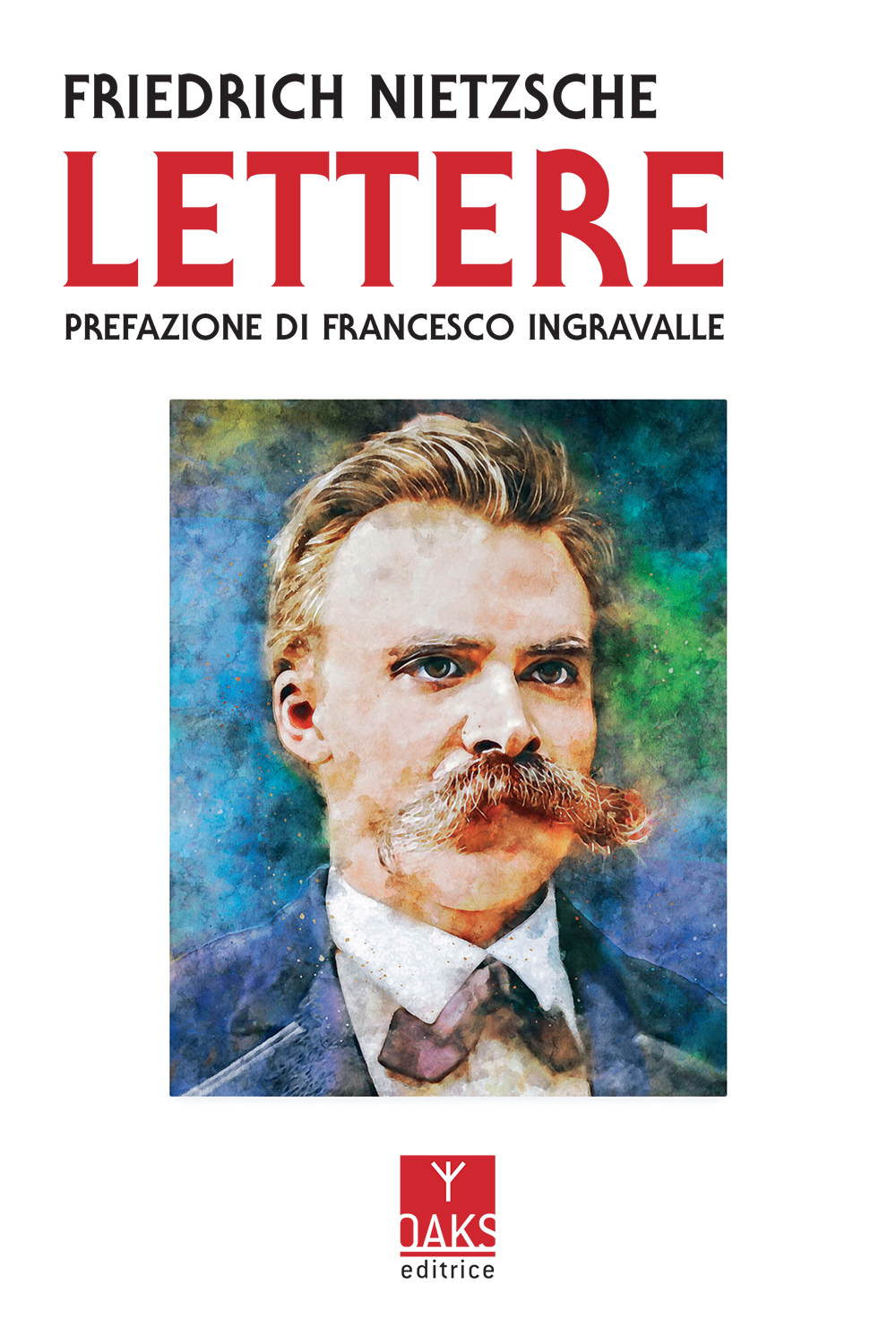
Friedrich Nietzsche- "Lettere"
- Torna l’opera curata da Barbara Allason nel 1941
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
Nietzsche è, per il nostro tempo, pensatore cruciale. Il filosofo di Röcken, infatti, ha anticipato profeticamente quel che sarebbe accaduto nella post-modernità e si è fatto latore, in opposizione alla visione egualitaria divenuta predominante in Europa negli ultimi secoli, del contro-movimento sovrumanista. Al fine di comprendere il tratto “destinale” della filosofia di Nietzsche, consigliamo vivamente la silloge delle sue missive, pubblicata in prima edizione nel 1941 per la cura di Barbara Allason. Una nuova edizione del volume, aperta dalla contestualizzante prefazione di Francesco Ingravalle, è ora nelle librerie per i tipi di Oaks editrice, con il titolo, Lettere (per ordini: info@oakseditrice.it). Pur trattandosi di una raccolta parziale dell’epistolario di Nietzsche, il libro ha carattere organico e consente al lettore di comprendere, non semplicemente l’iter speculativo del filosofo tedesco, ma anche gli aspetti più riposti dell’animo di Friedrich.- ...
- Barbara Allason fu studiosa seria e coraggiosa. Il suo mondo ideale di riferimento, peraltro, non guardava di certo con simpatia alla “trasvalutazione” dei valori auspicata dall’autore de, La nascita della tragedia. Nata nel 1877 a Pecetto Torinese, si formò dapprima all’Università di Torino e poi in quella di Napoli. Nella città partenopea entrò in contatto con Benedetto Croce. Centrale risultò, nella formazione della giovane intellettuale, la figura del germanista Arturo Farinelli, incontrato nel capoluogo sabaudo. Barbara fu traduttrice di vaglia (non solo dal tedesco), ma anche autrice di romanzi e saggista. Nazionalista e interventista nel 1915, si avvicinò successivamente a Piero Gobetti. Durante il ventennio fascista, per la sua adesione a “Giustizia e Libertà” dei fratelli Rosselli, fu dispensata dall’insegnamento e subì una serie di ulteriori discriminazioni. Nel 1946 dette alle stampe, Memorie di un’antifascista. Fu, comunque, intellettuale davvero libera, animata da curiositas, originale. Lo si evince dalla lettura dell’introduzione alle Lettere di Nietzsche, nella quale mostra un chiaro apprezzamento per l’esegesi nietzschiana di Alfred Baeumler. Questi, a proposito dell’epistolario del filosofo, ha scritto: «Il rapporto tra l’arte e l’opera di Nietzsche è cosi stretto che c’è da dubitare se le lettere siano da ritenere un commento alle opere, o non piuttosto le opere un commento alle lettere» (p. 9).
- ...
- L’affermazione di Baeumler chiarisce come l’epistolario del teorico del “superuomo” abbia valore eminentemente teoretico, non semplicemente biografico, visto che in Nietzsche vita e pensiero coincisero in modalità inusitata. Del resto, fu lo stesso filosofo a scrivere: «Nella mia vita nulla è caso, tutto è destino» (p. 9). Friedrich ebbe contezza, ricorda Ingravalle, che: «i valori, cioè ciò in vista di cui si agisce non sono, ma sono posti» (p. II). Gli esseri umani si rapportano tra loro o attraverso la forza o attraverso la persuasione: «Che cos’è vero? Che la verità non esiste» (p. III).
- ...
- La lettera che apre la silloge, indirizzata alla sorella Elisabeth l’11 giugno 1865, mette a tema la sperimentazione del nichilismo: «Vuoi raggiungere la pace del cuore o la serenità? Credi! Vuoi essere un discepolo della verità? Cerca!» (p. IV). Nietzsche ebbe consapevolezza che non si poteva più far riferimento, se mai in passato ciò fosse stato possibile, all’Ordnung, a un potere dall’alto, atto a pacificare armonicamente il conflitto che vive nei singoli e nella storia. Per questo, a suo giudizio, il nichilismo rappresentava una possibilità: «Nella vicenda del nichilismo […] il personale e il politico si intrecciano» (p. VI). Dalle lettere si evince, come del resto dalle opere, che Nietzsche pensò sia la decadenza che la possibile contro-decadenza. A tale assunto, Friedrich non fece seguire, a dire di Allason, una scelta meramente “titanica”, vale a dire un: «atteggiamento avido di tutte le più belle e compiute esperienze, ma anzi quello dell’assoggettamento al più severo imperativo categorico» (p. 9). Questo ascetismo della “cerca”, a dire della studiosa torinese, nel tedesco assunse fattezze “cripto-cristiane”. Posizione condivisa, peraltro, da altri interpreti di Nietzsche: da Eric Voegelin, in particolare, ma in parte anche da Robert Reininger, la cui monografia nietzschiana fu tradotta in italiano da Julius Evola.
- ...
- La lettura della silloge consente di attraversare l’intero itinerario speculativo ed esistenziale del filosofo. Dall’iniziale infatuazione per Schopenhauer e per Wagner, testimoniata da La nascita della tragedia, opera centrata sul ruolo “ancillare” della filologia rispetto alla filosofia e mirante alla riattivazione del mito tragico (tema ancora vivo e presente nelle Considerazioni inattuali), fino alle fasi speculative successive. Deluso dalla Germania del II Reich e dal festival wagneriano-barocco di Bayreuth, Nietzsche scrisse il 6 aprile del 1873 a Malwida von Meysenburg: «Ora tutto attende l’uomo d’azione, che scuota da sé e dagli altri le abitudini millenarie» (p. XII). I miti della giovinezza di Friedrich furono messi in discussione nella fase “illuminista-illuminata”, a seguito dell’incontro con Voltaire. Nel 1879 il pensatore si dimise dall’insegnamento universitario a Basilea e dette inizio, in tale frangente, a una inesausta peregrinazione in Europa alla ricerca di condizioni ambientali ed esistenziali, che gli consentissero di proseguire la “cerca”. È in questa solitudine che scoprì “spiriti” a lui affini, innanzitutto Spinoza, ma anche Montaigne e l’abate Galiani. Scrisse, in tale contesto, le opere più note, Così parlò Zarathustra e Al di là del bene e del male. Il 2 dicembre 1887 si rivolse a Brandes, uno dei suoi “pochi” lettori, con queste significative parole: «L’espressione di “radicalismo aristocratico” di cui vi servite a mio riguardo è eccellente» (p. XVII). Alla sorella inviò il 17 settembre 1888 una lettera in cui compare questa perentoria affermazione: «I miei nemici sono il cristianesimo, la morale, la verità» (p. XIX).
- ...
- Nietzsche, di fatto, mise in atto, in forza della lezione tratta da Spinoza, una naturalizzazione della cultura. La physis rimase, in ogni fase del suo pensiero, l’unico orizzonte di riferimento cui votarsi. I “biglietti della follia”, a partire dal 1888, testimoniano la confusione in cui cadde nell’ultimo periodo di vita.
- ...
- Il suo aderire all’“imperativo categorico” della “cerca” dice, forse, più che di un “cripto-cristianesimo” del filosofo, la sua ferma volontà epistrofica, di recupero del mondo cantato da Archiloco, centrato sul: «senso nobiliare dell’onore dell’“età omerica”» (p. XXIX) e sulla physis, unica “trascendenza” cui guardare oltre i dualismi imposti dal pensiero logo-centrico.
- Friedrich Nietzsche, Lettere, prefazione di Francesco Ingravalle, Oaks editrice, pp. 308, euro 25,00.
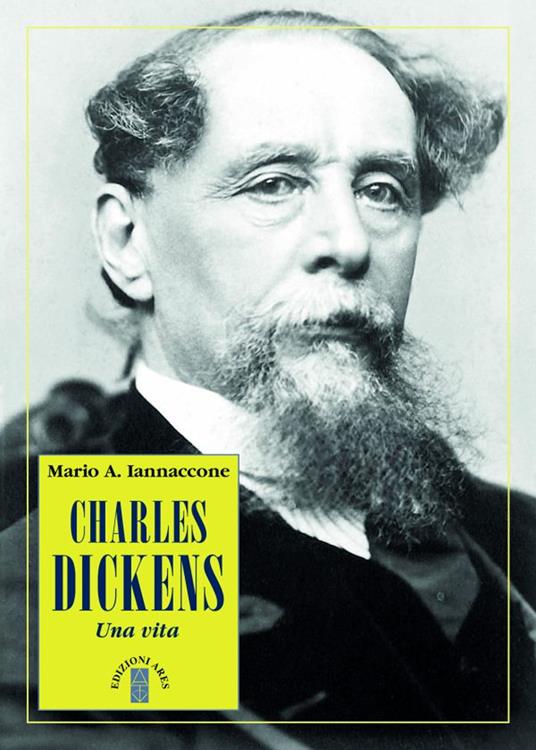
Charles Dickens. Una vita- Una biografia dello scrittore inglese di
- Mario A. Iannaccone
- rec.
- di
- Giovanni Sessa
- Mario A. Iannaccone è scrittore prolifico. Si è occupato, in particolare, di storia e di storia della cultura. In qualità di romanziere è stato finalista del Premio Calvino con, La cospirazione, volume uscito nel 2008. È nelle librerie, per i tipi di Ares, la sua ultima fatica, Charles Dickens. Una vita (per ordini: info@edizioniares.it). Si tratta di una biografia intellettuale del grande scrittore inglese, attenta non soltanto ai dati esteriori, meramente cronologici dell’esistenza terrena di Dickens, ma centrata sulla chiara volontà di decodificarne gli aspetti interiori, di portare alla luce la visione del mondo del narratore, nonché le recondite motivazioni psicologiche ed esistenziali che la sostanziarono. Nelle pagine del volume, Iannaccone mostra profonda conoscenza del personaggio, degli eventi, spesso tragici, con cui dovette confrontarsi, oltre a una sicura padronanza della letteratura critica in tema.
- ...
- Si tratta di un testo che, anche dal punto di vista letterario, risulta convincente e coinvolgente. L’autore ha piena consapevolezza che la produzione di Dickens è centrata sul continuo intersecarsi di vita vissuta e inventività fantastica. Fu il confronto serrato che lo scrittore intrattenne con uomini, donne, critici letterari, con gli stessi problemi politico-sociali dell’epoca in cui ebbe in sorte di vivere (1812-1870), ad innescare in lui la necessità di “fare” letteratura: «La biografia di Dickens si presta alla scrittura di un metaromanzo» (p. 6), che pone al centro delle vicende un: «celebrato (autore), padre di dieci figli, filantropo, infaticabile organizzatore di eventi di beneficienza (ma) anche uomo inquieto, ossessionato dalla morte […] tormentato dai fantasmi e costantemente sofferente al ricordo dell’infanzia di povertà» (p. 6). La vita di Charles è analizzata in ogni suo aspetto, a muovere, appunto, dalla primissima infanzia che, per Dickens, non fu un’età felice. La famiglia d’origine fu costretta, più volte, a migrare di città in città, mettendo in atto una serie infinita di traslochi, a causa dei periodici dissesti economici nei quali fu coinvolta dalla condotta, poco accorta, del capofamiglia John. Questi, non si sa bene per quale motivo, contrasse dei debiti che, in più di una circostanza, non riuscì a saldare, tanto da conoscere la reclusione nelle prigioni per debitori.
- ...
- Quando Charles aveva cinque anni, i Dickens andarono a vivere nel Kent, a Chatman. La casa di Chatman: «fu la più amata e la più importante […] nella geografia dell’immaginazione dello scrittore e sarebbe rimasta impressa, più di ogni altra, nella sua memoria» (p. 10). Qui imparò ad amare la verde e ondulata campagna inglese, che torna in tante descrizioni dei suoi romanzi, quale luogo accogliente, ospitale e vivificante. Non è casuale, ricorda Iannaccone, che l’area rurale di Chatman, con il fiume Medway sullo sfondo, sia stata il luogo nel quale Dickens ambientò alcune delle “avventure” narrate nel Circolo Pickwick. A causa dei continui trasferimenti e della precaria situazione economica della famiglia, l’istruzione di Charles fu irregolare. La sua formazione fu, in realtà, l’esito del suo animo curioso, che lo indusse a letture voraci e continue. Sulla formazione dell’immaginario di Dickens svolsero ruolo dirimente i racconti di fiabe, che ascoltò durante l’infanzia. Da essi trasse la convinzione della possibilità dell’impossibile. Il giovane fu duramente formato anche dalla frequentazione del carcere per debitori, che conobbe durante gli incontri con il padre.
- ...
- Il mondo degli ultimi, dei sofferenti e la necessità di rendere loro giustizia sarà centrale nella produzione letteraria dickensiana. La creatività del Nostro fu, inoltre: «alimentata dalla frequentazione del teatro» (p. 13), dalla quale trasse significative capacità attoriali, di immedesimazione psicologica nel vissuto dei personaggi. Tale interesse spiega come, dalle sue opere, si evinca l’abilità di passare, con estrema facilità: «dalla tragedia alla farsa e viceversa» (p. 14), testimonianza della convinzione che, nella vita, gli opposti si danno sempre in uno: «L’immaginazione di Charles era attratta tanto dal lato burlesco e allegro della vita quanto dai lati meno luminosi, gotici e macabri» (p. 15). A dodici anni si impiegò nella fabbrica di lucido da scarpe Warren’s Blacking, ubicata in una stradina umida e tetra di Londra, per raggiungere la quale doveva fare lunghe camminate. Le lunghe escursioni furono una costante della vita di Dickens fino agli ultimi anni, mentre la città di Londra, con le sue contraddizioni, sarà polo attrattivo ritornante della sua narrativa.
- ...
- Tra il 1825 e il 1827 fu apprezzato stenografo parlamentare: in questa fase iniziò a pubblicare scritti su periodici. Poté, grazie alla conseguita indipendenza economica, andare a vivere da solo. Dopo un breve innamoramento per una giovane di buona famiglia, sposò Catherine Hogarth, dalla quale ebbe molti figli e, per molti anni, visse felice con lei. I rapporti tra i due si incrinarono a causa di una giovane attrice, per la quale Dickens perse la testa. All’epoca, il Nostro aveva conseguito la notorietà e il “caso” fece parlare la grande stampa. La separazione fu molto dolorosa per entrambi i coniugi, ma Catherine mostrò, nella triste circostanza, un’evidente nobiltà d’animo. Iannaccone ripercorre e analizza, in modalità organica e persuasiva, non semplicemente gli eventi più significativi della vita di Dickens, soffermandosi, tra l’altro, sui viaggi in America, nella Francia dell’“anno dei portenti”, in Italia, ricordando il suo amore per Genova e l’interesse per il modo di vivere del nostro popolo, ma si intrattiene anche sulla storia editoriale dei suoi romanzi, tanto sui più noti, quanto sui meno conosciuti.
- ...
- Il successo gli arrise a muovere dalla pubblicazione, prima a puntate su un periodico, poi in un unico volume, della “cerca”, messa in atto nell’Inghilterra della età del pieno dispiegarsi della rivoluzione industriale, dai membri del Circolo Pickwick. In queste pagine, Charles mette in scena in modalità esilarante, per dirla con Mario Praz, una visione ludica della vita, mostrando straordinarie qualità inventive. Il testo ha tratto sincopato, ritmico, al racconto vero e proprio, si alternano storie di personaggi incontrati dai quattro protagonisti sulla “scena” inglese del tempo. Da esse si evince la possibilità dell’impossibile, testimoniata dalla fiaba. Il linguaggio di Sam Weller, le rocambolesche vicende che riesce a risolvere, sono alta testimonianza di questo tipo di inventività. Tra i molti tratti della personalità di Dickens messa a tema da Iannaccone, chi scrive è particolarmente sensibile all’apertura mostrata dall’inglese al misterium vitae. Questo, a nostro avviso, l’aspetto cruciale del “realismo magico” dickensiano. Charles Dickens. Una vita, è, per questo, biografia di sicuro valore, da leggere e meditare.
- Mario A. Iannaccone, Charles Dickens. Una vita, Edizioni Ares, pp. 360, euro 22.00.
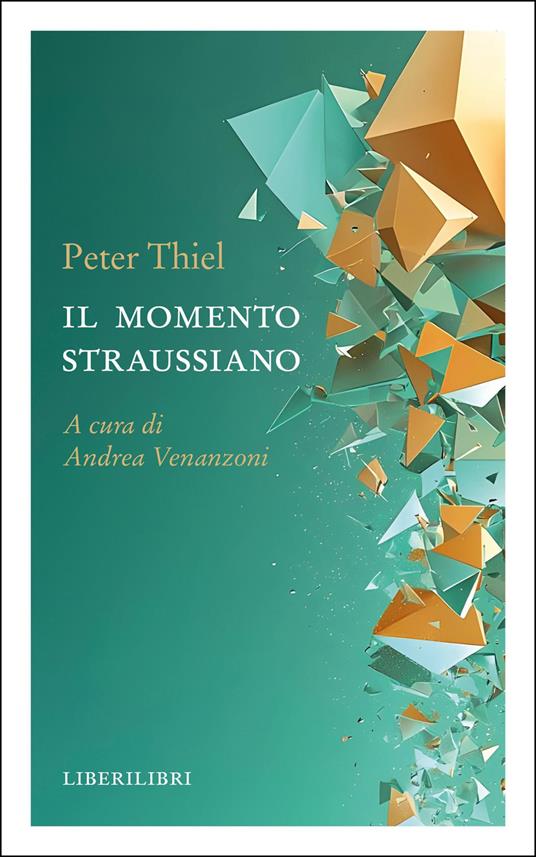
"Il momento straussiano" - di
- Peter Thiel
- (Liberilibri, Macerata 2025, pp. 65 + XXXIV, € 14,00)
- rec di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Come scrive Andrea Venanzoni nel saggio introduttivo “...Thiel è uno dei più importanti venture capitalist della Silicon Valley, ma non insegue soltanto una linea di profitto: nutre una visione che ha scolpito e cesellato nel corso degli anni, partendo proprio dagli insegnamenti di Girard con cui ha studiato a Stanford”. Il saggio di Thiel, partendo dalle concezioni di Leo Strauss “...va oltre; e pur permanendo nell’equilibrio problematico, e oscuro, dettato da Strauss, lo legge e lo trasfigura nel prisma della mimesi di Girard, della teologia politica di Carl Schmitt, del tramonto dell’Occidente spengleriano”.
- Com’è noto – e ripetuto nel saggio, la critica di Strauss alla modernità si fondava su due argomenti principali: l’aver contestato/occultato/minimizzato l’antropologia negativa che connotava la filosofia – e ancor più la teologia-politica classica; e che ciò era avvenuto con l’Illuminismo (v. per tutti il “buon selvaggio” di Rousseau). A contrastare tale tesi Thiel ricorda le opere di tre pensatori del XIX secolo: lo stesso Strauss, Carl Schmitt, René Girard. Come esempio di compromesso tra concezione classica e moderna, l’autore indica Locke “La nuova scienza economica e la pratica del capitalismo hanno riempito il vuoto creato dall’abbandono della tradizione più antica. Questa nuova scienza ha trovato il suo più importante sostenitore in John Locke e il suo più grande successo pratico negli Stati Uniti, una nazione la cui concezione deve così tanto a Locke”.
- ...
- In effetti la privatizzazione della religione toglie ragioni di conflitto. Ma non totalmente, come prova l’11 settembre 2001. Ed anche Locke, nel secondo Trattato sul Governo, indica nell’“appello al cielo” del popolo, la risoluzione del conflitto politico interno (curioso che Thiel non lo noti): che così è il “caso d’eccezione” visto da una prospettiva democratica. Con l’attentato alle Twin Towers “una guerra di religione è stata portata in una terra che non si preoccupa più delle guerre di religione”.
- ...
- Da ciò deriva l’insopprimibilità del politico, della regolarità amico-nemico (Schmitt) del conflitto e della crisi mimetica (Girard), anche in una società moderna.
- ...
- Due considerazioni del recensore su questo interessante saggio. La prima: l’insopprimibilità del politico (e così del nemico, del comando, della lotta per il potere). Questa è oggetto della consapevolezza (nella modernità) di tanti (giuristi, in particolare); da Jhering a Santi Romano, da Maurice Hauriou a Radbruch e a Donoso Cortes, dalla concezione dello Stato liberale quale sintesi tra principi politici e principi dello Stato borghese di Schmitt, tra Machstaat e Rechtstaat. La seconda è che ogni Stato anche liberaldemocratico, si serve sia della forza che del diritto: pretendere di eliminare la prima comporta distruggere l’edificio, costruito per la pace e la sicurezza, anche attraverso il diritto e il monopolio della violenza legittima. A realizzare le quali è necessario avvalersi anche dei mezzi, come l’innovazione tecnologica, che la Silicon Valley rende disponibili. Sempre ricordando quello che scriveva De Maistre che l’uomo è in bilico tra due abissi: quello del caos e quello della tirannide: il percorso è difficile, ma è l’unico disponibile.
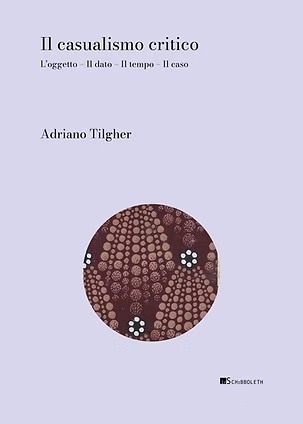
Il casualismo critico- L’ultimo volume del filosofo dimenticato
- Adriano Tilgher
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
Il pensiero italiano del secolo XX non è stata espressione minore, provinciale, del pensiero europeo, come nelle corde dell’esegesi storico-filosofica neo illuminista e/o marxista impostasi dopo il 1945. Al contrario, è stata una filosofia che si confrontò con aspetti teoretici a cui il pensiero continentale pervenne nei decenni successivi. Tra i pensatori italiani della prima metà del Novecento, un ruolo di protagonista spetta al troppo presto dimenticato Adriano Tilgher. La profondità e la crucialità, anche rispetto al tempo presente, della sua proposta speculativa emerge dalla lettura dell’ultimo volume al quale egli lavorò nella fase conclusiva della vita. Ci riferiamo a, Il casualismo critico. L’oggetto – Il dato – Il tempo – Il caso, da poco tornato nelle librerie per i tipi di InSchibboleth (per ordini: info@inschibbolethedizioni.com). La curatela del volume è del giovane e valente studioso Michele Ricciotti, che firma anche la contestualizzante prefazione. La postfazione è di Gianfranco de Turris, uno dei massimi esperti italiani del fantastico.- ...
- La prima edizione del testo è datata 1942, ma in realtà uscì nel 1941, quindi, come a suo tempo chiarito da Gian Franco Lami, Tilgher, deceduto nel novembre del 1941, poté vedere stampato il volume ed anzi, a testimoniare l’importanza che gli attribuiva, volle che una copia lo accompagnasse nel suo ultimo viaggio. L’argomentazione è articolata in quattro capitoli, come si evince dal sottotitolo. Nelle sue pagine, Tilgher torna, per l’ennesima volta, a fare i conti con Croce e con Gentile. Si tratta, infatti, di un volume che raccoglie alcuni scritti già comparsi su riviste e periodici, rielaborati e ripensati dal filosofo per l’occasione. Nel libro la dimensione polemica, tratto connotante vita e opere di Tilgher, si stempera in proposta teoretica definita e chiara. Ricciotti ricorda, opportunamente, come il pensatore fosse davvero ossessionato dal confronto con il contemporaneo (Guido Calogero scrisse, a riguardo, trattarsi di vero e proprio “entusiasmo” per il contemporaneo) e i problemi che esso presentava, sia sotto il profilo teorico, che dal punto di vista della prassi. Dopo l’incontro con la filosofia di Leopardi, discussa da Tilgher in un volume ancora attualissimo, nel pensatore partenopeo prevalse l’interesse per le morali e per la storia: «Tanto su un fronte […] quanto sull’altro, l’allontanamento dal pensiero di Croce […] si sancisce nella contestazione di uno storicismo orientato in senso ottimistico, nella rivendicazione della dimensione tragica», precisa il curatore (p. 9).
- ...
- Mentre Hegel, nel suo schema dialettico storicista: «non negava un certo ruolo al contingente […] lo “pseudoidealismo italiano” […] finiva […] per eliminare completamente la dimensione del contingente […] trovandosi sprovvisto di strumenti utili a spiegare il male […] il negativo nella storia» (p. 11). Croce sarebbe caduto, pertanto, in una sorta di provvidenzialismo; Gentile, di contro, con l’insistere sul primato dell’Atto, rendeva assoluto qualsivoglia evento, non potendo così aver contezza dell’unitarietà del processo storico. Di fronte a tale situazione, Tilgher mirò a “sprovvidenzializzare” la storia, a liberala dal determinismo. Il filosofo di Pescasseroli, con la “filosofia dei distinti”, aveva di fatto tacitato il possibile a vantaggio del necessario. Il possibile, a giudizio del filosofo del “pragmatismo trascendentale”, abita la vita. Gli essenti sono coinvolti, abbracciati dal misterium vitae. In, Filosofi e moralisti contemporanei, lo ricorda Ricciotti, Adriano scrisse che nell’esistere, leopardianamente inteso, è: «Il mistero in piena luce» (p. 16). L’esigenza di fondo che emergeva nella speculazione primo novecentesca rivendicava: «qualcosa di più concreto di ciò che l’articolazione concettuale del pensiero è in grado di esibire» (p. 17). Contingenza e singolarità non possono venir tradotte, in termini definitivi, in forma, in universale.
- ...
- Tilgher finì con il riproporre un tema fichtiano, quello dell’Anstoss, l’urto del dato, del concreto che impatta l’attività del pensiero, arrestandola e determinandola in uno. A differenza del’attualismo, egli ebbe chiara consapevolezza che il pensiero non vive, sic et simpliciter, di vita propria, ma è ciò che viene «costantemente urtato da “qualcosa” entrando in contatto con il quale il pensiero si anima» (p. 20). Oggetto, dato, tempo e caso non si lasciano ridurre, per Tilgher, ai moduli esegetici del filosofare logo-centrico. Alla luce di tale ermeneutica, il filosofo napoletano ritenne il neo idealismo espressione tipica del pensiero d’anteguerra. Giunse, più in particolare, a sostenere che l’attualismo era filosofia posticcia: «non originale e derivata» (p. 24). Giudizio, probabilmente, troppo severo, dettato dalla vis polemica connotante l’“equazione personale” di Tilgher. Nelle pagine de Il casualismo critico, egli difese il tratto indeducibile della singolarità, che lo indusse a sposare, in ambito politico, una sorta di liberalismo anarchico, aperto al possibile e alle visioni ucroniche della storia.
- ...
- Di esse, del loro affermarsi nel dibattito contemporaneo, in forza della catastrofe tragica cui gli storicismi sono andati incontro alla metà del secolo XX, si occupa, con persuasività di accenti e pertinenza argomentativa, Gianfranco de Turris nella postfazione. Il termine ucronia, ricorda, fu coniato da Charles Renouvier e allude a una storia immaginaria, diversa da quella che si è effettivamente fatta mondo: «destinata a porre come una vera verità filosofica e di coscienza, più alta della storia stessa, la reale possibilità», una possibile storia alternativa. La tesi ucronica, non casualmente, fu aspramente criticata proprio da Croce. L’ucronia mostra che un evento del passato avrebbe potuto verificarsi, a causa di episodi anche insignificanti, in modalità altra rispetto a quella testimoniata dal corso storico realizzatosi: «Gli autori di ucronie immaginano un tempo storico diverso, non soltanto […] un luogo diverso, […] un intero periodo temporale che avrebbe potuto essere altro da quello in cui loro stessi vivono […], se…» (p. 135).
- ...
- La vita è appesa perpetuamente al se, essa è esposta a un principio infondato, la libertà-potenza, la dynamis dei Greci, questo il “vero” che Tilgher ripropose nella prima metà del secolo scorso. Visione liberante, espressione non di un pensiero minore, ma lascito di un filosofo di vaglia, la cui visione delle cose è essenziale anche per i nostri giorni.
- Adriano Tilgher, Il casualismo critico. L’oggetto – Il dato – Il tempo – Il caso, a cura di M. Ricciotti, postfazione di G. de Turris, InSchibboleth, Roma 2025.
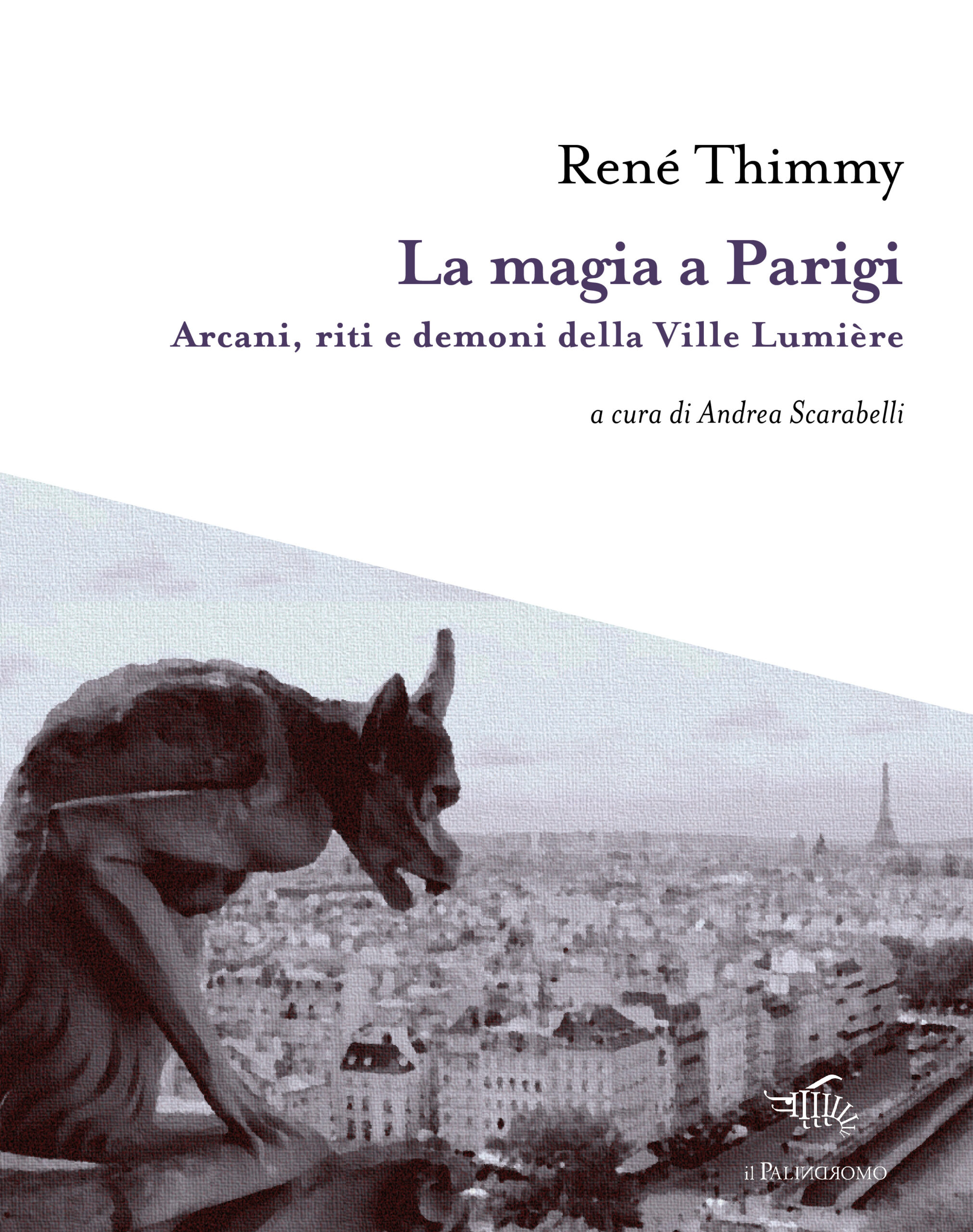
La magia a Parigi- di
- René Thimmy
- rec. di
- Giovanni Sessa
- È da poco nelle librerie un volume davvero curioso. Si tratta de, La magia a Parigi. Arcani, riti e demoni della Ville Lumière, comparso nel catalogo de il Palindromo (per ordini: info@ilpalindromo.it). L’autore è René Thimmy, mentre la curatela e la traduzione di questa prima edizione italiana, si devono ad Andrea Scarabelli. Questi firma un saggio contenuto nelle Appendici, che fa chiarezza sulla reale identità dell’autore. Il volume uscì in Francia nel 1934. Si tratta della silloge di una serie di reportage di Thimmy sulla Parigi delle confraternite esoteriche, delle sette occultistiche e dei maghi, che erano stati pubblicati, pochi mesi prima, sul settimanale «Gringoire». Nel trasporre gli articoli nel volume, l’autore mise in atto tagli e aggiunte. Scarabelli ha, con acribia da filologo, reintegrato i tagli e segnalato in nota le variazioni apportate al testo. Le note consentono, inoltre, di sciogliere i dubbi sui personaggi incontrati da Thierry nella sua inchiesta, in quanto nel libro i loro nomi sono, per discrezione, o indicati da una lettera puntata, o addirittura risultano modificati. Quella che presentiamo è un’edizione sobria ed elegante de La magia di Parigi, che propone le illustrazioni originali, nonché, cosa davvero rilevante, una mappa della Parigi dell’epoca con l’indicazione dei luoghi citati. Il volume è chiuso da tre racconti, assenti nell’edizione francese, ma usciti su «Gringoire» nel 1940, che avrebbero dovuto essere i primi capitoli di un nuovo lavoro dell’autore dedicato allo stesso tema.
- ...
- Le illustrazioni aiutano il lettore ad entrare nelle suggestive atmosfere di una Parigi misteriosa, specchio rovesciato e contraltare della Ville Lumière. Va precisato che Thimmy non ha i tratti psicologici del “devoto” settario, entra con scettica circospezione nel milieu magico-occultistico della Capitale transalpina. Lo si evince, in tutta evidenza, dal narrato: i fenomeni paranormali e i protagonisti stessi di questa Parigi segreta, sono descritti in modo, almeno in certi casi, sottilmente ironico. A introdurre René in questo mondo sotterraneo, così riferisce Thimmy nell’incipit de, La magia a Parigi, fu Eleuthère K., incontrato per caso in una libreria. Questi: «Aveva trascorso la vita a studiare fenomeni cui la maggior parte delle persone non presta alcuna attenzione […] sembrava essere senza età. Viveva da solo in un appartamento spoglio, letteralmente sommerso di preziosi manoscritti e libri rari» (p. 14). Eleuthère consentì al giornalista di accedere a cenacoli “chiusi”, sui quali vigeva il più assoluto riserbo: «molte delle vicende che mi accingo a raccontare suoneranno incredibili. Ma …sono vere. Da molto tempo sappiamo che il vero talvolta può non essere» (p. 15). Tra gli incontri straordinari narrati nel libro, articolato in ben diciannove capitoli, i più significativi ci paiono quelli con Maria de Naglowska, indicata con il falso nome di Vera de Petrouchka, praticante magia sexualis, e quello con la “Confraternita dei Polari”.
- ...
- Maria trascorreva le sue giornate in un caffè di Montparnasse. Quando era sola, il tavolino al quale sedeva era ricoperto da libri, opuscoli e dalle bozze della rivista «L’Arc» (in realtà «La Flèce», organo di azione magica della “Confraternita della Freccia d’oro”). Spesso, al suo fianco, sedeva una pattuglia di seguaci, di adepti, stregati dal magnetismo dei suoi occhi: «di un blu granitico e freddo […] Vivi e vispi sono illuminati da un fuoco interiore» (p. 69). De Naglowska praticava la magia sessuale nella convinzione che, attraverso i suoi riti, avrebbe risvegliato le forze: «sopite negli uomini in una materializzazione di sollievo passeggero» (p. 71). Era una ierofante in buona fede, incurante del denaro, la cui vita era completamente orientata verso la realizzazione spirituale. Di origini polacche, dopo la Rivoluzione, era sfuggita ai bolscevichi, aveva vissuto a Roma, dove aveva frequentato Julius Evola e, infine, si era trasferita a Parigi. Thimmy fu introdotto nel suo Cenacolo e poté assistere a pratiche di magia sessuale, il cui apice si sarebbe mostrato nella celebrazione della “messa d’oro”. Il rito si svolgeva in un ambiente ovattato, presso l’abitazione di una seguace della donna, nel quale, dopo libagioni a base di champagne e di etere, si svolgeva l’accoppiamento sacro. In realtà, il giornalista, forse a causa del suo scetticismo, non vide ciò che i partecipanti dissero di aver visto e sperimentato. La donna lo invitò di nuovo: sarebbe infatti giunto da Londra Lord F., che si diceva avesse conseguito il terzo grado dell’iniziazione satanica, attraverso il rito dell’impiccagione, pratica che veniva sospesa all’ultimo istante, prima del sopraggiungere della morte. L’uomo non giunse in Francia: durante l’ultimo rito da lui celebrato, aveva perso la vita.
- ...
- La “Confraternita dei Polari” era centrata sull’Oracolo della Forza Astrale. Di tale conoscenza era venuto in possesso, grazie all’incontro a Bagnaia con Padre Giuliano, Mario Fille che, in Egitto, ne aveva parlato con Zam Bothiva, autore di Asia Mysteriosa. L’Oracolo permetteva di entrare in contatto con Saggi ritiratisi sulle vette dell’Himalaya. Nella redazione di un giornale francese era stata convocata una riunione, cui parteciparono Guénon, ed altri insigni rappresentanti dell’esoterismo parigino. Questi appurarono, in prima battuta, la veridicità delle risposte fornite a distanza dai Saggi. Thimmy fu introdotto nella sede dei Polari. In essa era custodita una spada che si credeva essere appartenuta a Giovanna d’Arco, oltre alla bacchetta magica di Pico della Mirandola. Compito dei Polari era salvare la Francia e l’umanità intera dalla catastrofe incombente sul mondo. Il Nostro ricevette l’iniziazione dai Polari. Gli fu riferito che l’anno terribile sarebbe stato il 1933. Il disastro avrebbe trovato il proprio momento apicale nella notte del 6 febbraio 1934. Dall’Oriente sarebbe giunto un messo dell’oracolo, che in realtà non sbarcò mai in Europa.
- ...
- Ma chi era Thimmy? Scarabelli discute criticamente, con pertinenza argomentativa e significativa conoscenza della documentazione, le ipotesi fin qui avanzate dagli studiosi. Scarta le tesi dell’identificazione di Thimmy con Maurice Magre e con il medico ed etnologo Léon Sasportas. Conclude in questi termini, sulla scorta di motivate considerazioni: «Per quanto non vi sia la “prova provata” […] della vera identità dell’autore […] il quadro abbozzato la attribuisce in modo più che eloquente a Jean Dorsenne» (p. 276).
- ...
- Al di là del problema dell’identificazione dell’autore, La magia di Parigi, è volume di pregio perché coinvolge il lettore nel narrato e induce a guardare Parigi e la realtà con altri occhi. Uno sguardo non più centrato sulle idee chiare e distinte ma sul potere trasfigurante della fantasia.
TRUMP - e
- IL RATTO D’EUROPA
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
1.0 - Le reazioni indispettite delle èlite europee e della stampa loro allineata alle pagine che Trump ha dedicato all’Europa nel documento National Security Strategy 2025, non sorprendono: né per la reazione né nei di essa modi ed argomentazioni. D’altra parte anche le considerazioni del documento americano erano state in gran parte anticipate nelle precedenti esternazioni di Trump (e di Vance); peraltro, diversamente da quello che il Presidente USA afferma urbi et orbi, ossia tutto e il contrario di tutto a giorni alterni, il pensiero sull’Europa è stabile e immutato. I punti essenziali del quale sono di seguito riepilogati.
- ...
- 1) “L’Europa continentale sta perdendo quota nell’economia globale: è scesa dal 25% del PIL mondiale nel 1990 al 14% attuale — in parte a causa di regolamentazioni nazionali e sovranazionali che soffocano creatività e spirito d’iniziativa. Ma questo declino economico è superato da una prospettiva ancor più grave: quella della cancellazione civile” e questo perché le attività dell’U.E. e di altri organismi internazionali…” conculcano la libertà politica e la sovranità; ed adottano “politiche migratorie che stanno trasformando il continente e creando conflitti; censura della libertà di espressione e repressione dell’opposizione politica; crollo dei tassi di natalità; perdita delle identità nazionali e della fiducia in sé stessi. Se le tendenze attuali proseguiranno, il continente sarà irriconoscibile in 20 anni o meno”.
- ...
- 2) Il Presidente afferma di volere “che l’Europa rimanga europea, che ritrovi fiducia civile e abbandoni il suo fallimentare modello di soffocamento regolatorio”. Poi un’altra considerazione realistica “Gli alleati europei godono di un significativo vantaggio in termini di hard power rispetto alla Russia in quasi tutte le misurazioni, tranne che nelle armi nucleari”, perciò l’Europa gode di un vantaggio che dovrebbe impedire o almeno ridimensionare le (pretese) velleità egemoniche di Putin, se ne deduce.
- ...
- 3) “L’amministrazione Trump si trova in contrasto con funzionari europei che nutrono aspettative irrealistiche sulla guerra e governano in maggioranze instabili, molte delle quali calpestano principi democratici fondamentali per reprimere l’opposizione. Una larga maggioranza degli europei vuole la pace, ma questo desiderio non si traduce in politiche concrete, in larga parte a causa della sovversione dei processi democratici da parte di questi governi”.
- ...
- 4) Tuttavia “l’Europa rimane strategicamente e culturalmente vitale per gli Stati Uniti. Il commercio transatlantico resta uno dei pilastri dell’economia globale e della prosperità americana”, pertanto “La diplomazia americana deve continuare a difendere la vera democrazia, la libertà di espressione e la celebrazione senza complessi dei caratteri nazionali europei e della loro storia. L’America incoraggia i propri alleati politici in Europa a promuovere questa rinascita dello spirito, e la crescita dell’influenza dei partiti patriottici europei rappresenta effettivamente un motivo di grande ottimismo. Il nostro obiettivo deve essere aiutare l’Europa a correggere la sua traiettoria attuale… Vogliamo lavorare con paesi affini che desiderano restaurare la propria grandezza. Sul lungo periodo, è più che plausibile che entro poche decadi almeno alcuni membri della NATO diventeranno a maggioranza non europea”.
- ...
- 5) La migrazione incontrollata può alterare l’anima dell’Europa. Nelle nazioni ove la maggior parte della popolazione divenisse non europea “è una questione aperta se considereranno il proprio ruolo nel mondo — o la propria alleanza con gli Stati Uniti — nella stessa maniera di coloro che firmarono il Trattato NATO”.
- ...
- 6) Segue un elenco di priorità: Ristabilire condizioni di stabilità interna in Europa e stabilità strategica con la Russia; conseguire autonomia militare, invertire la rotta spirituale. Tra queste interessano soprattutto: “Rafforzare le nazioni solide dell’Europa centrale, orientale e meridionale tramite legami commerciali, vendite di armi, collaborazione politica e scambi culturali ed educativi; Porre fine alla percezione — e prevenire la realtà — di una NATO in espansione perpetua; Incoraggiare l’Europa a contrastare sovracapacità mercantiliste, furti tecnologici, cyber-spionaggio e altre pratiche economiche ostili”.
- ...
- 2.0
- I capisaldi del discorso di Trump sull’Europa e di tutto il documento, sono il realismo, il pragmatismo, il ridimensionamento (o il rifiuto) di contrapposizioni ideologiche: tipo quella spesso prediletta di democrazie contro autocrazie. Ossia il contrario (spesso) e, in genere, il diverso da quanto praticato dalle élite europee (al tramonto) nell’ultimo trentennio, anche ispirato dalle amministrazioni USA pre-Trump. D’altra parte che il capitolo sull’Europa s’intitoli “promuovere la grandezza europea” è anch’essa una considerazione realistica, per due motivi. Il primo che in un pluriverso, è essenziale selezionare i nemici e gli amici: se il nemico è un elemento insopprimibile, occorre provvedersi di amici, perché – come insegnato da millenni di storia, non ci si può contrapporre a tutti, pena la sconfitta e, al limite, l’autodistruzione. E tra i diversi soggetti politici (Russia, Cina, India) l’intesa è più facile con chi, come Europa e USA, appartengono alla medesima Kultur (civiltà): quella del cristianesimo occidentale, con la separazione di Chiesa e Stato, di questo dalla società civile, del popolo e dei suoi rappresentanti, della libertà e delle proprietà garantite (anche nei confronti dei poteri pubblici).
- ...
- 3.0
- Dove la critica di Trump coglie nel segno è nel notare come la pratica governativa della maggior parte dei paesi europei abbia contraddetto gran parte dei principi della civiltà euro-occidentale e della capacità di ripresa. In primo luogo con la perdita del rapporto tra vertice politico (governanti) e seguito (in senso lato i governati), il cui segno più evidente è il moltiplicarsi di governi populisti o comunque non allineati alle vecchie élite, in particolare nell’Europa “centrale, orientale e meridionale”. Ma risulta anche laddove i governi “nuovi” non hanno conseguito la maggioranza negli organi governativi, ma l’hanno tra gli elettori, con la conseguenza della difficile governabilità, come in Francia (malgrado la prevalenza nella quinta Repubblica del pouvoir minoritaire presidenziale-governativo). Mentre nel contempo la dirigenza europea esercita pressione sui governi non allineati, malgrado eletti (e confermati) da maggioranze popolari (come l’Ungheria di Orban) o cercando di non condannare, anzi di agevolare la manomissione del procedimento elettorale (come in Romania). Tutte pratiche aventi in comune la debolezza di élite dal consenso scemante; ovviamente riuscendo sempre meno a raggiungere lo scopo. In secondo luogo l’irrealismo di certe politiche: cominciarndo col far passare la Russia come nemica principale, quando è evidente che Putin non ha l’intenzione, e a ben vedere neppure la forza di invadere l’Europa centrale ed occidentale in un conflitto convenzionale (l’uso della superiorità nucleare russa appare ancor più irrealistico). O quello di europeizzare masse di migranti, in particolare islamici: poco propensi ad abiurare. O perseguire obiettivi (Green Deal) in modo autolesionistico (per l’economia). Inoltre Trump nota il tafazzismo europeo quando, invece dell’orgoglio delle proprie civiltà, istituzioni, valori e cioè della propria identità, ne prova quasi vergogna (qua, però, l’esempio è venuto dagli USA e dalla cancel culture).
- ...
- Le proposte del documento sull’Europa hanno anche un effetto ironico: dopo che le élite europee avevano favorito l’estensione della NATO (e dell’UE) agli Stati dell’Europa orientale, proprio dall’America viene il prudente (ed evidente) consiglio di non espanderla (dato a suo tempo da tanti altri, tra cui Kissinger). Così con i tromboni italiani che hanno auspicato la riduzione della sovranità nazionale – cominciando del “vincolo esterno” – e “guerrafondai” europei (italiani compresi) tutti compiaciuti di aiutare gli ucraini a combattere una guerra (persa) a danno dei combattenti e a spese degli europei, che proprio dal referente principale arrivi il consiglio a calmare i bollenti spiriti e a pensare più realisticamete, è sintomatico dell’inadeguatezza di élite decadenti. Alle quali ciò che (più verosimilmente) dispiace del documento è l’incoraggiamento ad alleati politici e partiti patriottici; suona come un preavviso di sfratto alle élite. Cosa che ovviamente non sopportano e pour cause: avendo collezionato talvolta sconfitte e talaltra risultati mediocri, non resta loro che consolarsi con l’esercizio del potere.
- ...
- E’ il potere per il potere, in luogo del potere per uno scopo (l’interesse generale, della comunità). Ma non vogliono che lo si “racconti in giro” come ha fatto Trump. E per questo fanno passare le critiche del Presidente americano per spirito antieuropeo nel senso delle comunità, quando il bersaglio ne sono le élite europee decadenti.
- GUERRA IBRIDA, NOVITA’?
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Da qualche anno si è diffuso il termine “guerra ibrida” che vuole significare la compresenza, in un confronto ostile, di condotte di guerra “classica” con altre accomunate dall’assenza di violenza: sanzioni economiche, propaganda, attacchi informatici. Qualcuno vorrebbe identificarla come il modo di guerra del XXI secolo. Senonché a (parziale) rettifica della “modernità” di tale tipo di guerra, alcuni di tali elementi non violenti sono praticati da secoli. Le sanzioni economiche soprattutto possono essere particolarmente efficaci: è opinione diffusa che se Roosevelt non avesse fatto seriamente rispettare le sanzioni contro il Giappone (come ad un certo momento fece) il Giappone avrebbe dovuto ritirarsi dalla Cina (al più tardi) nel 1943. Altri aspetti invece sono del tutto nuovi (ad esempio gli attacchi informatici), ma solo perché non c’erano i computer, così come la guerra aerea è nata solo con gli aeroplani (e il loro impiego militare).
- ...
- Se si rimane fermi al concetto tradizionale di guerra cioè di confronto violento tra sintesi politiche con formazioni organizzate militarmente e provviste di strumenti idonei alla distruzione fisica del nemico, che si fonda sugli aspetti più appariscenti del fenomeno bellico, indubbiamente l’uso del termine guerra, per gli attacchi ibridi, appare una forzatura. Ma se, come spesso mi capita di scrivere, ci si rifà al concetto che ne avevano pensatori come Clausewitz e Gentile, ossia che la guerra è un mezzo per costringere il nemico a fare la nostra volontà, quella forzatura non è tale o comunque appare secondaria.
- ...
- Già negli anni 30 del secolo passato Carl Schmitt scriveva che “il concetto di guerra si è nel frattempo molto modificato. Intanto esso non si esaurisce più nella lotta militarmente armata, ma vi è anche una attività extra-militare nelle ostilità, poiché la guerra diventa guerra economica, guerra di propaganda”, e riteneva che aveva ragione Chamberlain a dichiarare, nella primavera del 1939, che non si era né in guerra, né in pace, malgrado la guerra sarebbe stata dichiarata parecchi mesi dopo.
- ...
- La nota intervista dell’ammiraglio Cavo Dragone ha rinfocolato il dibattito sul tema, con relativa confusione derivante dal termine “guerra”. Può apparire corretto per quella ibrida solo se lo si usa nel senso di Clausewitz e Gentile ma suscita allarmi se non inteso in tal senso. Ciò stante a leggere sulla stampa le dichiarazioni dell’Ammiraglio di essere più aggressivi sulla cibersicurezza, siamo ancora nei limiti di una risposta proporzionata: un hacker, un hacker e mezzo avrebbe detto Napoleone se avesse avuto i computer. Quello che invece sarebbe assai imprudente è replicare con bombe e missili ad un attacco informatico. Le prese di posizione di Tajani e della Kallas, questa che ha parlato di sanzioni “ibride” per “contrastare gli attacchi ibridi” (quindi una difesa omogenea all’attacco) e quello che ha richiamato alla “difesa da una guerra ibrida”, invocando alla prudenza, hanno correttamente interpretato il senso dell’intervista dell’ammiraglio.
- ...
- Resta comunque il fatto che, da secoli la guerra si fa non solo con le azioni e il confronto diretto, ma in varie forme e tipi, compreso quello per procura in cui dietro i belligeranti apparenti c’è una lotta di potenza tra quelli occulti, che sostengono, soprattutto sul piano economico, il proprio alleato. Richelieu finanziò la lotta antiasburgica dei protestanti per i primi diciassette anni della guerra dei trent’anni, prima d’intervenire direttamente, costretto dalla sconfitta disastrosa dei propri alleati a Nordlingen. C’è da sperare quindi, dato questo (e altri) precedenti, che la Russia non vinca troppo. Soprattutto per non ringalluzzire i nostri guerrafondai.
- SEMPRE I SOLITI
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Le ultime occasioni di dibattito pubblico interno e cioè quella sulla patrimoniale e l’altra sulle esternazioni a tavola dall’on. Garofani hanno un carattere comune: di manifestare le costanti di comportamento del centrosinistra italiano. Di guisa da renderle verosimili, anche se non fosse stata (quella sulla necessità d’impedire la vittoria della Meloni alle prossime elezioni politiche) confermata dall’esternatore.
- Cos’ha detto l’on. Garofani? A quanto si legge sui giornali che, a distanza di meno di due anni dalle elezioni non c’è tempo per trovare un candidato-premier idoneo, onde per battere la Meloni servirebbe “un provvidenziale scossone”.
- Prospettiva preoccupante perché negli ultimi anni gli scossoni sono stati non dipendenti dalla volontà degli italiani e delle forze politiche nazionali, ma ricordano i quattro cavalieri dell’Apocalisse: la peste (il Covid); le guerre (Ucraina e Gaza), e queste due guerre ci hanno riportato la morte. Manca la fame, ma non è escluso che, con gli auspici dell’on. Garofani, non si rifaccia viva, per propiziare la fuoriuscita della Meloni. In fondo cos’è una piccola carestia, a fronte di un risultato così provvidenziale (per il centrosinistra)?
- Che buona parte dei dirigenti pubblici nominati dai governi precedenti cerchino di sdebitarsi, remando contro il governo, e diventando così dei partisan (senza la bi) è evidente, ma conoscendo il dettato dell’art. 97 della Costituzione, cercano di farlo sotto traccia, senza chiacchiere da bar o da salotto.
- Ai tempo della Riforma, si chiamava nicodemismo. Invece Garofani ha contraddetto questa prassi e il consiglio di Machiavelli di parere (e non di essere) buono, devoto, legale, legittimo, ma soprattutto imparziale come prescrive l’art. 97 della Costituzione.
- Una delle conferme che può quindi trarsi da questa vicenda, del tutto in linea con i precedenti (i ribaltoni anti-Berlusconi del 1994 e del 2011) è che, come scriveva Pareto, le classi dirigenti in decadenza si servono più dell’astuzia che della forza: manovre di corridoio, inciuci, finti scandali e vere calunnie sono gli espedienti preferiti per mantenersi al potere. Ciò per compensare la riduzione del potere (e dell’esercizio della forza) conseguente allo scemante consenso dei governati.
- In questo Garofani ha perfettamente ragione: una legge elettorale, abilmente sfruttata, può capovolgere i risultati di una votazione persa o dubbia. Come avvenuto nel 1996 e nel 2006.
- Anche l’altro tormentone mediatico sulla patrimoniale è in linea col pensiero del P.D. e non solo, come detto, con quello comunista. Se così fosse, ci sarebbe meno da preoccuparsi, perché finito il comunismo non resterebbe che aspettare la fine delle conseguenze.
- Ma purtroppo non è così, confermato dalle recenti vicende italiane e dal sistema fiscale la cui maggior imposta patrimoniale, cioè l’IMU, è stata decisa dal governo Monti, non comunista, anzi tutt’altro, “tecnico” e non “politico”. I cui mediocri risultati e le politiche che li hanno causati sono stati continuati dai governi di centro sinistra che li hanno fatti propri. Come ritenuto dal pensiero politico economico realista (e liberale) dell’ultimo secolo (abbondante) la finanza pubblica può essere predatoria, parassitaria o anche mutualistica.
- Di tali tipi non ripeto i criteri distintivi, resta comunque la stretta vicinanza tra assetto predatorio e imposta patrimoniale accomunati dal fatto che come in quello lo sfruttamento dei governati è tale da intaccare la capacità contributiva in misura superiore al reddito ricavabile (e così peggiora la situazione economica dei sudditi); nella seconda, proprio perché rapportata al patrimonio e non al reddito la suddetta conseguenza è del tutto irrilevante sul gettito ricavato.
- Quindi per le classi dirigenti una rendita assicurata che la sinistra giubilante associa alle solite belle parole come sempre proclamate perché nascondono pessimi comportamenti.
- E proprio questa è la novità del caso Garofani (almeno): che pratiche del genere sono tenute rigorosamente riservate, e se possibile segrete. Mentre il consigliere del Quirinale le ha tranquillamente esternate in allegra compagnia: per un congiurato (lo si sarebbe chiamato, in altri tempi) atteggiamento quanto mai imprudente.
- Carlo Galli
- Tecnica
- (Il Mulino, Bologna 2025, pp. 170, € 16,00)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Quali contemporanei ci confrontiamo quotidianamente con la tecnica – e ancor più col progresso tecnico – che ci cambia la vita sotto ogni aspetto. Dalla comunicazione alla salute, dalle abitudini al lavoro e al tempo libero. Questo saggio ne cura in particolare uno, quello decisivo, il rapporto tra tecnica e potere e come quella condizionasse questo, agevolandone l’opera o sovvertendo. Partendo dalla sua ineluttabilità.
- ...
- Scrive l’autore che non vi è cura per la tecnica, perché fa parte del modo di esistenza umano, è un fare produttivo: “...la tecnica costituisce l’essere umano e la stessa storia della specie umana, ma è anche capace di minacciare l’umanità”. Ciò perché è “neutra” nel senso che non determina i fini, ma è un mezzo: può servire a fare antibiotici come la bomba atomica: “La tecnica è indispensabile ma non è neutra, non può esserlo – e quindi non è possibile una tecnocrazia: il kratos non è della tecnica ma di chi la produce e la impiega. La tecnica è sempre trascinata all’interno di polarità e conflitti, storici ed intellettuali: fra politica e burocrazia, fra azione e fabbricazione, fra tradizione e progresso”.
- ...
- Per orientarsi sul tema Galli propone due coordinate essenziali: la prima che la tecnica va pensata come azione orientata all’utilità, cioè al profitto e alla potenza; “La seconda è che il pensiero si forma attraverso il fare, che esige la relazione col pensato, ma al tempo stesso il pensiero trascende il pensato se non altro perché è capace di pensare sé stesso e la propria origine. Il pensiero non è disincarnato ma anzi è «concreto»”.
- ...
- La connessone con la politica e l’economia fa si che ci sia sempre una politica (e una geopolitica) della tecnica. Perché nella tecnica “...non c’è solo l’elemento strumentale: vi sono compresi anche il Saper fare, il Voler fare, il Poter fare. Ovvero, nella tecnica sono presenti fattori epistemologici, economici, politici”. La coessenzialità di tecnica e natura umana è nel costruire ma anche nel criticare, nel co-determinare le azioni umane; implica che la “...tecnica è necessaria alla definizione dell’umanità, ma non è sufficiente. La ragione tecnica è un universale parziale, ovvero non è tutta la ragione: c’è un’eccedenza, ed è il pensiero che pensa quella ragione”.
- ...
- Un pensiero interessato, ma non solo strumentale che ri-orienta l’azione. A questo è dedicato il terzo capitolo in cui Galli mostra “...i molti modi con cui la filosofia ha messo in rapporto la tecnica, il sapere e l’agire, la realtà naturale e l’artificio, e con cui ha reagito alla moderna esondazione della tecnica, estesa a ogni ambito della società e delle mentalità”; con soluzioni che vanno “...dal massimo di estraneità fra teoria e fabbricazione, quindi, fino al massimo di immanenza”. Il libro conclude con due tesi.
- ...
- La prima è che il dominio che si realizza “...non è della sola tecnica come strumentale fabbricazione: è dominio di una forma concreta, storica, di combinazione fra sapere pratico, politica, economia, comunicazione. Quando ci accorgiamo di servire la tecnica e il suo nichilismo, o i suoi simulacri, possiamo quindi capire che stiamo servendo il profitto o la potenza di qualcuno: non è l’impersonale ma persone”.
- ...
- La seconda, collegata alla prima è che così esiste “...lo spazio della critica e la possibilità dell’agire politico, che vada al di là di quel fabbricare che ci sta fabbricando”. E Galli prosegue: “Quelle due tesi, combinate, sono insomma un invito alla «critica della tecnica»"
- …
- Una critica realistica (un «realismo critico») che esige capacità di vedere le contraddizioni tra universalità e parzialità, fra progresso e dominio… "...la cui esistenza e consistenza è il vero problema – non tanto dalla tecnica quanto dalle coazioni del sistema sociopolitico di cui questa è l’espressione storica concreta”.
- ...
- Due notazioni del recensore a margine di un saggio esauriente e attuale.
- ...
- La prima: a differenza delle concezioni tecnocratiche, non c’è soluzione tecnica valida a prescindere dai fini cui è indirizzata. Cioè buona, auspicabile, voluta (da chi i fini determinava). Il che significa che i presupposti del politico (comando/obbedienza; pubblico/privato; amico/nemico) rimangono immutati e pure se condizionati dalla tecnica, non se sono detronizzati.
- ...
- La seconda che perciò non c’è una tecnocrazia quale forma politica (come monarchia, aristocrazia, democrazia); c’è una conformazione dell’organizzazione pubblica alla novità delle situazioni, tra cui – numerosissime – quelle risultanti dallo sviluppo tecnico. La contraria convinzione già criticata da Croce con ironia è costantemente smentita dal fatto – peraltro energicamente sostenuto da Galli – che è sempre un “modello”, a servizio di un potere (a cui risponde). E che sotto una apparente oggettività finisce per conculcare la soggettività degli individui e delle loro formazioni sociali, con il tramonto di ogni libera prospettiva di piena comprensione di un mondo di cui questi abbiano “...piena comprensione e responsabilità”.
- SEMPRE I SOLITI
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Le ultime occasioni di dibattito pubblico interno e cioè quella sulla patrimoniale e l’altra sulle esternazioni a tavola dall’on. Garofani hanno un carattere comune: di manifestare le costanti di comportamento del centrosinistra italiano. Di guisa da renderle verosimili, anche se non fosse stata (quella sulla necessità d’impedire la vittoria della Meloni alle prossime elezioni politiche) confermata dall’esternatore.
- ...
- Cos’ha detto l’on. Garofani? A quanto si legge sui giornali che, a distanza di meno di due anni dalle elezioni non c’è tempo per trovare un candidato-premier idoneo, onde per battere la Meloni servirebbe “un provvidenziale scossone”. Prospettiva preoccupante perché negli ultimi anni gli scossoni sono stati non dipendenti dalla volontà degli italiani e delle forze politiche nazionali, ma ricordano i quattro cavalieri dell’Apocalisse: la peste (il Covid); le guerre (Ucraina e Gaza), e queste due guerre ci hanno riportato la morte. Manca la fame, ma non è escluso che, con gli auspici dell’on. Garofani, non si rifaccia viva, per propiziare la fuoriuscita della Meloni. In fondo cos’è una piccola carestia, a fronte di un risultato così provvidenziale (per il centrosinistra)?
- ...
- Che buona parte dei dirigenti pubblici nominati dai governi precedenti cerchino di sdebitarsi, remando contro il governo e diventando così dei partisan (senza la bi) è evidente, ma conoscendo il dettato dell’art. 97 della Costituzione, cercano di farlo sotto traccia, senza chiacchiere da bar o da salotto. Ai tempo della Riforma, si chiamava nicodemismo. Invece Garofani ha contraddetto questa prassi e il consiglio di Machiavelli di parere (e non di essere) buono, devoto, legale, legittimo, ma soprattutto imparziale come prescrive l’art. 97 della Costituzione.
- ...
- Una delle conferme che può quindi trarsi da questa vicenda, del tutto in linea con i precedenti (i ribaltoni anti-Berlusconi del 1994 e del 2011) è che, come scriveva Pareto, le classi dirigenti in decadenza si servono più dell’astuzia che della forza: manovre di corridoio, inciuci, finti scandali e vere calunnie sono gli espedienti preferiti per mantenersi al potere. Ciò per compensare la riduzione del potere (e dell’esercizio della forza) conseguente allo scemante consenso dei governati. In questo Garofani ha perfettamente ragione: una legge elettorale, abilmente sfruttata, può capovolgere i risultati di una votazione persa o dubbia. Come avvenuto nel 1996 e nel 2006. Anche l’altro tormentone mediatico sulla patrimoniale è in linea col pensiero del P.D. e non solo, come detto, con quello comunista. Se così fosse, ci sarebbe meno da preoccuparsi, perché finito il comunismo non resterebbe che aspettare la fine delle conseguenze. Ma purtroppo non è così, confermato dalle recenti vicende italiane e dal sistema fiscale la cui maggior imposta patrimoniale, cioè l’IMU, è stata decisa dal governo Monti, non comunista, anzi tutt’altro, “tecnico” e non “politico”. I cui mediocri risultati e le politiche che li hanno causati sono stati continuati dai governi di centro sinistra che li hanno fatti propri. Come ritenuto dal pensiero politico economico realista (e liberale) dell’ultimo secolo (abbondante) la finanza pubblica può essere predatoria, parassitaria o anche mutualistica.
- ...
- Di tali tipi non ripeto i criteri distintivi, resta comunque la stretta vicinanza tra assetto predatorio e imposta patrimoniale accomunati dal fatto che come in quello lo sfruttamento dei governati è tale da intaccare la capacità contributiva in misura superiore al reddito ricavabile (e così peggiora la situazione economica dei sudditi); nella seconda, proprio perché rapportata al patrimonio e non al reddito la suddetta conseguenza è del tutto irrilevante sul gettito ricavato. Quindi per le classi dirigenti una rendita assicurata che la sinistra giubilante associa alle solite belle parole come sempre proclamate perché nascondono pessimi comportamenti.
- ...
- E proprio questa è la novità del caso Garofani (almeno): che pratiche del genere sono tenute rigorosamente riservate, e se possibile segrete. Mentre il consigliere del Quirinale le ha tranquillamente esternate in allegra compagnia: per un congiurato (lo si sarebbe chiamato, in altri tempi) atteggiamento quanto mai imprudente.
-
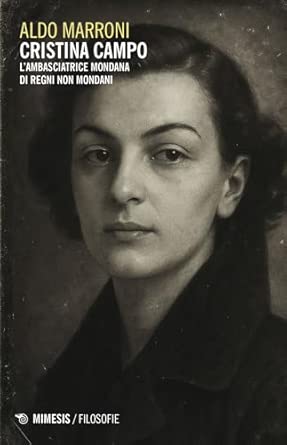
Cristina Campo- ambasciatrice di regni non mondani
- Un saggio di
- Aldo Marroni
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Cristina Campo (1923-1977) è stata scrittrice e poetessa di grande valore che, dato l’universo ideale che trascrisse nelle sue opere, è stata trascurata dalla critica e marginalizzata dalla cultura ufficiale. Finalmente dei suoi scritti e della sua vita si comincia a discutere con persuasività di accenti. Lo mostra il bel saggio di Aldo Marroni, già docente di Estetica e autore di un numero considerevole di volumi e saggi di rilevo, Cristina Campo. L’ambasciatrice mondana di regni non mondani, da poco nelle librerie per i tipi di Mimesis (per ordini:02/24861657, mimesis@mimesisedizioni.it).
- ...
- Il libro si articola in cinque densi capitoli ed è connotato dalla notevole capacità scrittoria dell’autore. Dalle sue pagine il lettore può trarre molte notizie significative sull’affascinante personalità della Campo e, soprattutto, cogliere la profondità, inattuale e antimoderna, del suo pensiero complesso, articolato, anagogico e strutturato in modalità spiraliforme attorno a un centro, la tensione per l’origine.
- ...
- Nella prima parte del testo, Marroni si sofferma sul rapporto tra malattia e salute nella pensatrice. Campo, infatti, angustiata fin dall’infanzia da malattia e dolore (cardiopatia) seppe trarre, in modo inspiegabile, da tale conflitto, l’alimento della propria creatività. Tale contesto, lo si evince non solo nei libri pubblicati ma, in modalità ancor più evidente, negli epistolari intrattenuti con amici e sodali del milieu intellettuale della metà del secolo scorso, quali Leone Traverso, Andrea Emo, Margherita Pieracci Harwell, soprannominata da Cristina “Mita”: «La vita spirituale e quella materiale, vi appaiono scontornati e come refusi entro uno stie di vita, di pensiero e di lavoro intellettuale impareggiabili» (p. 10).
- ...
- Da Simone Weil, Campo apprese che la malattia è dono divino di cui profittare per sporgersi sulle profondità della vita. Seppe, la nostra scrittrice, che la dicotomia malattia-salute altro non è che trascrizione del dualismo imposto alla cultura europea dal trionfante logo-centrismo escludente. Un bavaglio imposto a creatività e immaginazione, che non consente di cogliere il flusso animico che pulsa in tutto ciò che vive. La valorizzazione del dolore a scopo realizzativo fu esperito in profondità, ricorda Marroni, da Pascal, Nietzsche, Proust ed Ernst Bloch, che affermò: «pensare è varcare le frontiere» (p. 17).
- ...
- Il filosofo romeno Noica seppe, al pari di Campo, che malattia e dolore sono, per l’uomo, pungoli ontologici. Si badi, sostiene Marroni, non si tratta di capovolgere la valorizzazione della salute in assolutizzazione del malattia, in quanto solo cogliendo: «l’attitudine fluttuante delle due condizioni» (p. 29) si entra nel misterium vitae, nell’ enigma dell’ex-sistere, dello “star fuori dal principio”, che risulta essere, a ben vedere, condizione di mera apparenza. Nei molti si dice sempre il medesimo Uno. La poesia di Campo: «nasce da una religiosità che non potrebbe esistere senza il dolore» (p. 37), il suo dire è preghiera di una mistica senza misticismo, che sente di non appartenere all’età in cui ebbe in sorte di vivere.
- ...
- Il suo iter spirituale la condusse a scoprire il valore disvelativo della parola, capace: «di squarciare il velo dell’assoluto conservandolo nella sua alterità» (p. 39). Fu, in questo, come gli autori che amò, imperdonabile. Decisivo risultò l’incontro con lo psicanalista junghiano Ernest Bernhard, autore di Mitobiografia. Questi le fece comprendere che l’origine, la libertà può, stoicamente, essere vissuta: «entro un’amorosa necessità» (p. 47). È necessario conoscere e accettare il proprio destino, amor fati. Il destino di Cristina passava dall’incontro con la malattia, sublimata nella scrittura perfetta. L’entelechia individuale aristotelica, con la quale Bernhard corresse Jung, infatti: «contiene […] il veicolo della forza creativa universale che […] si vuole […] realizzare» (p. 47). Ma, rileva Campo: «I fiori non si apriranno se ci si aspetta che s’aprono, ciò avverrà da sé quando il tempo sia maturo» (p. 53). Lo stigma del Deus absconditus, al quale la scrittrice mirò con tutte le forze, sta nel rivelarsi ritraendosi. Dio e la scrittura stessa, si configurano, in questo itinerarium mentis in Deum, quale rischio estremo.
- ...
- Il tratto aristocratico della Campo, tradusse il far letteratura quale strumento atto a concedere solitudine esclusiva. La scrittrice si sottrasse alla dimensione mercantile, alla ricerca di lettori, che connota le arti nel nostro tempo. La sua parola intransitiva, simile a quella dei Padri del deserto, si pone quale metaxù, “in-tra”, al centro tra uomo e dio, tra corpo e spirito. Tale visione la indusse, nota Marroni, a scelte altre da quelle messe in campo dalla Chiesa cattolica con il Concilio Vaticano II, che Campo criticò aspramente in un manifesto firmato da molti intellettuali degli anni Sessanta. Poesia, preghiera e rito dicono il medesimo. La liturgia latina e tradizionale del Cattolicesimo era, a suo dire, strumento disvelativo che non poteva esser abolito senza colpire al cuore l’intero impianto trinitario della Chiesa. Da qui il suo apprezzamento per il Cristianesimo orientale, la sua frequentazione del Collegio “Russicum” di Roma. La liturgia, per la poetessa, preservava lo “splendore gratuito” e lo “spreco delicato”, salvandolo dalla degradazione nel profano. La tradizione Ortodossa ha creato la possibilità per Dio di nutrire i sensi e di abitare i corpi. I Padri del deserto conobbero i sensi soprannaturali. Le icone, grazie ad essi, sono immagini nient’affatto vuote, il mistero dell’incarnazione ha legittimato, di contro all’iconoclastia, la raffigurazione del divino, le icone sono realissime Porte regali.
- ...
- La scrittura della Campo si fece, per questo, fotografica, “scrittura di luce”, capace di ospitare l’attenzione per l’origine. Il suo “dire” in continua tensione verso il principio, è esposto, in forza dell’attenzione stoica, al divino che ci anima. Si tratta di scrittura cerimoniale, che allude alla possibilità dell’impossibile, messa in scena dalla fiabe. Vittoria Guerrini (Campo) utilizzò una serie disparata di eteronimi: non siamo questo o quello, meri enti, ma origine. Gli eteronimi attestano diversi punti di vista dai quali l’origine può essere osservata e vissuta. La fiaba è il centro vitale del pensiero della Nostra. Si tratta del: «crocevia mistico ove la sorte […] ha deciso di far incontrare in un ideale simposio, perfezione, attenzione, sapore massimo della parola» (p. 148).
- ...
- Il narrato della fiaba mostra la sconfitta della necessità statuita dal principio d’identità, mette in luce il primato del possibile, come avviene nella tessitura dei tappeti tradizionali i cui nodi dicono l’intrecciarsi dei destini individuali e cosmici. Non casualmente, nel racconto-non racconto, Il nodo di Salomone, Campo mostra l’:«unione tra l’uomo e il divino» (p. 161), esperibile attraverso i sensi soprannaturali. La scrittrice fu davvero, come si legge nel sottotitolo del volume, ambasciatrice mondana di regni non mondani.
- Aldo Marroni, Cristina Campo. L’ambasciatrice mondana di regni non mondani, Mimesis, pp. 183, ero 14,00.
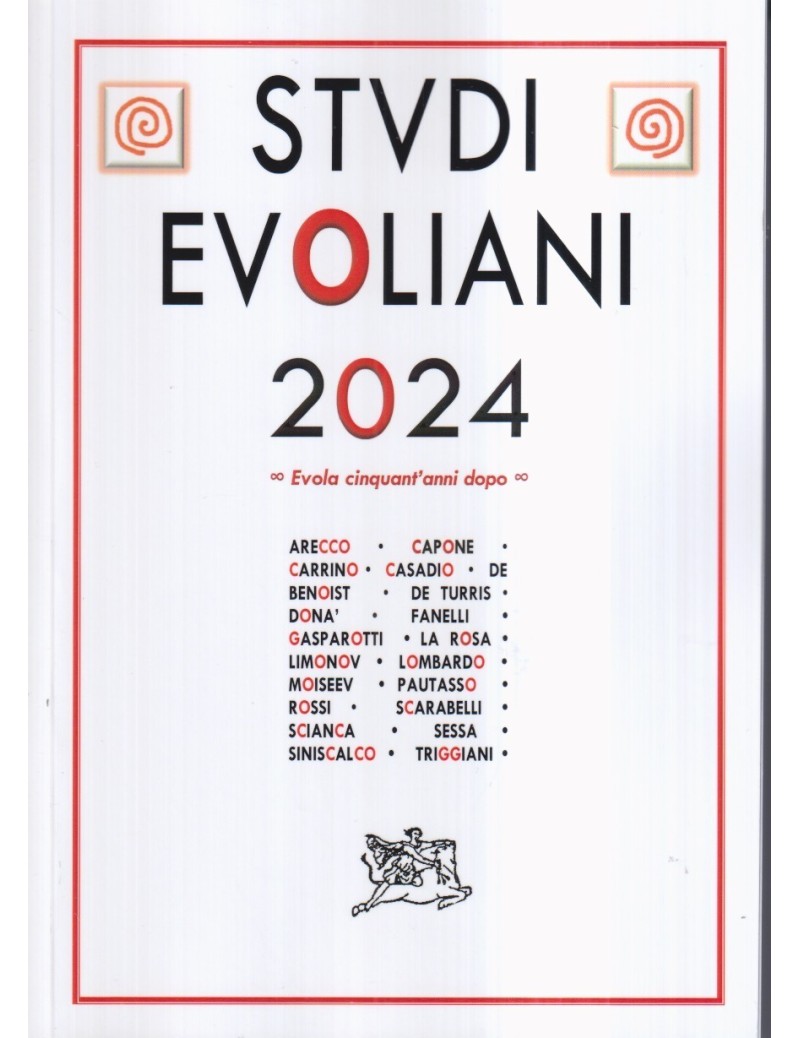
Pubblichiamo la Nota Editoriale - di
- “Studi Evoliani 2024”
- Il 2024 è stato un anno cruciale per gli studi su Julius Evola e le attività della Fondazione che a lui si riferisce. Nella Nota che apriva l’ultimo annuario si era già detto di alcune iniziative editoriali e convegnistiche progettate e attuate per ricordare degnamente il cinquantenario della morte del filosofo. Tale lavoro di diffusione del pensiero tradizionale è proseguito anche in seguito, con la pubblicazione di una serie di volumi rilevanti per l’esegesi dell’intero iter speculativo e pratico del pensatore romano.
- ...
- Primo per ordine e importanza, il Catalogo ragionato dell’opera pittorica evoliana, uscito dalla prestigiosa casa editrice Electa e impeccabilmente curato da Guido Andrea Pautasso. Un lavoro certosino, che segna il punto d’arrivo della ricerca e degli studi compiuti dal Comitato Scientifico per Evola Artista, costituito nel 2021 per volontà della Fondazione e di cui sono membri Gianfranco de Turris, lo studioso delle avanguardie artistiche del Novecento G. A. Pautasso, il critico Carlo Fabrizio Carli, nonché i professori Francesco Tedeschi e Paolo Campiglio. Al curatore e ai due docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, rispettivamente di Milano e Pavia, si devono i saggi critici che accompagnano le opere pittoriche, la raccolta più completa sinora realizzata. La lettura del Catalogo mostra, nella sua complessità, quanto il percorso artistico di Evola sia aperto a nuove esegesi e possa dar luogo a svariate suggestioni tematiche, come si evince anche dalla presenza di alcuni dipinti rintracciati negli ultimi anni presso collezioni private.
- ...
- Di grande importanza, tanto per gli studiosi quanto per i lettori comuni, risulta la pubblicazione della prima edizione anastatica di Rivolta contro il mondo moderno (Hoepli, 1934) uscita per Edizioni Mediterranee nella collana Opere di Julius Evola, diretta da de Turris, che dagli anni Novanta si occupa dell’edizione critica dell’intero corpus evoliano. Come già messo a fuoco dagli studi pionieristici di Roberto Melchionda, questa prima versione è molto diversa dalle successive (1951, 1969) per struttura, linguaggio e contenuti. Ecco perché la sua lettura risulta imprescindibile – come chiariscono i saggi introduttivi di Andrea Scarabelli e Giovanni Sessa – per chiunque voglia avere un quadro definito e organico della proposta evoliana.
- ...
- Per la stessa ragione, segnaliamo l’anastatica della prima edizione di Râaga Blanda. Composizioni 1916-1922, anch’essa edita da Mediterranee. Il saggio di Giorgio Calcara immette nelle vive cose della poetica ermetica di Evola, mentre la postfazione di Giovanni Canonico, che di Evola fu editore e amico, consente di decifrare l’equazione personale del pensatore, in particolare la sua generosità umana.
- ...
- Sempre nel 2024 è uscita – per la prima volta nella sua interezza – una delle più importanti monografie dedicate alla filosofia evoliana: Il volto di Dioniso. Filosofia e arte in Julius Evola di Roberto Melchionda, edito da L’Arco e La Corte di Bari. Il volume, curato da Andrea Scarabelli e Giovanni Sessa, è arricchito dalla prefazione di Giovanni Damiano e dalla postfazione di Massimo Donà. Uscito per la prima volta nel 1984, viene ora riproposto in edizione ampliata grazie ai materiali inediti forniti alla Fondazione dal fratello dell’autore, Mauro. La sua lettura permette di comprendere come, a un secolo dalla sua teorizzazione, l’Idealismo Magico sia di stringente attualità, capace di attraversare le rovine tanto della metafisica classica quanto della filosofia analitica.
- ...
- Sempre sullo stesso tema, nel 2025 la casa editrice InSchibboleth, per gentile concessione della Fondazione, ha dato alle stampe una silloge di scritti evoliani intitolata Oltre l’idealismo, per la cura di Donà e Sessa. La sua lettura permette di evidenziare la stretta relazione tra la filosofia di Evola e la Nuova Oggettività di Franz Matzke, tra gli autori che più incisero sul pensiero evoliano, con il suo Jugend bekennt: So sind wir!, che ancora attende una traduzione italiana.
- ...
- Restano da menzionare, a ideale chiusura di questo “anno evoliano”, due volumi, sempre dedicati al Nostro. Il primo è Notturno Europeo. Serate sull’orlo della catastrofe, curato da Andrea Scarabelli e Adriano Scianca per Altaforte, che raccoglie pezzi “di costume” scritti da Evola soprattutto nella seconda metà degli anni Trenta, quando girava l’Europa in qualità di corrispondente del quotidiano Il Regime Fascista di Roberto Farinacci. In questa antologia troviamo un Evola che frequenta i locali notturni delle capitali europee e che da queste esperienze trae acute considerazioni sulla modernità. Ma anche l’attento osservatore di momenti storici cruciali, come vediamo nelle sue descrizioni in presa diretta dell’Anschluss o dai suoi resoconti sulla Berlino in guerra.
- ...
- Infine, nello stesso periodo, L’Arco e la Corte ha ristampato l’antologia dei dodici scritti evoliani usciti tra il 1971 e il 1974 su Vie della Tradizione, che spaziano dall’etica del samurai ai centri iniziatici, dai misteri di Mithra allo Zen, dalla “Via della Mano Sinistra” alla magia sessuale, dall’iniziazione alla decadenza, fino a Dioniso e a Meyrink, al “morso della tarantola” e al simbolismo erotico orientale. Originariamente voluta dal palermitano Gaspare Cannizzo, direttore del periodico, la raccolta viene presentata in una nuova veste editoriale, comprendente ulteriori saggi e approfondimenti.
- ...
- Tutte queste pubblicazioni, che si aggiungono alle altre ricordate nel precedente numero di Studi Evoliani, bastano a suggerire quanto ancora vi sia da dire sul filosofo romano. Ora si aggiunge questo volume, la cui prima sezione contiene le relazioni del convegno milanese, tenutosi il 4 maggio 2024 nelle sale della Società Umanitaria e dedicato a Evola 1974-2024. Un pensiero per l’Europa, oltre a quelle del simposio romano, svoltosi il 23 novembre presso la Sala Conferenze Oroincentri e intitolato Evola cinquant’anni dopo. Le due iniziative hanno visto la partecipazione di un folto pubblico. Molti dei relatori, accademici e non, sono ben noti a chi si interessa di Evola: Alain de Benoist, Guido Andrea Pautasso, Gianfranco de Turris, Giovanni Sessa, Giorgio Calcara, Horia Corneliu Cicortaş, Alberto Lombardo, Andrea Scarabelli, Massimo Donà, Romano Gasparotti, Agostino Carrino, Giovanni Casadio, Davide Arecco, Adriano Scianca, Luca Siniscalco ed Emanuele La Rosa. Le loro relazioni immettono alla comprensione dei diversi momenti che hanno connotato la multiforme produzione evoliana e rappresentano un documento essenziale per la sua contestualizzazione storica. Sfogliando le pagine di questo annuario ecco la sezione Saggi, con uno scritto del filosofo russo Dmitry Moiseev, che discute connessioni e differenze tra Evola e Miguel Serrano sul tema del valore iniziatico dell’Eros. Giusy Capone presenta poi l’interpretazione dell’essenza della donna e del femminile in Evola, articolata fra i due poli della sacralità e della Tradizione. Nella sezione Inediti e rari troviamo molti documenti: una lettera inedita di Evola a Petroni, probabilmente del 1917, rintracciata da Pautasso. Da essa traspare l’interesse evoliano per le avanguardie, anche per quella futurista, oltre all’intenzione di Evola di fondare la rivista Alpenrose. A cura di Andrea Scarabelli compare invece una lettera che Evola inviò ad Attilio Fanelli in risposta alla recensione, solo in parte critica, che questi aveva scritto, su Il Secolo Fascista da lui diretto, all’uscita di Diorama filosofico, l’inserto culturale curata dallo stesso Evola per Il Regine Fascista.
- ...
- Sempre a cura di Scarabelli viene pubblicato un graffiante e immaginifico ritratto evoliano dovuto allo scrittore russo Eduard Limonov (1943-2020), da sempre lettore dell’opera del Nostro. Nella sezione Cronache e polemiche, Gianfranco de Turris compie precise messe a punto sul pontificato di Bergoglio e sui primi passi compiuti da Prevost, analizzandone le continuità ma, soprattutto, le discontinuità, anche con riferimento ai segni e ai simboli che hanno preceduto e accompagnato le due elezioni. Chiude l’Annuario la sezione Rassegne, in cui sono raccolte numerose recensioni a testi evoliani o di argomento tradizionale.
- ...
- In conclusione, Studi Evoliani 2024 fornisce al lettore materiale di analisi ampio e stimolante. Attesta, in particolare, come il lavoro di esegesi messo in atto nel corso del tempo dalla Fondazione abbia conseguito un livello qualitativo unico nel panorama degli studi nazionali sul tema. Tale lavoro, nel prossimo futuro, proseguirà con la medesima intensità e, occorre pur ricordarlo, grazie alle nostre sole forze e quelle dei singoli amici e collaboratori che ci affiancano, perché siamo costretti a dire che, soprattutto nell’anno del cinquantenario evoliano, assolutamente nulla è stato fatto da alcuna istituzione che pur avrebbe dovuto ricordarsi dell’evento proprio per far uscire Julius Evola e il suo pensiero dal “ghetto” in cui l’establishment culturale italiano, e non solo progressista, lo ha fino ad ora confinato, indipendentemente dalla quantità dei volumi editi che stanno a dimostrare come ci sia sempre un pubblico molto interessato alla sua persona e alle sue idee. Purtroppo, se ne deve dedurre che Evola continua a essere, a oltre mezzo secolo dalla scomparsa e nonostante l’enorme lavoro effettuato, una specie di tabù per l’intellettualità italiana dominante, o pseudo dominante, sia essa di sinistra o di destra, fatte le dovute encomiabili eccezioni che però, come ben si sa, confermano la regola. Questa situazione non può andare che a disdoro di una cultura e una intellettualità che ha fatto salire sulle cattedre universitarie, per parlare delle proprie esperienze, ex terroristi, ex brigatisti e compagnia sparante e considera l’aggettivo “evoliano” un insulto nei confronti di chi riesce per i suoi meriti a raggiungere posti importanti. Nonostante ciò, si continuerà a fare tutto quel che deve essere fatto, secondo quel celebre motto buddhista che Evola aveva fatto proprio.
-
- Fondazione J. Evola, Roma
- luglio 2025
-
AA.VV., Studi Evoliani 2024, acura di G. de Turris, A. Scarabelli, G. Sabetta e G. Sessa, Fondazione Evola-Ritter, Roma-Milano 2025, pp. 291, euro 25,00.
- SORTEGGIO Sì
- SORTEGGIO No
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Tra gli argomenti addotti per rifiutare la recente riforma della giustizia con separazione delle carriere ce n’è uno particolarmente interessante: che il sistema elettivo del CSM garantiva la selezione dei migliori, mentre sorteggiarli significa affidarsi al caso; non è detto che quelli sorteggiati siano migliori di quelli scelti dal “corpo elettorale” (cioè dai componenti il collegio votanti). In effetti l’uno e l’altro sistema sono considerati connotati l’uno (l’elezione) dal principio aristocratico, l’altro (il sorteggio) da quello democratico.
- ...
- Nel primo possono essere selezionate le capacità (e il comportamento) del candidato, nel secondo è esaltata l’eguaglianza tra gli elettori-candidabili. Come scrive Schmitt: “l’elezione può davvero creare un’autentica rappresentanza ed è quindi un metodo del principio aristocratico, se ha il senso di determinare la scelta dei migliori, se la direzione va dal basso verso l’alto, ossia gli eletti sono i più eminenti. Ma al contrario l’elezione può anche essere una mera nomina di agenti e rappresentanti di interessi. La tendenza va quindi dall’alto verso il basso, cioè l’eletto è un impiegato degli elettori, dipendente e subordinato… Nella determinazione mediante sorteggio l’eguaglianza è assicurata nel modo migliore, per quanto sia esclusa la possibilità di una distinzione secondo la capacità obiettiva”.
- ...
- Il fatto che talvolta la nomina di magistrati fosse fatta con il metodo stocastico nelle antiche repubbliche, in particolare ad Atene e millenni dopo, a Venezia è dovuto probabilmente al numero dei componenti il collegio elettorale, di poche migliaia (al massimo decine di migliaia) per quelle antiche mentre è di parecchi milioni (o decine di milioni) per le moderne “democrazie rappresentative”, le quali sono un compromesso (status mixtus), coniugando elementi monarchici, aristocratici e democratici nell’ordinamento costituzionale.
- ...
- D’altro canto il sorteggio, ancor più se accoppiato, come soprattutto a Venezia, dalla temporaneità delle cariche (spesso per pochi mesi) da incompatibilità, da divieti di nomine successive, oltre che derivare dal principio di uguaglianza, difende sia dal professionismo politico sia dalla bulimia del potere. Altro è il potere esercitato, come sta capitando in Italia per gli ultimi Presidenti della Repubblica, cioè per più di sette anni, altro quello dei componenti il Consiglio dei dieci di Venezia, sia per la brevità della carica, che per la rotazione dei capi, l’incompatibilità tra membri della stessa famiglia (e altro).
- ...
- Nell’ordinamento pubblico italiano il sorteggio trova applicazione, anche se non diffusa, specie in uffici (e incarichi) amministrativi a carattere tecnico o con funzione di controllo quasi a sottolinearne l’aspetto tecnico o di verifica di conformità alla normativa. Fa eccezione proprio l’amministrazione della giustizia (anche se non è un’eccezione ampia). Infatti il sorteggio è impiegato per la formazione delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello, competenti a giudicare per le fattispecie delittuose più gravi, relativamente alla quota dei giudici popolari; il tutto avviene tra gli iscritti ad un albo che abbiano un certo grado d’istruzione. Ciò è un’attuazione dell’art. 102 della Costituzione sulla partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia.
- ...
- Al vertice, e in tema di giustizia politica, è prevista l’integrazione della Corte costituzionale (ove debba giudicare nei giudizi di alto tradimento e attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica) con sedici giudici sorteggiati da un elenco di 45 eletti, ogni nove anni, dalle Camere riunite. Giustificato dalla necessità di evitare un controllo preventivo e stretto sulla composizione del collegio giudicante. Indubbiamente, più ancora nel caso delle Corti d’Assise la non professionalità del giudice popolare e sorteggiato non è stata ritenuta argomento sufficiente a contrastare le opposte considerazioni; anche se sottoporsi al giudizio di giudici dalla ridotta perizia giuridica non è una prospettiva confortante per le parti del processo. Nel caso del CSM tuttavia, essendo il Collegio da cui sorteggiare i candidati, composto da funzionari dello Stato di elevata professionalità e selezionati per concorso, gli inconvenienti addotti sono meno rilevanti. Va da sé che comunque qualcuno rimane. Specie se come riteneva Schmitt il corpo elettorale seleziona i migliori non perché i più eminenti e preparati, ma perché i più adatti a rappresentare gli interessi della categoria; deviazione ricorrente nell’esercizio di ogni funzione pubblica.
- ...
- Concludendo (ma l’analisi va rinviata ad un contributo più diffuso) occorre trovare (in parte già cennato nella legge de qua) le garanzie istituzionali della magistratura (e i diritti del singolo giudice conseguenti) non tanto nell’esterno – come per lo più nello Stato borghese – cioè tra poteri (come scriveva Montesquieu occorre che il potere arresti il potere), ma all’interno del potere stesso, come per l’appunto praticato nella Serenissima.
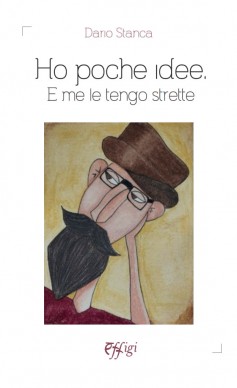
"Ho poche idee. E me le tengo strette"- Una raccolta di aforismi di
- Dario Stanca
- rec.di
- Giovanni Sessa
Quello di Dario Stanca è nome noto ai cultori di letteratura aforistica. Sue precedenti pubblicazioni hanno avuto significativi riconoscimenti, tra gli altri, la menzione d’onore, nel 2024, alla IX edizione del Premio Internazionale per l’Aforisma, “Torino in sintesi”. Salentino d’origine, vive da tempo in Piemonte. La sua formazione è eminentemente filosofica: si è laureato, infatti, con una tesi dedicata alla filosofia della persuasione di Carlo Michelstaedter che, da allora, è divenuto uno dei numi tutelari della sua visione della vita. A Stanca va, inoltre, riconosciuto l’indubbio merito di aver fatto conoscere a un pubblico considerevole di lettori, l’opera di colui che, senz’ombra di dubbio, può essere considerato il suo punto di riferimento ideale, il filosofo Anacleto Verrecchia. Usciamo da poco dalla lettura della sua ultima fatica, Ho poche idee. E me le tengo strette, una silloge di aforismi, da poco nelle librerie per i tipi di Ēffigi Edizioni (per ordini: 0564/967139, cpadver@mac.com).- ...
- Si tratta, a parere di chi scrive, di un lavoro davvero importante, arricchito dalla prefazione di Antonio Castronuovo. Nelle sue pagine, Stanca, non solo mostra una non comune perizia nell’utilizzo dello stile aforistico, rara nella tradizione delle patrie lettere, ma viva, comunque, in luminose eccezioni, rappresentate da Flaiano, Longanesi, Ceronetti e Gervaso. È un aforisma di quest’ultimo a introdurre il lettore nell’universo ideale di Stanca. Scrive Gervaso: «Il cinico dice le cose come stanno; l’idealista, come vorrebbe che fossero» (p. 7). Muovendo da tale asserto, l’autore, con persuasività di accenti, mette in scena la decostruzione, innanzitutto del senso comune, da sempre nemico giurato del libero pensiero che induce i più ad accodarsi al “bisogna pur vivere”, atteggiamento esistenziale fustigato dal pensiero sferzante di Michelstaedter. L’approccio alla vita di Stanca è antidogmatico, sostenuto da uno scetticismo liberante. Lo studioso definisce il dogma: «Il sonnifero dell’esistenza» (p. 21). Il dogma, sia esso di natura religiosa, politica o filosofica, è sorto in sequela all’invenzione del concetto, del mondo delle idee, strumenti che hanno tacitato la singolarità tragica di ogni esistenza.
- ...
- La domanda filosofica, il thauma, sorse di fronte a tele singolarità, ab origine, esposta al limite, al dolore, alla morte. La scoperta, platonico-aristotelica, degli universali ha finito per azzittire brutalmente il non, il negativo, che alligna e si mostra in ogni ex-sistere. Il lavoro di scavo del nostro autore lo fa riemergere in sintetica evidenza. Del resto, la scelta espressiva di Stanca, l’aforisma, non è casuale. La vita è lacerto, frammento, solo l’aforisma può illuminarla, può coglierne i tratti essenziali, a condizione che si avvalga del potere destrutturante dell’ironia socratica. Qualche esempio tra i tanti che il lettore incontrerà nelle pagine del volume di cui stiamo discutendo: «L’ignoranza vien studiando» (p. 16). L’aforisma chiarisce, in fondo, come qualsiasi sapere, anche quello critico-accumulativo, si riduca a sapere nesciente. «L’amore eterno lo sa che siamo mortali?» (p. 14), svela, di contro, che anche il più profondo tra i sentimenti umani è stato concettualizzato, staticizzato, eternato per fuggire l’angoscia indotta dal divenire. In tema di opposti, leggiamo: «Scienza e fede non si contrappongono. Entrambi fanno miracoli» (p. 18). Significativa, inoltre, questa tagliente definizione, carica di profonda ironia disvelativa, dell’immortalità: «Il posto fisso cui aspirano i precari della vita» (p. 18). Con una battuta, l’autore sintetizza quanto Giovanni Gentile scrisse in tema, vale a dire che l’immortalità cui guardano le religioni positive non è altro che il tentativo di pensare la perpetuità dell’empirico e, per questo, a dire dell’attualista, si tratterebbe di un pensiero immorale, espressione di sconfinato egoismo.
- ...
- Stanca compie in queste pagine, in un serrato confronto con la vita nuda, un esercizio di sincerità. Rileva, in pochi tratti di penna, come le azioni umane, il più delle volte, siano egoistiche e, addirittura, malvagie. Siamo tutti “animali” coinvolti nella lotta per la sopravvivenza, per questo: «Non fidarsi degli altri è bene. Fidarsi di se stessi è peggio» (p. 28) e, tra gli uomini: «A spuntare per primo è sempre il dente del pregiudizio» (p. 30). Da tali presupposti consegue questo giudizio sugli eventi umani: «La Storia non dà lezioni. Tantomeno ripetizioni» (p. 32), che svela come la storia sia sempre singolare. In un frammento illuminato sintetizza, quindi, la posizione teorica sostenuta in tema da Carl Schmitt. Il dire di Stanca è raffinato e affilato coltello, atto a dissolvere gli idola della contemporaneità, a muovere da falso mito della “religione dei diritti”: «Umanitarismo. Il galateo della falsa umanità.»; «La fratellanza umana ha soltanto figli unici.» (p. 39). In tal senso, il nostro autore perviene, in modalità paradossale, a rivalutare il male: «Rispetto al bene, il male è più onesto: non nasconde mai secondi fini» (p. 38). Anche le buone maniere sono scandagliate facendo emergere il fondo oscuro che tentano di celare: «Cortesia: indifferenza in maschera da sera» (p. 48), oppure, a proposito delle maniere affettate di comportamento, afferma: «La gentilezza profuma, ma quando è troppa puzza.» (p. 59).
- ...
- Nota, corrosivamente, Stanca: «“Dio è morto”. Ma la terra brulica di padreterni.» (p. 49). Questo aforisma fotografa, quale “scrittura di luce”, il nostro presente, nel quale, chiosa l’autore, è indispensabile evadere dalla ratio in quanto: «La modernità “liquida” fa acqua da tutte le parti.» (p. 79). Conclusivamente, è possibile sostenere, come fa il prefatore, che lo scetticismo cinico di Stanca non induce alla rassegnazione, all’affidamento inerte all’ineluttabile stato presente delle cose, ma, al contrario, spinge a sospendere il giudizio sulle verità, apparentemente epistemiche, prodotte nell’Infosfera dalla Forma-Capitale a proprio esclusivo beneficio: «Per lo scettico, gli unici punti di riferimento sono quelli interrogativi.» (p. 85). L’autore ha contezza che l’aporia nel nostro esistere non è, sic e simpliciter, data dalla morte (Derrida). Essa palpita, ben lo seppe Andrea Emo, nella vita stessa, appesa al non dell’origine. Questa scoperta, per chi sappia mantenere gli occhi aperti e vigili sul nulla-di-ente del principio, concede serenità stoica.
Dario Stanca, Ho poche idee. E me le tengo strette, Ēffigi edizioni, pp. 99, euro 12,00.
-
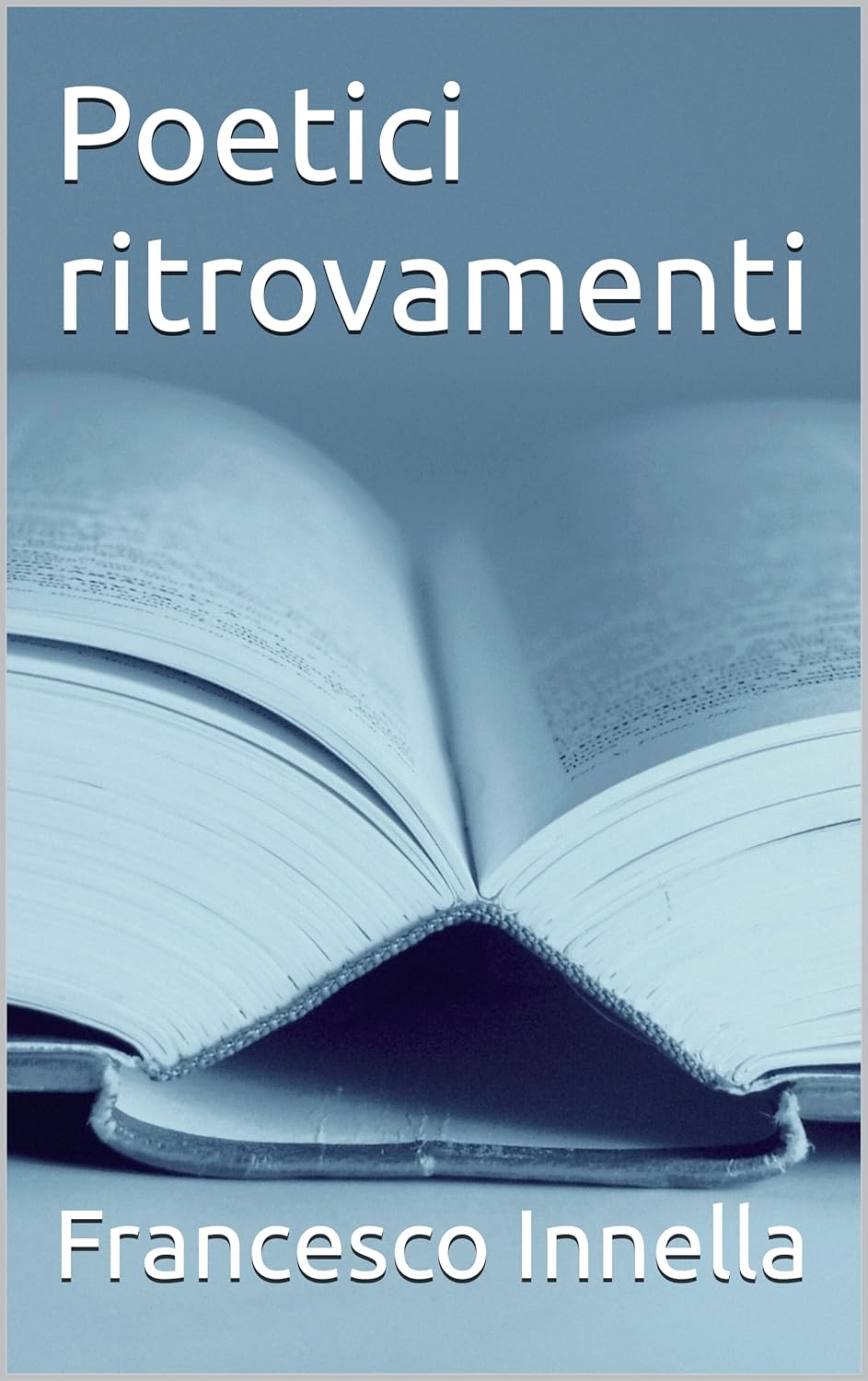
I Poetici ritrovamenti di - Francesco Innella
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
Della poesia di Francesco Innella ci siamo, a più riprese, occupati. Lucano di nascita e salernitano d’adozione, oltre che poeta, Innella è saggista di valore. In particolare, si è occupato della filosofia della persuasione del goriziano Carlo Michelstaedter, morto suicida a ventitré anni nel 1910. - ...
- La poesia di Innella è un sofferto colloquio con la Via del pensatore isontino, i suoi versi testimoniano l’aspirazione dell’uomo a una vita piena, non dispersa nella corrente dissolutiva suscitata dal desiderio. Nel mondo contemporaneo, gli idola della società post-moderna, attraverso l’Infosfera, hanno colonizzato l’immaginario individuale e collettivo. Ecco, allora, la necessità improrogabile, fortemente avvertita dal nostro autore, che la poesia, marginalizzata dal potere culturale ed editoriale dominante nell’età della post-verità, torni ad essere esercizio di parresia. Tale intento muove i versi di Innella. Lo si evince dalla lettura della raccolta, Poetici ritrovamenti, recentemente edita da Amazon.
- ...
- La silloge poetica raccoglie due precedenti opere dell’autore, Questi miei versi (1982) e Aenigmata (1991), dedicata all’amato Michelstaedter. Il volume è impreziosito da due scritti, il primo firmato dal pittore Eustachio Montemurro, il secondo dal poeta Vittorio Orlando ed è chiuso dalla postfazione di Emma Pretti. Il componimento che inaugura la silloge esplicita come il poetare di Innella sia sostanziato da pathos esistenziale e sofferta partecipazione: «Sono questi miei versi/ solitudine nella carne […] baci rubati/ ai venti infranti/ di uno specchio» (p. 14). Il poeta avverte la propria solitudine nel confrontarsi con il quotidiano della vita contemporanea: egli è indotto a mettere in atto una radicale decostruzione del senso comune nel quale i suoi simili vivono irretiti: «Paludi di silenzio/ attraversano la città/ […] Deserta la città/ si offre agli sguardi,/ affogati nella nebbia/ si ritorna a casa» (p. 15). Il “foro interiore”, come per Ernst Jünger, divine rifugio: solo in interiore homine vive la libertà che il fare poetico preserva. La poesia assomiglia, nel mondo contemporaneo, alla conchiglia che le onde del mare hanno lasciato sulla battigia. Queste conchiglie, lacerti e frammenti di vita persuasa, celano, nel loro esser eco della voce del mare dell’essere, il Sacro (si pensi, in tal senso, a I figli del mare di Michelstaedter), che affascina e terrifica in uno: «Non voglio che le prendano i bambini/ per gioco e sentano, non voglio rompere/ il velo della loro innocenza» (p. 16). Solamente lo sguardo rivolto alla natura, alla physis, appaga e svela, oltre l’ambiguo gioco degli opposti, guidato da Dioniso, la luce dell’eterno, il bagliore di Zoé, perpetuo tempo dell’ “Uno e Tutto”. Tale lucore si dà, con particolare evidenza, nella notte stellata che: «ripropone l’ostilità/ del giorno che viene» (p. 18).
- ...
- La vita è ludo eracliteo che Innella trascrive nella sua poesia dell’attesa: «Siamo qui ad aspettare che un nuovo giorno/ si elevi come altare sulle nostre angosce» (p. 20). Il Nuovo Inizio, prima di farsi evento storico, accade nell’animo del poeta. In caso contrario, la vita, rettoricamente intesa, si mostra quale tempo in cui trionfa la noia, un viaggio connotato da: «monotono fluire di treni/ su binari arrotati dal sole./ Frantumi di pali e di alberi/ fotografati dal finestrino» (p. 21). Dal grigiore del paesaggio della vita desiderante, il poeta acquisisce consapevolezza della possibilità di una vita altra: «Vissi in altre sinfonie,/ altri paesaggi,/ nei dischiusi sorrisi/ dell’eterno specchio della vita» (p. 23). Innella si sottrae alle lusinghe della modernità al: «cicaleccio inutile/ delle matrone del mercato» (p. 25), invita gli uomini a farsi bambini e a viveri liberi: «senza paura,/ come i fiori ai bordi della selva» (p. 29). Ci sprona a salpare verso lidi ignoti oltre: «la nebbia della vita» dimidiata della società contemporanea. Solo restando avvinghiato, ammonisce il poeta: «al mandorlo fiorito/ riuscirai a non annegare/ tra la tempesta di cemento» (p. 35) .
- ...
- Nella seconda sezione della silloge, il poeta si fa vate: «d’un segreto antico» (p. 46), dell’origine sempre all’opera in noi e nella natura. È l’otium il tempo capace di schiudere la dimensione persuasa. Allora, alchemicamente, nel “gioco cristallino” della “materialità” si ci si trova innanzi a: «un’apertura antica» (p. 58). Si tratta della Via che percorsero i Sapienti della Grecia aurorale. Per chi la persegua, i sorrisi imbonitori degli “ultimi uomini” non avranno più presa sull’animo, e potranno conoscere, pertanto, la realtà del risveglio. Il poetare: «è una ferita,/ da cui sgorga,/ la buona salute» (p. 62). I Poetici ritrovamenti di Innella ci conducono nei pressi della soglia oltre la quale la vertigine conoscitiva restituisce la Parola al silenzio rivelatore dell’origine, che anima tutto ciò che ha vita.
Francesco Innella, Poetici ritrovamenti, Amazon, pp. 79, euro 4,71.
- In morte di
- Giuseppe del Ninno
- intellettuale e amico raro
- di
- Giovanni Sessa
- Venire a conoscenza della morte di qualcuno è sempre raggelante. La morte aleggia ab origine sulle nostre vite. Noi uomini, ben lo intese Heidegger, siamo gli unici esseri di natura davvero mortali, perché abbiamo contezza della ineluttabilità della nostra fine. Quando, questa mattina, mi hanno informato della dipartita di Giuseppe Del Ninno, la notizia è stata per me un fulmine a ciel sereno. Giuseppe è stato intellettuale di primo piano e, soprattutto, amico libero, sincero, onesto. Qualità che oggi appartengono a pochi e si fanno sempre più rare.
- ...
- Io e Giuseppe ci siamo incontrati, per la prima volta, molti anni fa. Ero stato trasferito da qualche giorno, durante l’espletamento del servizio di leva, in una caserma della Cecchignola a Roma. In un pomeriggio che, nei colori, negli odori dei fiori e nel tepore, annunciava l’incombere della primavera, mi recai alla Libreria Europa di Enzo Cipriano, allora ubicata in Via Cavallini. Erano, credo, i primi anni Ottanta. Del Ninno si aggirava tra gli scaffali ricolmi di libri. Ci presentammo. Lo conosceva già di nome, in quanto Giuseppe era, da qualche tempo, uno degli animatori italiani, del movimento della Nuova Destra alle cui prospettive teoriche mi sentivo vicino. Discutemmo della sua prefazione a Visto da Destra di Alain de Benoist e della rilevanza della filosofia di Emanuele Severino. Ci accordammo, avendo entrambi espresso la volontà di rivederci, per un ulteriore appuntamento ma, purtroppo, l’accordo saltò, non ricordo di preciso per quale ragione e, della cosa, ora me ne rammarico non poco. La nostra amicizia avrebbe potuto consolidarsi fin da allora anche se, successivamente, ci siamo incontrati in più occasioni.
- ...
- Giuseppe è stato intellettuale coerente, di conoscenze profonde, in particolare di ambito letterario e filosofico, ma anche uomo curioso, mai sazio di sapere e dagli interessi molteplici. Sempre dialogante, attento alla comprensione delle tesi altrui, caratterizzato da un’equazione personale non dogmatica, come dimostrano le amicizie che intrattenne con personaggi dalla formazione diversa dalla propria, non ultimo Giampiero Mughini. Studioso di primo piano del pensiero di Tradizione, nei primi anni Settanta, tradusse, in modalità impeccabile, per le Edizioni Mediterranee, Forme tradizionali e Cicli cosmici di René Guénon, probabilmente su suggerimento di Julius Evola, allora ancora in vita. Non è casuale, pertanto, che suoi scritti siano comparsi anche su pubblicazioni della Fondazione Evola. Di de Benoist ha tradotto, L’eclisse del sacro. Ho collaborato con lui alla seconda edizione di questo importante volume: Giuseppe mantenne la precedente traduzione e l’accompagnò con una esaustiva prefazione, io scrissi la postfazione. Da allora, più volte, l’ho invitato a partecipare a presentazioni di miei volumi. Ha sempre accettato di buon grado. I suoi interventi, in queste circostanze, erano vere e proprie relazioni, le sue analisi inappuntabili (la cosa è testimoniata anche dalla prefazione, che qualche mese fa ha scritto per, L’esilio interiore, di de Benoist, nella quale fa riferimento alla mia filosofia del possibile). Anch’io ho ricambiato, recensendo i suoi scritti e, ove richiesto, partecipando a eventi da lui organizzati.
- ...
- La produzione letteraria di Giuseppe è vasta, variegata, spazia dall’esegesi del cinema, arte della quale è stato appassionato cultore, alla letteratura di viaggio e si spinge al giallo d’atmosfera. La sua ultima fatica, comparsa nel catalogo Bietti, La vedova nera, lo testimonia. Lo scritto è stato lungamente pensato, rivisto. La prosa, intervallata dal pensare ad alta voce del protagonista, l’investigatore privato Ernesto Di Gianni, irpino trapiantato a Roma, è accattivante, fluida, capace di coinvolgere il lettore nelle complesse vicende che costituiscono la trama. Ernesto, scapolo solitario e trasandato nell’abbigliamento, vive in un mini appartamento che diviene, nei momenti del bisogno, rifugio sicuro per le sue meditazioni. A nostro parere, se abbiamo ben inteso, ha dei precedenti letterari di tutto rilevo in Igravalle, l’investigatore di Gadda e nel Maigret di Simenon. Sullo sfondo del narrato le atmosfere di una Roma “magica” anni Sessanta.
- ...
- La famiglia è stata il perno attorno al quale Del Ninno ha costruito e vissuto la propria vita, luogo, per antonomasia, degli affetti. Lo mostra, in tutta evidenza, La guerra addosso. Grandi guerre e piccole storie familiari, apparso nel catalogo di Oaks editrice, opera nella quale Giuseppe si intrattiene, con maestria, sui drammi, bellici e non, in cui furono coinvolti appartenenti alla sua famiglia. Napoletano d’origine, soleva soggiornare a Ischia assieme ai Suoi. In molti testi la trasparenza del cielo mediterraneo e il rigoglio della flora insulare divengono protagonisti del narrato. Viaggiatore instancabile, sempre accompagnato dall’amatissima moglie Patrizia, dai figli e dai numerosi nipoti, ha lasciato testimonianza della sua appassionata peregrinatio nel mondo e nella vita, in Giornale di un viaggiatore ordinario, uscito per Tabula Fati.
- ...
- Grazie, Giuseppe, per l’amicizia che mi hai concesso, entrambi abbiamo fatto parte di una genia umana che non-scorda ma che porta sempre nel cuore, centro profondo e spirituale del nostro essere, ciò che va preservato, nel mio caso un indelebile ri-cordo della tua amicizia e della tua opera. A-Dio Giuseppe… Giungano ai tuoi familiari, sia pure con uno scritto rapsodico, le mie sentite e partecipate condoglianze e quelle della Fondazione Evola.
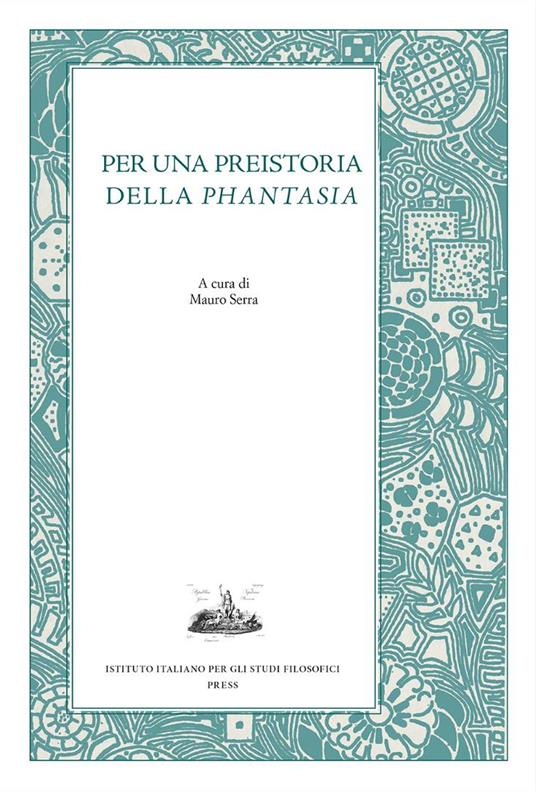
La preistoria della - Phantasia
- Una raccolta di saggi su un tema filosofico cruciale
- rec. di
- Giovanni Sessa
- È nelle librerie un volume davvero interessante, che induce il lettore a confrontarsi con un plesso teoretico di grande rilievo. Si tratta della raccolta di cinque interventi che gli autori tennero in un seminario tenutosi nella tarda primavera del 2023 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Ci riferiamo a, Per una preistoria della Phantasia, edito da Istituto Italiano per gli Stufi Filosofici Press (per ordini: info@scuoladipitagora.it/iisf). Nel testo, curato da Mauro Serra, sono contenuti i contributi di Alessandra Manieri, Alessandro Starvu, Roberta Ioli, Daniele Guastini e dello stesso Serra. Nella Premessa, il curatore chiarisce le ragioni di questa pubblicazione: indagare la “preistoria della phantasia”. Nel pensiero greco, infatti, riferimenti espliciti al termine oggetto di indagine, di fatto li si rinviene solo in Platone e in Aristotele. Di contro, i cinque studiosi sono convinti che la phantasia abbia rivestito un ruolo significativo anche nell’Ellade arcaica, a muovere da Omero. Dalla lettura si evince, inoltre, la discontinuità tra l’idea di phantasia ellenica e la nozione di “immaginazione”, impostati a partire da Kant.
- ...
- Alessandra Manieri compie l’esegesi della poesia omerica con l’intento: «di mostrare […] la stretta relazione esistente tra la “fantasia”di Omero […] e la creazione di un linguaggio poetico […] contrassegnato […] dalla trasmissione orale» (p. 12). Nella poesia arcaica, ne ebbe contezza Vico, parole ed espressioni: «sono “immagini delle cose”» (p. 13). Tale forma originaria della lingua è anteriore al lógos che, comunque, la presuppone. Non casualmente, Aristotele si soffermò su relazioni e differenze intercorrenti tra metafora e similitudine. La seconda non è immediatamente piacevole, ha struttura più ampia rispetto alla prima: «la metafora attiva un processo di apprendimento, con cui la mente si allena a cogliere le analogie, che non segue le vie del ragionamento logico» (p. 16). Le similitudini sono metafore che necessitano di una spiegazione ulteriore, integrativa. Manieri si intrattiene su molti luoghi dell’opera omerica, mostrando come in essi sia evidente il continuo gioco di metafore e similitudini. Le parole coniate dal poeta sono imitazioni di voci, suoni naturali, create su base percettiva, che vengono, di continuo, poste in relazione: «attraverso un crescendo iperbolico» (p. 24). L’argomentazione dell’autrice è sostanziata da vaste conoscenze filologiche, che mostra in qual modo l’ascoltatore venga indotto: «a visualizzare con la sua immaginazione, la rappresentazione» (p. 32) presentata, di volta in volta, dal poeta. Significativa la constatazione che l’uomo greco arcaico: «aveva una concezione della natura […] provvista di un’anima» (p. 34).
- ...
- Il saggio di Alessandro Starvu si focalizza su una caratteristica della fantasia messa a tema da Aristotele, che è presente nella trattatistica successiva, almeno fino alla Seconda Sofistica: «Si tratta della nozione di “ostensione ecfrastica”, ovvero della capacità della phantasia di visualizzare […] condurre sotto gli occhi della mente, un qualsivoglia argomento» (p. 41). Tale “porre sotto gli occhi” è compiutamente alluso dalle parole greche enérgeia ed enárgeia, “efficacia” e “vividezza”. Ciò implica che tale “vedere immaginifico” abbia tratto immediatamente persuasivo. L’autore chiarisce che la “vividezza” in Omero rimanda alla “lucentezza”. Il poeta è letto quale pittore, in forza dell’affermazione di Simonide per la quale: «la pittura è poesia silenziosa, la poesia pittura parlante» (p. 45). Starvu procede, con persuasività d’accenti e competenza filologico-filosofica, all’ekfrasis dello scudo di Achille. Chiarisce, in particolare, che la poetica omerica è centrata sul “guardare luminoso”: «che sottende un brillare di gioia tipico del mondo arcaico» (p. 46).
- ...
- Cruciale è il saggio di Roberta Ioli. La studiosa si sofferma su Anassimandro, mostrando il tratto visionario-immaginativo della sua filosofia: «Immaginando di poter osservare la terra dal cielo […] egli arriva a tracciare su una superficie a due dimensioni l’intera estensione delle terre e delle acque, e contribuisce a creare una nuova immagine del cosmo» (p. 87). La sua carta è un phantastón, un oggetto immaginario. La stessa evidenza è attribuibile a Senofane che, a proposito della natura degli dèi, utilizzò lo stratagemma del “controfattuale” capace di: «restituire presenza a ciò che non è o non sarà mai, se non nell’evocazione del possibile» (p. 89). Il filosofo inventa e, con lo scrivere o il disegnare, testimonia la possibilità dell’impossibile, che inaugura una catena deduttiva. La fantasia ha, quindi, implicazioni teoriche e pratiche. Gorgia chiarisce come i primi “fisici” tendessero a cogliere nel visibile l’invisibile. Il sofista si pone oltre l’interdizione eleatica del non poter dire gli esistenziali negativi, sostiene la possibilità di pensare il non-essere, al fine di destrutturare le certezze apodittiche e statiche. Aristotele ha precisato i due tempi che agiscono nel processo di immaginazione, il passato vicinissimo e il futuro imminente. Essi azzerano: «la distanza che li separa dal presente, […] dall’attualità della vita» (p. 100). La vista incide nell’anima immagini, frutto di esperienze. Esse sollecitano emozioni ma attivano, altresì, il processo conoscitivo. Come colse Guido Calogero, la logica noetica precede quella dianoetica. La fantasia non produce semplici descrizioni dell’esistente: «la capacità immersiva del lettore (o ascoltatore) è tanto più intensa quanto meno il processo immaginativo è soffocato dai dettagli narrativi» (p. 108).
- ...
- Daniele Guastini discute la differenza che distingue la phantasia greca dall’Einbildungskraft, l’immaginazione moderna. Lo fa attraversando criticamente, in modalità organica, le posizioni platoniche e quelle aristoteliche, guardando alla nascita dell’estetica moderna con Kant. A suo dire, immaginazione è il nome attribuito dalla modernità alla capacità di anticipazione soggettiva della conoscenza propria della fantasia. Verso di essa: «l’antichità nutriva […] non pochi sospetti» (p. 139), animata com’era da un forte radicamento ontologico, dall’idea di un mondo fondato, “vero”.
- ...
- Mauro Serra, a proposito della fantasia, si pone il seguente quesito: «è possibile, e come, rintracciare una preistoria di tale concetto di cui si ritrovino poi tracce nella speculazione filosofica vera e propria?» (p. 143). Lo studioso prende le mosse da una cornice teorica generale, la relazione tra visione e linguaggio, dalla quale si può tentare di rintracciare una risposta plausibile alla domanda. Nella poesia aedica a vedere realmente sono le Muse, di contro, a “far vedere” sono: «le parole con cui l’aedo restituisce “con ordine” la stessa sequenza degli avvenimenti», visti, in presa diretta, dalle Muse (p. 160). “Ricordando”, grazie alla divina Memoria, gli aedi aprivano per l’ascoltare la possibilità di accedere alla dimensione invisibile del reale.
- ...
- La fantasia, come seppero Giorgio Colli ed Ernesto Grassi, ha a che fare con uno sguardo sul mondo che non si contrappone astrattamente al discorso logico, ma ne costituisce l’antecedente e il presupposto. Una lezione di grande rilevanza.
- AA.VV., Per una preistoria della Phantasia, a cura di M. Serra, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, pp. 165, euro 18,00.
-
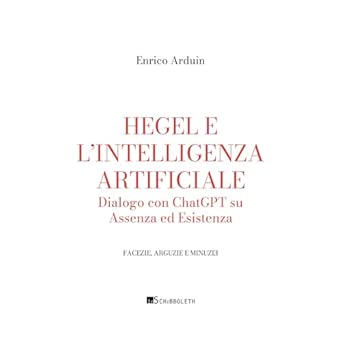
Hegel e l’Intelligenza Artificiale- Un saggio dialogico di
- Enrico Arduin
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Abbiamo letto un volume originale e attualissimo. Originale, si badi, non nel senso comune del termine, rinviante, nel caso di una produzione intellettuale, a qualcosa di inconsueto e singolare, ma in senso profondo, quale produzione centrata sul confronto con l’origine. Attualissimo questo libro lo è per altra ragione: affronta, oltre qualsivoglia canone ermeneutico già sperimentato, il problema dell’Intelligenza Artificiale (AI). Ci riferiamo al saggio dialogico del filosofo Enrico Arduin, da poco comparso nel catalogo InSchibboleth, nella collana “Facezie, arguzie e minuzie”, "Hegel e l’Intelligenza Artificiale. Dialogo con ChatGPT su Assenza ed Esistenza" (per ordini: info@inschibbolethedizioni.com). Il volume è aperto dalla prefazione di Massimo Donà, direttore della collana, e da un contributo di Gianfranco Bettin. I due scritti sintetizzano, con pertinenza argomentativa, le tesi di Arduin e immettono il lettore nell’universo ideale delle complesse tematiche affrontate nelle pagine del volume.
- ...
- Finora la bibliografia critica in tema di AI è stata connotata da prese di posizione divisive. Da una parte i fautori dell’AI, che ne esaltano vantaggi e positività, dall’altra i detrattori che, in sostanza, la ritengono un pericolo per la libertà e il pensiero. Arduin muove, di contro, da un confronto diretto e attivo con l’AI, un confronto dialogico su tematiche che, taluni, potrebbero ritenere inusitate per AI, riguardanti i plessi più significativi della speculazione di uno dei grandi padri della filosofia, Hegel. Nella prima parte del volume, l’autore ha scelto, in funzione di deuteragonista, il plugin “Mr. Logical”, basato su ChatGPT, nella seconda sezione, invece, Arduin colloquia con un modello più avanzato di ChatGPT, prodotto nei primi mesi del 2024, mentre, nelle conclusioni, il dialogante diviene la Chat, di ultimissima generazione, GPT-4.5. Arduin ha, quindi, contezza che nell’attuale frangente storico, segnato da dispositivi sintetici di PC e telefono, si intravede la possibilità dell’integrazione tra la dimensione fisiologico-biologica dell’umano e quella rappresentata dalla nuova tecnologia. Il confronto che egli mette in scena, rileva Donà, è quello tra: «la fragilità e la manchevolezza del (nostro) essere senziente e l’azione simbolica generata dalle complesse articolazioni sinaptiche custodite da un processo computazionale privo d’identità materiale e corporea» (p. 10). Da tale processo si evince, nietzschianamente, la sparizione del soggetto, dell’agente, in quanto tutto è azione.
- ...
- Le domande incalzanti, critiche, a volte sottili, che Arduin rivolge all’AI, lo chiariscono. L’incipit del dialogo con l’AI ritorna in tutta la discussione ed è rappresentato dalla dialettica hegeliana, riletta oltre le esegesi scolastiche stratificatesi nella filosofia nel corso di oltre due secoli. La conversazione mostra che nell’idealista tedesco i concetti di Dio e della stessa Religione non rinviano, rileva il prefatore: «mai a qualcosa di simile ad una fallace reificazione concettuale, che non sia riconducibile al movimento generale dello Spirito» (p. 12). Da tale concettualità intesa dinamicamente, non staticamente, discende l’autocancellazione cui è destinata ogni determinazione dell’Assoluto. Ne ebbe consapevolezza, nel suo ultrattualismo, il filosofo veneto Andrea Emo. Nella logica dell’essenza Hegel colse la negatività del principio, riverberantesi perpetuamente nell’apparire “positivo” dei molti. Chiosa l’autore: «Abbracciare questa prospettiva richiede un’apertura filosofica alla fluidità della realtà e alla natura provvisoria dei nostri orizzonti concettuali. Ci invita a vedere il mondo […] come un processo dinamico e interconnesso di divenire» (p. 21). Arduin evoca e si confronta, nel dialogo con l’AI, con la tesi della “mancanza” lacaniana.
- ...
- La “mancanza”, che sperimentiamo concretamente nel vivere, dà luogo a un: movimento desiderante senza fine, destinato a mettere in scacco […] qualsivoglia tentativo di “fissare” la sostanzialità del reale» (p. 13). L’origine è infondata, è libertà non riducibile alla categorie eidetiche, agli universali. Hegel e Lacan sono pensati quali autori atti a dirimere il complesso problema del rapporto tra le nostre esistenze individuali, “incorporate” e: «la complicatissima rete di processi computazionali restituita all’umano […] da una inesistente ma efficacissima “azione” in grado di modificare […] il nostro rapporto […] con la realtà» (p. 13). La visione di Lacan, a dire dell’autore: «presenta un valido modo per comprendere il processo dialettico […] integrando le dimensioni fisiche, esistenziali e simboliche dell’esperienza umana» (p. 22), rendendoci, pertanto, edotti del fatto, sostiene Bettin, che la storia dell’individuo è storia della physis.
- ...
- L’esegesi di Hegel è condotta da Arduin alla luce della nozione di “contraddizione”. Essa chiarifica l’interrelazione di essere e non-essere e presenta cinque configurazioni. Il confronto con l’AI consente, inoltre, di entrare nelle vive cose di tematiche etico-politiche: tra le altre, con il nesso che lega in uno potere e libertà, sempre intrecciati tra loro, in modo tale, precisa Donà, che: «riconoscere l’uno sia sempre anche un riconoscere, nell’uno, l’altro» ( p. 15). La tesi centrale del libro va colta nella discussione del tema degli sviluppi futuri dell’AI, che prevedono la nullificazione della distanza tra processi neurali digitali e l’esperienza della coscienza analogica. I primi, si badi, tendono però a negare il flusso di coscienza umano. La soluzione è rintracciabile, ancora una volta, nella nozione di “contraddizione” hegeliana, in cui i “superati” (intelligenza analogica e computazionale) non siano cancellati, ma radicalizzati nella loro incomponibilità. Una “sintesi” incapace, quindi, di esser veramente tale e di statuire e giungere a un nuovo positum. In fondo, rileva l’autore, la rivoluzione informatica non fa che riproporre il problema della significazione, sul quale la riflessione filosofica si è intrattenuta, in termini scettici e critici, ab origine.
Enrico Arduin, Hegel e l’Intelligenza Artificiale. Dialogo con ChatGPT su Assenza ed Esistenza, InSchibboleth, pp. 345, euro 26,00.
-
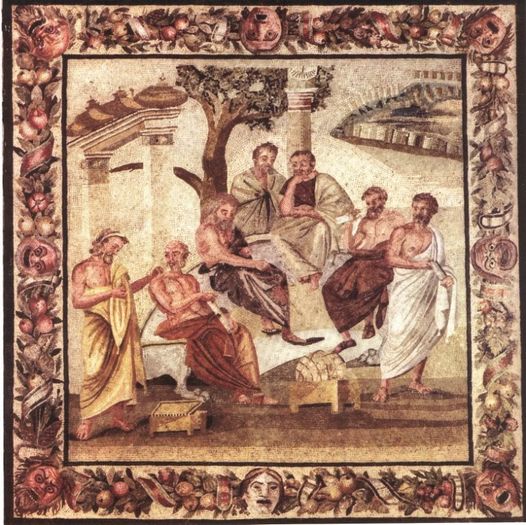
JUS SCHOLAE, - BASTA?
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Da qualche secolo il pensiero politico e giurispubblicistico europeo si è chiesto perché lo “stato di diritto” (o meglio la democrazia liberale): a) sia nato in Europa e non in Cina o in Egitto b) e le ragioni perché ciò è avvenuto. Il primo dato è evidente; quanto al secondo la spiegazione principale e ricorrente è che ciò era effetto del cristianesimo (meglio se occidentale). E questo per due ragioni corrispondenti a due passi del Nuovo testamento: la risposta di Cristo ai farisei rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio e l’istituzione divina di ogni autorità nella Lettera ai Romani di S. Paolo. Per cui, come scrive G. Mosca “Il primo elemento, e diremo anzi il più essenziale, perché un organismo politico possa progredire nel senso di ottenere una difesa giuridica sempre migliore, è la separazione del potere laico dall’ecclesiastico; o, per dire meglio, bisogna che il principio a nome del quale si esercita l’autorità temporale non abbia nulla di sacro e di immutabile” e ricordava come per musulmani, buddisti e cristiani ortodossi non c’è separazione ma commistione tra Stato e religione, così che “Un organismo politico la cui popolazione è seguace di una delle religioni universali accennate, o anche divisa fra diversi riti di una di queste religioni, deve avere una base propria giuridica e morale sulla quale poggi la sua classe politica”. La tesi era condivisa da tanti. L’influenza della religione sulle istituzioni e sull’economia è stata sostenuta, tra gli altri, da Max Weber, da Maurice Hauriou, da Bryce. Ancora oggi, e probabilmente senza consapevolezza, ne vediamo il segno nella nuovissima contrapposizione tra democrazie (del mondo occidentale) e autocrazie (di Putin, di Xi, di Modi, di Maduro ecc. ecc.) per qualificare e giustificare ideologicamente l’aiuto della NATO all’Ucraina. Ci sarebbe da chiedersi se sia un caso che tutte le democrazie nella parte del mondo sono riconducibili all’area del cristianesimo occidentale, e tutte le autocrazie (o piuttosto democrazie imperfette) siano nel resto del mondo. Inoltre la Gran Bretagna, ha gestito per oltre due secoli un impero sterminato, composto da colonie abitate da europei emigrati (Canada, Australia, Nuova Zelanda e, in parte, Sudafrica) e colonie abitate da autoctoni (in Africa e in India). Mentre quelle “europee” si reggono in democrazie liberali “piene”, le altre lasciano un po’ a desiderare. Anche se hanno istituzioni plasmate sui principi e gli ordinamenti dello “stato di diritto”; spesso derogano in settori, norme e istituzioni di particolare importanza – decisive per la popolazione (e per il controllo della stessa).
- ...
- E ancor più è stato notato, a partire da Montesquieu, che le istituzioni sono modellate sullo Stato “fattuale” del paese: clima, situazione geopolitica, usi e costumi.
- ...
- Si scrive questo perché la proposta dello jus scholae come mezzo d’integrazione degli immigrati (questo dovrebbe essere lo scopo) è un po’ pretenziosa e di conseguenza poco credibile. Pensare che un immigrato per essere andato a scuola (dieci anni? O di più?) sia diventato un cittadino buono e consapevole, e che superi i condizionamenti derivanti dal di esso ambiente e relative tradizioni è poco probabile. Nel senso che per taluni può avvenire ma per altri, presumibilmente la maggioranza, non capita. L’integrazione tra comunità diverse avviene, ma ha bisogno di secoli più che di aule, voti ed esami. Va per la maggiore ricordare – a disdoro della Meloni e di Salvini – l’editto di Caracalla, ma chi lo ricorda omette di ricordare che l’impero romano esisteva, ai tempi di Caracalla da circa due secoli e mezzo, e che i popoli su cui dominava avevano già dato dei grandi contributi alla civiltà greco-romana, al punto che buona parte degli scrittori latini e greci della prima età imperiale non erano nati né in Italia né in Grecia.
- ...
- Seneca, Lucano, Tacito (forse) erano ispanici, Luciano di Samosata ed Erone di Alessandria erano siriaci. Da secoli circa metà dell’esercito (gli Auxilia) era reclutato tra i non cittadini, i quali ottenevano la cittadinanza al congedo. Metodo sicuramente più pericoloso, coinvolgente ma sicuro per valutare l’amor patriae di un esame.
- ...
- Dalla prassi d’integrazione romana arriva un esempio assai diverso da quella che ci vorrebbero far credere. E dati i risultati (straordinari) di quello sarebbe il caso di meditarci sopra.
-
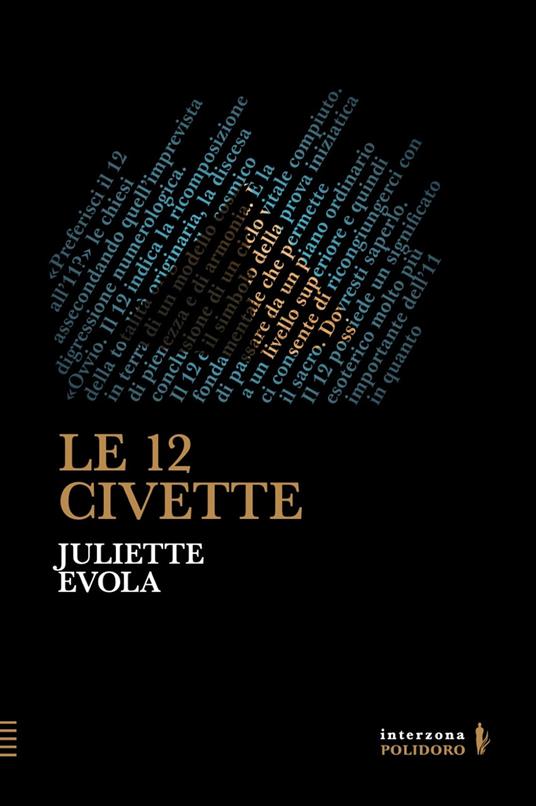
Le 12 Civette- Il labirintico romanzo di
- Juliette Evola
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Del libro sul quale stiamo per intrattenere i nostri lettori, molto è stato scritto. Ci riferiamo al volume di Juliette Evola, Le 12 civette, nelle librerie per Polidoro Editore. Alcuni hanno messo in dubbio la stessa reale esistenza dell’autrice: Juliette Evola, sarebbe semplicemente un nom de plume, scelto a bella posta per evocare il pensiero del filosofo-esoterista Julius Evola. In effetti, occultismo, esoterismo e numerologia riempiono molte delle numerose pagine di questo romanzo sui generis, a partire dal titolo nel quale compare il numero 12. Tale numero indica la possibile ricomposizione della pienezza dell’origine, il riproporsi in terra di un modello cosmico armonico, dell’Ordnung, di un potere politico che trae la propria legittimità “dall’alto”.
- ...
- Diego Fusaro, autore della prefazione che apre il volume, smentisce, di fatto, l’inesistenza dell’autrice. Racconta, infatti, di averla incontrata a Trieste in occasione di una sua conferenza. In quella circostanza, si recò con la donna al caffè Tommaseo e qui, l’anziana signora, gli consegnò il manoscritto del romanzo. Fusaro sostiene di aver letto d’un fiato il volume e di esserne stato favorevolmente colpito. Oltre ciò, cosa sappiamo dell’autrice? Le poche notizie che la riguardano le ricaviamo dalla nota biografica che apre il volume. Nata a Praga nel 1951 e residente a Trieste, maestra elementare in pensione, si è dedicata alla regia cinematografica realizzando documentari di animazione. Ha, inoltre, dato alle stampe due raccolte di poesie. La sua vita è stata animata da un profondo interesse per l’esoterismo, in quanto la propria famiglia vanterebbe tra i propri ascendenti il ricordato Julius Evola, fondatore del Gruppo di Ur.
- ...
- Le civette del titolo, in tal senso, rinvierebbero ai processi dissolutivi in atto nella post-modernità, fase estrema dell’Età Ultima, dopo la quale il ciclo discendente della civiltà avrebbe termine, dando luogo a una nuova Età dell’Oro (concezione ciclica esiodea). Il romanzo, in ogni caso, non si esaurisce in questi temi, in quanto è centrato, lo rileva il prefatore, su un registro labirintico, nel quale trame diverse si intrecciano di continuo, si sovrappongono l’una all’altra: «in un gioco di specchi borgesiano, con un effetto che […] ci trasporta verso luoghi letterari impensati e in grado di far scricchiolare a ogni piè sospinto tutte le nostre certezze narrative pregresse» (p. 9). È possibile asserire che siamo, di certo, di fronte a un testo originale, coinvolgente, sostenuto da una prosa affabulatoria, da dialoghi stringenti, il cui linguaggio è puntuale trascrizione del mondo virtuale nel quale, volenti o nolenti, siamo calati: «Le 12 civette è in effetti un romanzo che racconta e asseconda lo Zeitgeist e allo stesso tempo se ne distanzia abissalmente» (p. 9), in quanto la narratrice pare convinta che, la “risoluzione” dello stato attuale delle cose, possa manifestarsi all’improvviso, imprevedibilmente. Non è casuale che le tappe nelle quali si articola il narrato, siano le fasi alchemiche nigredo, albedo, rubedo. I fatti sono ambienti in un recente passato, nel 2020, l’anno della pandemia da Covid-19 che, secondo alcuni, avrebbe rappresentato, in forza dei provvedimenti restrittivi messi in atto, il momento apicale del Great Reset: «formula coniata al World Economic Forum che indica la volontà delle élite finanziare […] di sfruttare la congiuntura pandemica e l’escalation bellica per aumentare […] il controllo […] delle coscienze per arrivare a instaurare un Nuovo Ordine Mondiale» (p. 19).
- ...
- Il protagonista, Samuele, è un complottista con un matrimonio fallito alle spalle, legatissimo a sua figlia. Questi si innamora di Lorena, conosciuta online (del resto, oggi, i rapporti umani sono dimidiati, ridotti alla dimensione virtuale). Lorena, biologa che lavora in una start-up biomedica, con sede nel cuore delle Dolomiti, impegnata nelle ricerche sui vaccini anti Covid, scompare improvvisamente. Dopo un grave incidente stradale, viene ricoverata in una clinica. A questa storia se ne aggiungono altre. Innanzitutto, quella inerente un gruppo di imprenditori woke dediti a stregoneria e satanismo. Di maggior rilievo, per la comprensione del romanzo, il riferimento al libro del cattolico Maurizio Blondet, Gli Adelphi della dissoluzione, che giunge, infine, dopo molti passaggi di mano in mano tra i protagonisti, a un mitomane, conosciuto alle forze dell’ordine con il nome di Erostrato. Vengono, inoltre, rievocati nei minuti dettagli, omicidi compiuti negli anni Trenta, noti alle cronache giudiziarie come i delitti di Alleghe, nonché gli eventi legati al processo seicentesco intentato alla strega Ginevra Settembrini. Blondet, nel libro citato, attribuiva alla casa editrice Adelphi, il ruolo di diffusione di una cultura dissolutiva, mirato a indebolire i valori sui quali la civiltà europea è stata, nel corso del tempo, costruita. Un progetto, questo, messo in atto da ben individuati ambienti massonico-finanziari. Allo scopo, il catalogo Adelphi, ripropose un numero considerevole di autori legati all’esoterismo, tra i quali primeggia, per volontà dichiarata di Calasso, Guénon. Lasciamo al lettore il piacere di scoprire l’evolversi di questo thriller, la cui soluzione si evince alla fine del racconto. Da essa si comprende come Samuele sia il capro espiatorio di un trama più grande di lui.
- ...
- Il valore del romanzo di Juliette Evola va individuato, a parere di chi scrive, nel chiarire come le verità “chiare” e “distinte” su cui il mondo contemporaneo si regge, abbiamo un precedente, per molti oggi divenuto inconsapevole e inconscio, nella cultura ermetica. Una sorta di preistoria della conoscenza che cela possibilità inusitate, tra cui si distingue, in particolare, la possibilità dell’impossibile. Una cultura con la quale è necessario tornare a confrontarsi, non solo in termini romanzeschi, ma filosofici. Una visione altra-non-altra rispetto al theorein, ma capace di liberare dalle filosofie dell’impotenza oggi dominanti.
Juliette Evola, Le 12 civette, Polidoro, pp. 596, euro 20,00.
- LA "CAPRA ESPIATORIA"
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Capita spesso di leggere sulla stampa e ascoltare in televisione che i risultati delle elezioni regionali stiano indebolendo la segreteria del PD. Questo perché la ormai (quasi) triennale permanenza della Schlein non ha portato alcun significativo cambiamento nel consenso dei governati: il PD mantiene le posizioni, e la coalizione di governo anche: continuando, con tale andazzo, alle elezioni politiche prossime (salvo lo scioglimento del Parlamento) nel 2027 il risultato sarà lo stesso delle ultime: maggioranza (confermata) al centrodestra. Secondo molti commentatori la prospettiva induce molti maggiorenti del PD a sostituire la (deludente) segretaria.
- ...
- Non sono convinto che tale ragionamento sia corretto, e per due ragioni. La prima è che la difficoltà principale della Schlein e del PD non sono quelle che la stessa sbandiera a ogni piè sospinto, spesso smentite poco tempo dopo averle esternate.
- ...
- In primis l’inadeguatezza del governo Meloni a gestire la situazione economica, l’imminente default (o simili) lo spread in agguato, ecc. ecc. Il fatto che da tre anni non sia successo nulla del profetizzato, anzi qualche giorno fa, si legge, l’Italia è tornata ad affacciarsi nella categoria “A” dei paesi debitori, per un governo dipinto come votato alla bancarotta, è un risultato sorprendente. E assai migliore di quelli appoggiati dal PD, tanto osannati. E così per il resto: dalla tregua per Gaza dovuta all’amico Trump, della cui corte la Meloni farebbe parte (meglio, anche qua, un armistizio che un massacro ormai biennale); all’andamento dei flussi migratori (calati con i relativi naufragi e spese). Quasi in ogni campo risultati superiori a quanto realizzato dai precedenti governi appoggiati dal PD. Il fatto che il governo Meloni non sia come sostiene il PD, animato da buone intenzioni, non fa che confermare il vecchio detto che le vie dell’inferno (dei governati) è lastricata dalle buone intenzioni (dei governanti). Per cui a scegliere i malintenzionati spesso ci si indovina.
- ...
- Ma non è questa la sola ragione delle difficoltà del P.D, e dei suoi segretari, così come dei loro omologhi di sinistra (???) negli altri Stati europei. I sistemi politici-partitici europei erano ordinati lungo l’asse destra/sinistra, a sua volta fondato sull’opposizione borghesia/proletariato. Ora largamente soppiantata da quella globalizzazione/sovranismo. Partiti come il PD, fondati sull’inimicizia calante, si trovano in crescenti difficoltà, dovendo nuotare contro corrente (della storia). Pretendere che ne invertano il corso è chiedere il (quasi) impossibile. Tant’è che non c’è riuscito nessuno dei segretari frequentemente sostituiti negli ultimi (quasi) venti anni. Compresi i reggenti, siamo a 9, mentre il partito comunista dal 1943 al 1991 ne aveva cambiati 6 (durata media 8 anni). Si vede che il contesto era tutt’altro, a beneficio della durata delle leadership.
- ...
- E di tutto ciò si pensa siano consapevoli i dirigenti del P.D. Onde far carico alla Schlein di non essere riuscita a fare quel che nessuno dei suoi predecessori aveva conseguito è profondamente errato. Nessuno di questi – a parte Renzi – in un’occasione aveva tirato il PD al di sopra del limite (superiore) del 30% dei votanti. Anche se nel 2008 la coalizione di centrosinistra riportò il 37,5% dei voti era per l’appunto una coalizione di più partiti di cui il PD era magna pars, ma non tutto. Nelle elezioni politiche del 2019 il PD conseguiva il 22,8% dei suffragi; nel 2022 il 19,07%.
- ...
- I predecessori della Schlein non facevano quindi di meglio; anzi a sostegno della stessa, si può dire che i modesti risultati del PD governante non le sono ascrivibili, perché nei governi amici del PD non c’era lei, ma altri, compresi quelli pronti a silurarla. Perciò se di sicuro la giovane segretaria non è un Bismarck o un Cavour, ma anche se ne avesse le capacità, non ha la fortuna di tali grandi statisti: di essere spinti dall’onda lunga della storia. Con cui sarebbe più produttivo fare i conti.
-
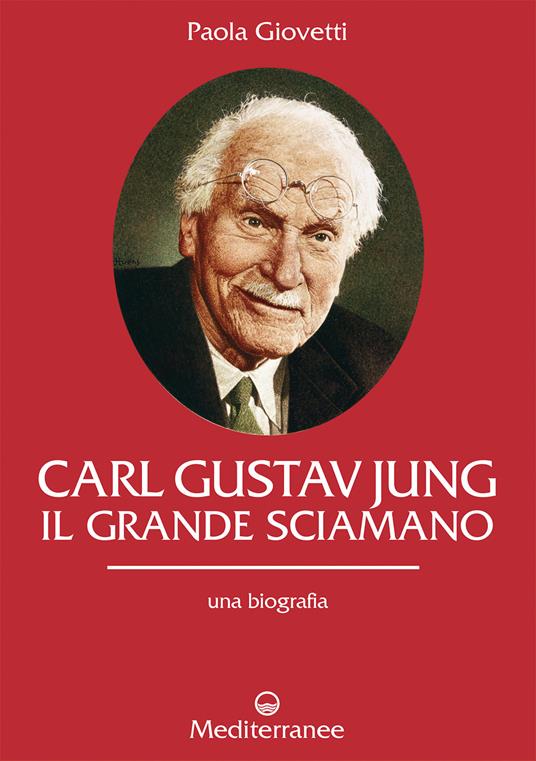
Carl Gustav Jung, il grande sciamano- L’illuminante biografia junghiana di
- Paola Giovetti
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Paola Giovetti è autrice prolifica, specializzata in tematiche afferenti alla ricerca psichica. Dirige la storica rivista, Luce e Ombra, organo della Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna. Non poteva, pertanto, mancare, nella vasta bibliografia a sua firma, un volume dedicato a C. G. Jung. È da poco nelle librerie per i tipi delle Edizioni Mediterranee la sua ultima fatica, "Carl Gustav Jung, il grande sciamano. Una biografia" (per ordini: ordinipv@edizionimediterranne.net, 06/3235433).
- ...
- Si tratta di un lavoro organico, esaustivo, che concede al lettore proficuo accesso, non semplicemente alla biografia esteriore dello psicanalista svizzero, ma rivela i tratti salienti della sua vita interiore e del suo iter “realizzativo”. Giovetti mostra una non comune conoscenza della bibliografia critica dedicata a Jung, la cui esegesi è condotta dall’autrice con pertinenza argomentativa e persuasività d’accenti. Giovetti si sofferma, peraltro, questo il pregio maggiore del volume, su aspetti sinora sottaciuti della personalità di Jung, esposta, fin dall’infanzia, al misterium vitae. La ricostruzione biografica è minuziosa, sostanziata da vasta documentazione e da una prosa affabulatoria che rende gradevole la lettura, come accade in genere nella storiografia biografica anglosassone.
- ...
- Jung, per dirla con Prezzolini, fu davvero “un figlio del secolo” XX (1875-1961), del quale visse le tragedie e gli slanci intellettuali. A parere di chi scrive, per entrare nelle vive cose della trattazione, è bene muovere dal racconto di un sogno infantile del grande intellettuale, riportato dall’autrice. Jung vide, in tale esperienza onirica, un prato verde nel quale: «si apriva una fossa oscura molto profonda […] scese la ripida scala […] in fondo trovò un drappo verde a mo’ di tenda» (p. 27) oltre il quale, in una sala, v’era un trono dorato sormontato da un tronco di carne e pelle, con un grande occhio nella parte superiore. Si trattava del: «fallo rituale, simbolo di vita e potenza, che troviamo all’origine di tante religioni dell’antichità» (pp. 27-28). Fin da bambino Jung, quindi, ebbe sentore della propria missione “sciamanica”: conoscere, attraverso la risoluzione dell’ombra, il Sé, cui si perviene in forza dell’integrazione della personalità.
- ...
- Gli Sciamani, lo rileva Eliade, operarono sempre, nei loro pericolosi viaggi nei “molteplici stati dell’essere”, a beneficio dei loro simili, svelando che, nella physis, tutto è animato, in perpetua relazione, in una prospettiva per dirla con Evola, di trascendenza immanente. Medesimo compito si pose Jung nei confronti della disorientata umanità del Novecento. Non casualmente, Giovetti rileva la possibile discendenza familiare dello svizzero da J. W. Goethe, per il quale Carl mostrò, fin dalla giovinezza, evidente sintonia di visione, in particolare, per le opere scientifiche del poeta (apprezzate, tra gli altri, da Rudolf Steiner).
- ...
- Jung avrebbe voluto laurearsi in archeologia ma, ragioni familiari, lo indussero a studiare medicina e ad occuparsi di psichiatria. Spinto dal professor Bleuler, dedicò la sua tesi di laurea a, Psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti. Jung partecipò, sul campo, alle esperienze medianiche della cugina, H. Preiswerk. Egli stesso, del resto, visse esperienze paranormali nelle case in cui abitò: udì “scoppi” provenire dalle librerie e vide un coltello spezzarsi misteriosamente in quattro parti. Questo oggetto fu conservato gelosamente dallo studioso fino alla fine dei suoi giorni. Lo svizzero fu alieno a qualsivoglia dogmatismo, in particolare, rispetto ai fenomeni su indicati, al pregiudizio positivista, negante la possibilità dell’impossibile. Conobbe Freud, che lo elesse al ruolo di allievo prediletto e di possibile successore. Giovetti ricostruisce i rapporti tra i due, rilevando come la causa del loro dissidio non sia imputabile solo a ragioni teoriche. Jung non accettava il dogmatico pansessualismo del padre della psicanalisi che leggeva quale excamotage compensativo della dimensione religiosa rigettata dall’ateo Freud, ma nella rottura un ruolo di rilievo lo svolsero anche le diverse “equazioni personali” dei due uomini. Fu “l’assassinio del Padre” Freud a porre Jung a diretto confronto con l’inconscio.
- ...
- Quel frangente storico fu assai difficile per lo psicologo archetipale che riuscì a superare la crisi grazie a una figura femminile di grande importanza per la sua vita, Tony Wolff. Jung, con questa paziente e allieva, intrattenne una liaison coinvolgente che la moglie Emma riuscì a tollerare in forza dell’amore sincero che la legava a Carl. Del resto, il confronto con l’“eterno femminino” goethiano ebbe sempre ruolo dirimente per Jung, come testimoniato dalla relazione con Sabine Spielrein, discussa da Giovetti. L’Animus maschile e l’Anima femminile devono integrarsi per pervenire alla coincidentia oppositorum alchemica. L’interesse junghiano per l’alchimia, sviluppato a seguito della lettura del Mistero del fiore d’oro, è essenziale per la comprensione della psicologia analitica: «La nigredo degli alchimisti corrisponde al confronto con l’Ombra […] L’albedo […] corrisponde all’incontro con l’archetipo dell’anima per il maschio e dell’animus per la femmina […] la rubedo rappresenta l’incontro con l’archetipo del Sé» (p. 125).
- ...
- La lettura del Libro rosso, composto di testi scritti con grafia goticheggiante e disegni, tra i quali molti mandala, chiarisce il tratto immaginale, niente affatto logo-centrico, del pensiero junghiano ed è simbolo del percorso esistenziale-spirituale dello psicoterapeuta. Jung rese evidente tutto ciò nella costruzione della Torre di Bollingen, a cui lavorò in prima persona, architettonica testimonianza del suo universo di riferimento. Un cosmo muto all’approccio casualistico, atto, di contro, a rivelarsi all’approccio analogico e sincronico: «Il concetto di sincronicità […] indica la corrispondenza significativa di eventi senza relazione causale tra loro» (p. 157). Jung fu homo religiosus: in forza dell’integrazione conseguita, poté asserire a conclusione di un’intervista, concessa nell’ultimo periodo della sua vita: «Non ho bisogno di credere, io so!» (p. 207).
Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, il grande sciamano. Una biografia, Edizioni Mediterranee, pp. 210, euro 19,50.
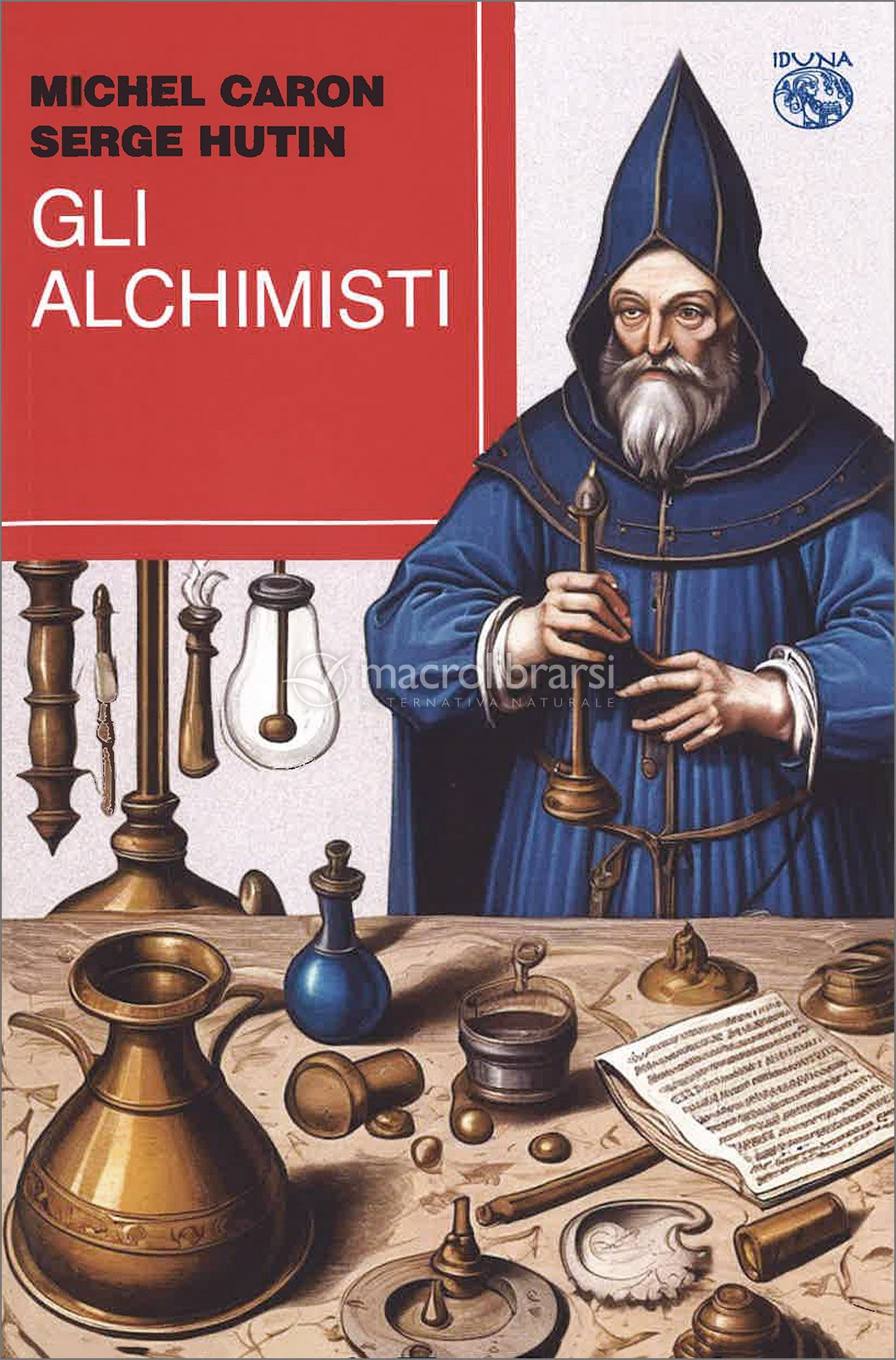
"Gli Alchimisti"- Un saggio di
- Michel Caron e Serge Hutin
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Michel Caron e Serge Hutin sono due noti studiosi di esoterismo. Alcune opere di Hutin sono state tradotte nella nostra lingua. È da poco nelle librerie un’opera di rilievo dei due solerti ricercatori, Gli Alchimisti, comparsa nel catalogo di Iduna Editrice (per ordini: associazione.iduna@gmail.com). Il libro è una vera e propria storia dell’alchimia, letta e presentata attraverso la discussione della vita e degli scritti dei più noti adepti della “Grande Opera”.
- ...
- Caron e Hutin forniscono al lettore le coordinate generali affinché possa districarsi nei complessi rimandi che il tema trattato implica. Allo stesso tempo, questo il pregio maggiore del volume, non banalizzano l’argomentazione, ma la discutono alla luce della più accreditata bibliografia critica in argomento. La prosa dei due studiosi, coinvolge e affascina rendendo gradevole la lettura di queste pagine, cosa piuttosto rara nei trattati di storia dell’ermetismo. Il volume è, inoltre, impreziosito da un ricco apparto iconografico, da ritratti di alchimisti e da raffigurazioni dei loro laboratori, nonché dei simboli che contraddistinguono tale Via. Scopo dichiarato del saggio è quello di mostrare che l’alchimia ha poco a che fare, in realtà, con la sua esegesi prodotta dal positivismo: non si tratta di una “chimica primitiva”, praticata dai meri “soffiatori”, ma di una via iniziatica europea che ha alle spalle una lunga storia.
- ...
- Riteniamo che, per la comprensione di questa affermazione, ruolo dirimente svolga il primo dei quattro capitoli, dedicato a Nicolò Flamel. Di Flamel è stato detto tutto e il contrario di tutto. La sua vita è circondata da un alone leggendario (come nel caso di molti adepti). Le apparenti incongruenze dei suoi dati biografici mirano a custodire il segreto iniziatico proprio dell’ermetismo. Dalla bibliografia prodotta su questo “scrivano pubblico” francese, nato tra il 1330 e il 1345, parsimonioso, fedele e devoto, è possibile rintracciare tanto la verità che, dall’interno, connota la “Grande Opera”, quanto le falsità e le dicerie che, per secoli, hanno accompagnato l’iter carsico della “scienza” alchemica. La sua tranquilla esistenza fu sconvolta da un sogno nel quale un Angelo gli presentò un libro sul cui frontespizio compariva una dedica di Abramo Ebreo: «Questo libro trattava della trasmutazione dei metalli e i fogli erano in numero di 21, vale a dire tre volte il numero 7» (p. 7). Flamel rintracciò questo volume molti anni dopo e si dedicò, dapprima senza successo, alla sua interpretazione. Intraprese il pellegrinaggio a S. Giacomo di Campostela, Durante il viaggio entrò in contatto con un medico e studioso di Cabala, Conches, con il quale rientrò in Francia. Grazie al suo insegnamento comprese la realtà celata nel volume. Il senso della “Grande Opera” fu fatto rappresentare da Flamel su due grandi arcate nella Chiesa di S. Giacomo a Parigi, più precisamente nell’ossario degli Innocenti. Sulle arcate comparivano due draghi: «Quello che sta sotto, senz’ali, è il fisso […] quello che sta sopra è il volatile» (p. 21). Questi draghi furono dipinti nell’antico Egitto come: «formanti un cerchio, la testa che morde la coda, per indicare che essi sono usciti dalla stessa materia» (p. 21). Compaiono, di seguito, i “tre resuscitati”, in campo verde: «Questa verdezza dimostra […] che la nostra pietra ha un’anima vegetante, e che essa è stata convertita dall’industria dell’Arte in vero e puro seme per germinare» (p. 21). È qui chiaramente indicato come l’obiettivo di ogni Via iniziatica sia trasmutare la “pietra grezza” in “pietra levigata”, filosofale. Pertanto, i tre resuscitati, vestiti di bianco, rappresentano il corpo, l’anima e lo spirito. Il conseguimento della pietra filosofare non si fonda su procedure chimico-materiali, proprie dei soli “soffiatori” e non indica il possesso dell’oro fisico, di ricchezze mondane, ma la riconquista della natura divina che, ab origine, vive latente nell’uomo.
- ...
- A questo punto del narrato, Caron e Hutin ricostruiscono, con persuasività d’accenti, la storia dell’alchimia. Si intrattengono sul ruolo svolto in essa da Fulcanelli, sul tema dell’immortalità legato alla pratica ermetica. Rilevano come Alberto Magno e il suo discepolo Tommaso d’Aquino non siano stati, come alcuni ritengono, in senso proprio, adepti del’Arte Regia: ad essa si rapportarono, sic et simpliciter, quali eruditi mossi da viva curiositas, in quanto: «Sino alla fine del Medioevo l’esperienza scientifica è stata costantemente legata all’esperienza spirituale» (p. 178). Il grande aquinate: «considerava l’alchimia una scienza perfettamente lecita fino a che non si accostasse al dominio della magia» (p. 34). Una risposta a questa esegesi riduttiva della “Grande Opera” la si trova ne, La tradizione ermetica, di Julius Evola.
- ...
- Nelle pagine de, Gli Alchimisti, il lettore incontrerà le rilevanti interpretazioni, fornite dai due autori, del simbolismo alchemico, spiegazioni dettagliate della strumentazione che compariva nei loro laboratori, in descrizioni cariche di atmosfera. Interessante è quanto Caron e Hutin sostengono a proposito di Jacob Böhme. Questi: «vedeva in Dio una realtà concreta e vivente con una natura e un insieme di energie, che sono in lui e che egli accoda armoniosamente» (p. 80) agli enti del mondo e agli uomini, in quanto Dio in essi e solo in essi vive.
- ...
- Come scrisse C. G. Jung: «La vera alchimia non è mai stata un affare o una carriera, ma un vero e proprio Opus compiuto in silenzio e con abnegazione». Conclusivamente: «Le formulazioni […] dei principi dell’alchimia non son il culmine di un ragionamento […] ma si presentano come dedotte da certe conoscenze metafisiche acquisite partendo da una iniziazione» (p. 178). Via per tutti e per nessuno, che conduce al cospetto della vertigine della soglia, come sostenuto dal grecista Davide Susanetti.
- M. Caron - S. Hutin, Gli Alchimisti, Iduna, pp. 191, euro 20,00.
- La rivista «Arthos» è, da decenni, un punto di riferimento per quanti siano interessati al pensiero di Tradizione. È nelle librerie l’ultimo numero di questo periodico, pubblicato da Arya Edizioni di Genova e dedicato, in gran parte, alla discussione di un tema avvincente: "Il Paganesimo",
- (per ordini: info@edizioniarya.it, pp. 416, euro 38,00).
- ...
- Si tratta di una pubblicazione di particolare rilievo: va segnalata all’attenzione dei lettori, sia per le firme di prestigio che vi compaiono, quanto per l’impeccabile curatela che la caratterizza. Gli autori dei saggi sono noti studiosi di tradizionalismo, di storia delle religioni, di filosofia e simbolismo. Diversi gli accademici, tra gli altri ricordiamo Pietro Mander, Flavio Piero Cuniberto, Luciano Albanese. La rivista, diretta da Nicola Crea, è articolata in più sezioni: in Contenuti sono raccolti i saggi che discutono, da diverse prospettive e angolature, tematiche legate a senso e significato dei culti politeisti, o che si soffermano su loro particolari implicazioni. In questa sezione compare lo scritto di Dumézil, Vacuna, che fu tradotto da Renato Del Ponte. L’angolo di Julius Evola celebra il cinquantenario della morte del pensatore romano e presenta scritti che analizzano il rapporto paganesimo-cristianesimo nel filosofo romano (è il caso del contributo di Aldo La Fata). In tale sezione compare un importante saggio di Elémire Zolla, finora inedito nella nostra lingua, che mette a tema i rapporti teorici e personali intercorsi tra Evola e Reghini. Infine, in Memoranda et Agenda, vengono ricordate, con partecipata commozione, le figure di Renato Del Ponte, fondatore del periodico, di Enzo Mario Migliori e di Giovanni Feo, recentemente scomparsi.
- ...
- Per ragioni di spazio, ci intratterremo solo su alcuni degli scritti della rivista, quelli più vicini alla nostra sensibilità. Non ce ne vogliano gli altri autori. Muoviamo dal saggio, informato e convincente, di Luca Siniscalco, dedicato a, Forme politeiste del sacro in Ernst Jünger. L’autore precisa che Jünger, nel 1996, dopo un iter teorico complesso, aderì al cattolicesimo. Da giovane, lo scrittore aveva confessato la propria difficoltà a sposare una confessione religiosa positiva, sviluppando una critica alla teologia centrata su un’intuizione di Leopold Ziegler. Questi aveva rilevato che: «Il divino si esprime sempre […] in forma dinamica» (p. 159). Per tale ragione, Jünger riteneva che la contemporaneità avesse necessità di nuove forme di espressione religiosa. Il divino, grecamente inteso, dà segno di sé nel cosmo, nella physis. Nella contingenza storica della modernità è preservato nel foro interiore dal Singolo, dal “contemplatore solitario”. Il tedesco ha sempre mantenuto un atteggiamento sismografico riguardo al Sacro: «Alla ortodossia […] oppone una ortoprassi: una strategia di visione ed evocazione delle forme del divino» (p. 161). Theós, in greco, ebbe valore aggettivale, così come il tedesco Gott conserva in sé il mistero di un principio ineffabile e indicibile, tradito dal dio personale del Cristianesimo. Jünger avrebbe messo in atto, a dire di Siniscalco, un tentativo di integrazione del linguaggio cristiano con: «l’immaginazione creatrice pagana» (p. 161), ponendo in posizione di sacco qualsivoglia dualismo.
- ...
- Solo nella physis, ne siamo convinti, è possibile cogliere la realtà della trascendenza immanente, di cui disse Evola. Essa si mostra nella vibratilità della dynamis, esperibile in un’empiria estatica, connotata dall’apertura al reale sia dei sensi che dell’intelletto. Nella dimensione estatica si vive in un tempo qualitativo, dinamico e dionisiaco, un tempo imperniato sulla ricorsività del simile, non dell’identico. L’origine, infatti, inizia sempre daccapo. Tale visione rimase vitale in Jünger anche dopo la sua adesione al cattolicesimo. Il tedesco lesse, infatti: «La Grazia, come forza di donazione originaria» (p.172). La sensibilità spirituale rimase, nello scrittore, sempre la stessa. Una sensibilità esposta al principio, all’origine, mirata alla tutela del Deus absconditus e del misterium vitae.
- ...
- Temi non dissimili emergono nell’intervista rilasciata a Nicola Crea da Alain de Benoist. In essa, il filosofo francese, se abbiamo ben inteso, ribadisce le posizioni espresse, qualche decennio fa, nel volume, Come si può essere pagani?. Prende le distanze dalle forme parodistiche di neo-paganesimo e dal New Age, ribadendo una visione dell’origine da intendersi come il sempre possibile. È l’azione umana a decidere il riaffermarsi del principio nella storia o il suo definitivo oblio, esempio di visione tragica pura. Giovanni Damiano nel saggio, Il pensiero delle differenze nel mondo classico, delinea: «una breve analisi genealogica, volta a ricostruire […] alcuni frammenti […] del pensiero delle differenze durante l’età classica» (p. 225). L’intento è perseguito attraverso l’attenta analisi di quanto prodotto, in termini teorici e politici, in Grecia e a Roma, e in forza di una non comune conoscenza delle fonti. Nel primo caso, ruolo dirimente ebbe l’opera di Giuliano Augusto: «che seppe far convivere, in un ordinamento gerarchico, il padre di ogni cosa (il dio della religione ebraica) con gli dèi etnarchi» (pp. 230-231), riducendo la possibile egemonia del primo, in un contesto storico ormai difficile, se non compromesso, per il politeismo. Per quanto attiene a Roma, basti citare la conclusione dello scritto: «Fare del confine un dio “significa rendere le proprie scelte, e in un certo senso, la propria identità, indiscutibili […] La cultura romana […] ci appare come un insieme di costruzioni anti-flusso”» (p. 235), alle quali tornare a guardare nell’età della dismisura.
- ...
- Segnaliamo, infine, lo scritto di Charles Upton incentrato sulla discussione dei rapporti tra fisica e metafisica, in particolare alla luce delle posizioni tradizionaliste di Schuon. Ci pare un indirizzo di studio da approfondire. Chi scrive ritiene, alla luce delle opere del fisico ed epistemologo Claudio Borghi e della filosofia di Cacciari, che in questo ambito sia necessario ribadire il tratto singolare, sempre in fieri dell’origine. Ciò consente non solo di superare il dualismo indotto dal logo-centrismo, distinguente essenza ed esistenza, essere e nulla, ma di recuperare il cuore vitale del Paganesimo europeo, la potestas di Dioniso, chiave di volta della filosofia evoliana e quint’essenza della visione sferica del tempo.
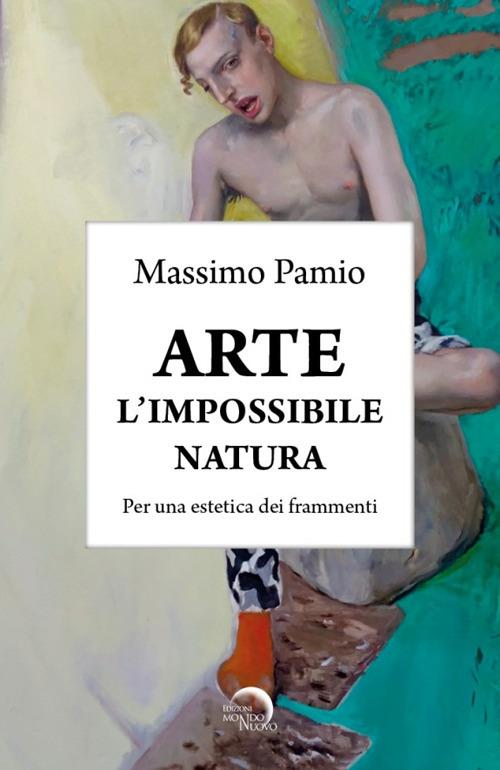
Arte, l’impossibile natura- Un saggio di
- Massimo Pamio
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Il senso del fare artistico
- Massimo Pamio è poeta e saggista. Dirige, in Abruzzo, il Museo delle Lettere d’Amore, istituzione significativa, legata alla visione della vita propria di questo autore. In passato, ci siamo già occupati di una sua precedente fatica teorica, "Sensibili alle forme".. Testo di grande rilievo i cui presupposti teorico-pratici vengono ulteriormente discussi e, ci pare, sviluppati ulteriormente, in un volume da poco nelle librerie per i tipi delle Edizioni Mondo Nuovo. Ci stiamo riferendo a, "Arte, l’impossibile natura. Per una estetica dei frammenti". Il libro è impreziosito dalla prefazione di Romano Gasparotti, fenomenologo dell’immagine e performer di Danza profonda. Si tratta di un saggio assai denso nel quale Pamio, in primis, interroga se stesso intorno al senso del fare artistico, in particolare soffermandosi sulla pittura, senza proporre, come nelle corde della filosofia autentica, soluzioni definitive. In proposito, scrive Gasparotti: «All’ostinato domandare non corrispondono rassicuranti risposte […] bensì un rispondere evasivo» (p. 5). L’autore muove dalla vedenza, vale a dire: «il vedere disseminato nello spazio-tempo, puro debito di incoscienza al mondo» (p. 15). In essa, ogni elemento, in forza della luce, si concede quale pura visibilità. La luce (l’autore ci pare memore della lezione della filosofia di Roberto Grossatesta e di Florenskij) è l’origine della vedenza, la realtà si mostra in modalità gratuita, ludica, lucreziana, sempre in relazione al buio cosmico.
- ...
- Luce e immagine
- La luce, di fatto, è la meraviglia principiale: «che rende visibile l’invisibile» (p. 16), un vedere non riducibile alla modalità meramente oggettivante del theorein che, in forza dei concetti, del logo-centrismo affermatosi nel corso del pensiero occidentale, ha ossificato, sterilizzato la metamorfosi universale, il fluxus della physis-mixis, che immediatamente rinvia all’immagine intesa come scarto e selezione (strumenti imprescindibili per la sopravvivenza dell’uomo preistorico): «L’immagine si dirige verso un’altra per una sconosciuta forza di attrazione» (p. 16). Il vero creatore è esposto a tale flusso. Pamio mostra di aver contezza di quanto sostenuto da Klages e, soprattutto, da Andrea Emo, il quale ebbe a scrivere: «Le immagini sono le metempsicosi dell’unica anima, dell’eterna unica fenice che si brucia e si consuma […] rinasce in altro nido […] la sua sola giustificazione sono altre immagini» (Q. 264, 1963). La dimensione immaginale consente agli uomini di transitare dal sonno/cecità, di cui ebbe contezza Eraclito, al vedere nel profondo. Non vi è, nell’arte autentica, l’eleatica identità di vedere e pensare ma un tra-guardare sapiente, da sapio, assaporante e sin- estetico. L’arte così intesa educa un guardare che non è, sic et simpliciter, mirato a contemplare oggetti, in quanto scardina la dimensione rappresentativa, costituita dalla dualità soggetto e oggetto. L’immagine, anche quella pittorica, rinvia, come rilevato da Gasparotti, a un quadro invisibile, non produce l’excrementum (Derrida) di un poietes che, in modalità consapevole, crea, ma dà luogo a una: «danza musicale delle dinamiche ondeggianti e rimbalzanti di un aperto e metamorfico formarsi sempre in corso d’opera» (p. 11). Rinvia al misterium vitae, all’Eccedenza che palpita nelle cose della vita e che tutte simpateticamente tiene in Uno, l’Amore.
- ...
- Arte e singolarità
- L’arte s-determina gli enti, rivela, nel kairos del suo apparire immaginale, come avviene nella physis, l’essere sempre in fieri della dynamis, potenza-possibilità, che agita e vitalizza dall’interno, il nostro ex-sistere, il nostro apparente star-fuori dall’origine. Pertanto, lo stesso creatore è individuo assoluto, Io svuotato di se stesso, esposto al novum di quella che Bruno, avrebbe definito la “vicissitudine universale”: «Le immagini garantiscono il movimento […] un in-stare che è un osare, un oltr-are» (p. 27). Appartengono all’esistenza individuale, singolare, all’unicità delle cose del mondo, ai frammenti della vita che, qualsivoglia approccio universale, nega (da Platone ad Hegel). Vedere implica far esperienza, esperire, il muoversi at-traverso, per sapere: «che l’inconoscibile si espone» (p. 30). Non si tratta dell’idea di “conoscenza” fondata sulla significazione, ma di un restituire, per dirla con Magritte, “mondo al mondo”. Ne ebbero contezza Beuys e Nitsch, ricordati da Gasparotti, che portarono il loro fare oltre l’umana “cocciuta razionalità”.
- ...
- Arte e Nuovo Inizio
- Comunicare, infatti, non implica necessariamente il servirsi del pensare noetico e discorsivo. Per questo, Pamio mette in discussione la stessa valenza ermeneutica della storia dell’arte. Gli artisti, suggerisce l’autore usando il dubitativo, attingono al mundus imaginalis (Corbin), a una sorta di memoria cosmica immaginale e la proiettano nel presente. Come accade ai bambini, non ancora legati, nella modalità espressiva loro propria, al linguaggio concettuale-diairetico. Essi vivono mitopoieticamente nell’Uno-Tutto, nella realtà empatica dell’Amore. Fenomeno e noumeno, in tale percezione, si dicono in uno: «Esistono solo i fenomeni. C’è una fenomenologia di vicende […] oppure il loro rimuoversi o accumularsi o rinnovarsi in nuove procedure. La verità sta nelle procedure» (p. 93), ma la “coscienza” del soggetto, modernamente intesa e scissa da mondo, non può coglierle. Il pittore, sintonico al fluxus della physis: «fonda inizi che sono diversi per ciascun uomo. Ognuno di loro è un interprete del vero come fluttuazione, come gioco di attrazioni […] di metamorfosi» dei “frammenti-lacerti”. (p. 94). La “forma” cui Pamio guarda in queste pagine, che l’arte vera trascrive, non è Gestalt, idea fondante, ma Bildung, ritmo, danza, tra-sformazione relazionale sempre all’opera delle forme viventi. Il fare artistico contemporaneo, il più delle volte colonizzato dalla Forma-Capitale, mercificato, non ha nulla in comune con quanto asserito da Pamio. È segno estremo della tacitazione della vita e del suo perpetuo rinnovarsi. Arte, l’ impossibile natura, è libro atto a rasserenare la mestizia dell’età della post-verità, per dirla con Stiegler, animato dal sacro fuoco di un fare sapiente. È profetico auspicio di Nuovi Inizi per le nostre vite e per la storia.
- Massimo Pamio, Arte, l’ impossibile natura. Per una estetica dei frammenti, Edizioni Mondo Nuovo, pp. 112, euro 14,00.
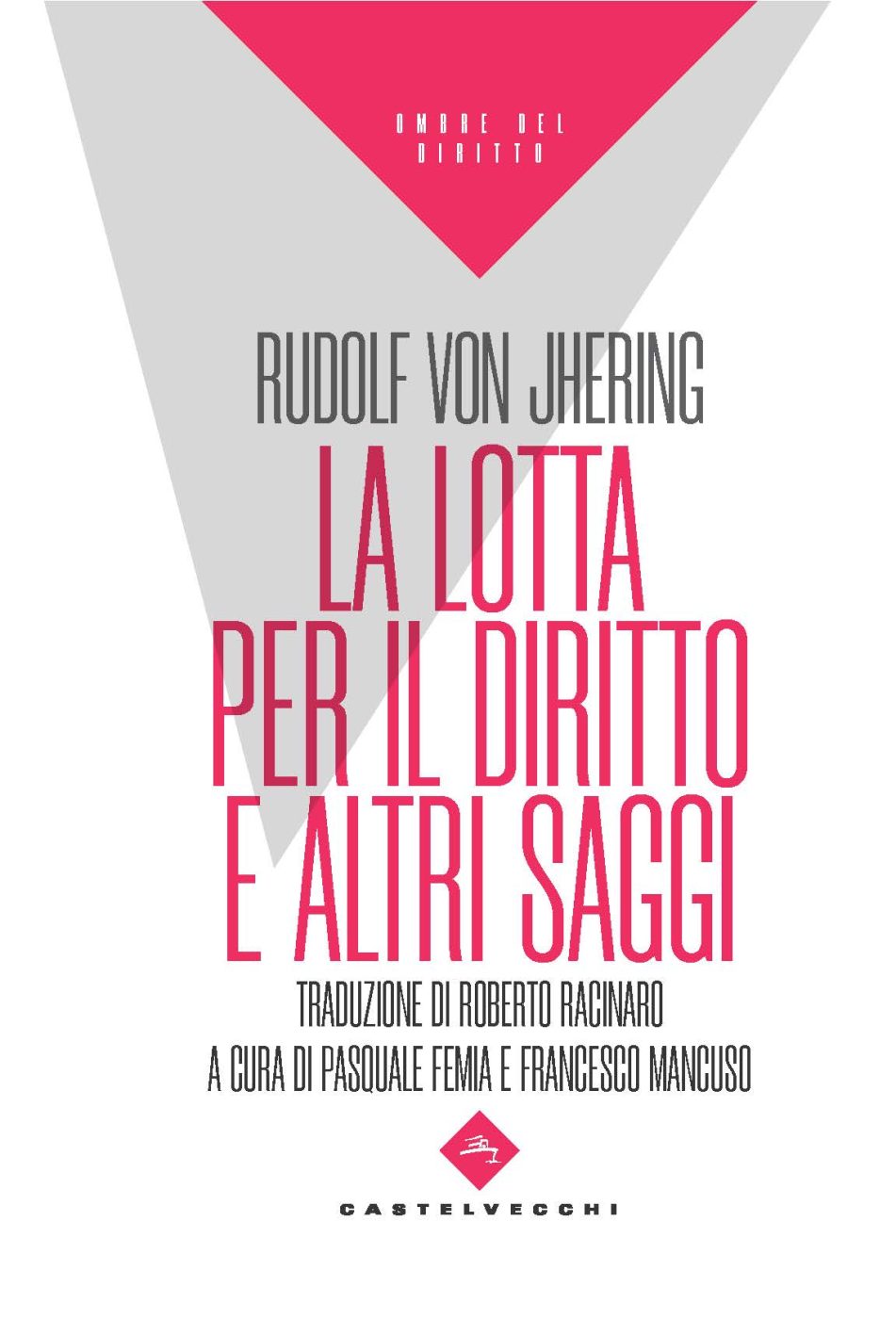
Rudolf Von Jhering- La lotta per il diritto e altri saggi
- (Castelvecchi editore (traduzione di Roberto Racinaro,
- a cura di Pasquale Femia e Francesco Mancuso), € 21,00, pp. 254)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- A leggere questa nuova edizione della traduzione (del 1989) di Roberto Racinaro di un classico del pensiero giuridico come Der Kampf um’s Recht occorre porsi alcuni interrogativi. Il primo è: se il saggio di Jhering è uno dei libri giuridici più conosciuto (e pubblicato) degli ultimi centocinquant’anni, tradotto in una ventina di lingue, continuamente ripubblicato (Italia compresa) a che serve una nuova edizione?
- ...
- La prima risposta che si può dare è che i problemi lì affrontati (connaturati al diritto) sono sempre attuali. Facciamo un esempio. Nelle prime edizioni del saggio, Jhering scriveva “Il concetto del diritto è un concetto pratico, cioè rivolto ad uno scopo, ma ogni concetto rivolto a uno scopo è configurato per sua natura dualisticamente, poiché racchiude in sé l’antitesi di scopo e di mezzo: non basta rendere noto semplicemente lo scopo, ma deve insieme essere fornito il mezzo, attraverso cui esso possa essere raggiunto”. A chi rimproverava a Jhering di aver enfatizzato la litigiosità perciò rispondeva, nella prefazione del 1891 (non presente nell’edizione italiana precedente, neanche in quella del 1935, traduttore R. Mariano) “mi limito soltanto a rivolgere, a coloro che si sentono chiamati a farmi delle critiche, due preghiere. In primo luogo, che non facciano in modo di distorcere e snaturare le mie vedute, da farmi propugnare la lite e la lotta, l’amore di far liti e processi, mentre io non richiedo assolutamente la lotta per il diritto in ogni lite, ma solo là, ove l’assalto contro il diritto implica parimenti il dispregio della persona… L’arrendevolezza e lo spirito di conciliazione, la mitezza e la natura pacifica, la composizione amichevole e la rinunzia a far valere il diritto trovano anche nella mia teoria il posto che loro compete; ciò contro cui essa si pronunzia è unicamente l’umiliante tolleranza dell’ingiustizia che deriva da viltà, pigrizia, indolenza” e sottolinea il limite di opposte critiche “Cos’ha il dovere di fare chi si trova dalla parte del diritto, quando il suo diritto è calpestato? Chi può darmi al riguardo una risposta diversa dalla mia, ma tollerabile, cioè compatibile con il sussistere dell’ordinamento giuridico e con l’idea della personalità, mi ha battuto”; perché in attività (e problemi) pratici “per quanto riguarda i problemi puramente scientifici ci si può limitare a confutare semplicemente l’errore, anche se non si è in grado di sostituirvi la verità positiva, ma nel caso dei problemi pratici, ove è certo che un problema non può essere non trattato, e ove la questione è come debba essere trattato, non è sufficiente rifiutare come non giusta l’indicazione positiva data da un altro, ma la si deve sostituire con un’altra. Attendo che ciò avvenga riguardo all’indicazione da me fornita; finora, non sono stati compiuti in proposito neanche i primi passi”.
- ...
- E nell’attualità abbondano quelli che Jhering chiamava i “Sancho Panza… i filistei del diritto”, ai quali conveniva l’espressione di Kant “chi si fa verme, non può lamentarsi se viene calpestato”: il risultato delle loro condotte, di mancata coltivazione dei diritti soggettivi, è il venir meno del diritto oggettivo come il grande giurista ripeteva “La vita del diritto è lotta, una lotta dei popoli, del potere statale, degli individui.
- ...
- Ogni diritto nel mondo è stato conquistato, ogni massima giuridica ha dovuto dapprima essere strappata con la lotta a coloro che le si opponevano, e ogni diritto, il diritto di un popolo come quello del singolo individuo, presuppone la disposizione continua alla sua affermazione. Il diritto non è un concetto logico, ma un concetto di forza… La spada senza la bilancia è la cruda violenza, la bilancia senza la spada è l’impotenza del diritto… Il diritto è un lavoro ininterrotto e cioè non è soltanto un lavoro che riguardi il potere dello Stato, ma tutto il popolo. L’intera vita del diritto, vista con uno sguardo d’insieme, ci offre l’immagine di un infaticabile lavorare e lottare… Ogni singolo che si trova nella situazione di dover affermare il suo diritto, svolge la sua parte in questo lavoro nazionale, offre il suo contributo alla realizzazione dell’idea del diritto sulla terra”.
- ...
- Che quello stigmatizzato da Jhering sia l’andazzo prevalente nell’Italia del XXI secolo è evidente.
- ...
- La ripetuta formulazione di leggi che rendono difficoltosa e onerosa l’esecuzione di sentenze, soprattutto nei confronti delle pubbliche amministrazioni ne è la componente saliente. Così come è trascurato quello che sosteneva Jhering, che il diritto è un lavoro di tutto il popolo e non solo (e non tanto) del potere dello Stato. Tanto più quando questo è strumento per l’approvazione e il mantenimento di una classe dirigente decadente: e proprio perciò propensa, come scriveva Pareto, a far uso della furbizia piuttosto che della forza.
- ...
- La seconda questione è la capacità di Jhering di coniugare versanti spesso contrapposti, o quanto meno distinti, in una sorta di complexio oppositorum e così diritto soggettivo ed oggettivo, forza e diritto, norma ed eccezione. L'unità dei quali, o quanto meno la loro coincidenza e sinergia è trascurata o negata. Gli è che Jhering come scrive in “Das Zweek im Recht” ritiene che scopo del diritto sia la vita (collettiva ed individuale) e in ciò manifesta molti punti di contatto con altri giuristi, a cominciare da Hauriou e Santi Romano. E’ un vitalismo giuridico che vede nella norma lo strumento dell’ordine della (e nella) vita comunitaria (come nella metafora della scacchiera di Romano).
- ...
- Un cenno, prima di terminare queste note. Jhering rileva che nel “Mercante di Venezia” Shylock lotta per il proprio diritto, che è, a un tempo, quello di Venezia, come afferma il mercante. A fronte di tale domanda “Il giudice aveva l’alternativa di ritenere valida oppure non valida la cambiale”. Tuttavia “dopo che è stata pronunciata la sentenza del giudice, dopo che è stato fugato dal giudice stesso ogni dubbio sul diritto dell’ebreo, non si osa più contraddire tale diritto… lo stesso giudice, che ha riconosciuto solennemente il suo diritto, glielo rende vano con una scusa, con una malizia così meschina e vergognosa, che non merita alcuna seria critica… egli deve prendere soltanto carne senza sangue e deve tagliare solo una libbra determinata, né più né meno”.
- ...
- Porzia così vanifica il diritto di Shylock non con l’argomento forte della nullità del contratto per “illiceità della causa” (o illiceità in genere) ma con un espediente da causidico di mezza tacca. E, nell’opera di Shakespeare, anche il Doge ritiene di non poter cambiare la legge di Venezia e la sentenza che la applica. In un altro capolavoro teatrale come il Tartuffe di Molière, la conclusione è inversa, perché il rapporto tra legge ed autorità politica è cambiato. Nello Stato assoluto di Luigi XIV è l’occhio vigile del Sovrano, il quale cassando la sentenza pronunciata legalmente dai giudici (ingannati da Tartuffe) salva Orgon e la sua famiglia. Ma lo fa senza espedienti, senza ipocrisia, sicuro della propria autorità e decisione.
- ...
- Come scrive Schmitt a proposito dell’Amleto, in Shakespeare c’è una rappresentazione pre-statuale (cioè pre-moderna) della realtà mentre nella commedia di Moliére, c’è un nuovo protagonista: la monarchia assoluta. E di conseguenza lo Stato sovrano, il quale oggi appare in calo di sovranità (e abbondanza di espedienti).
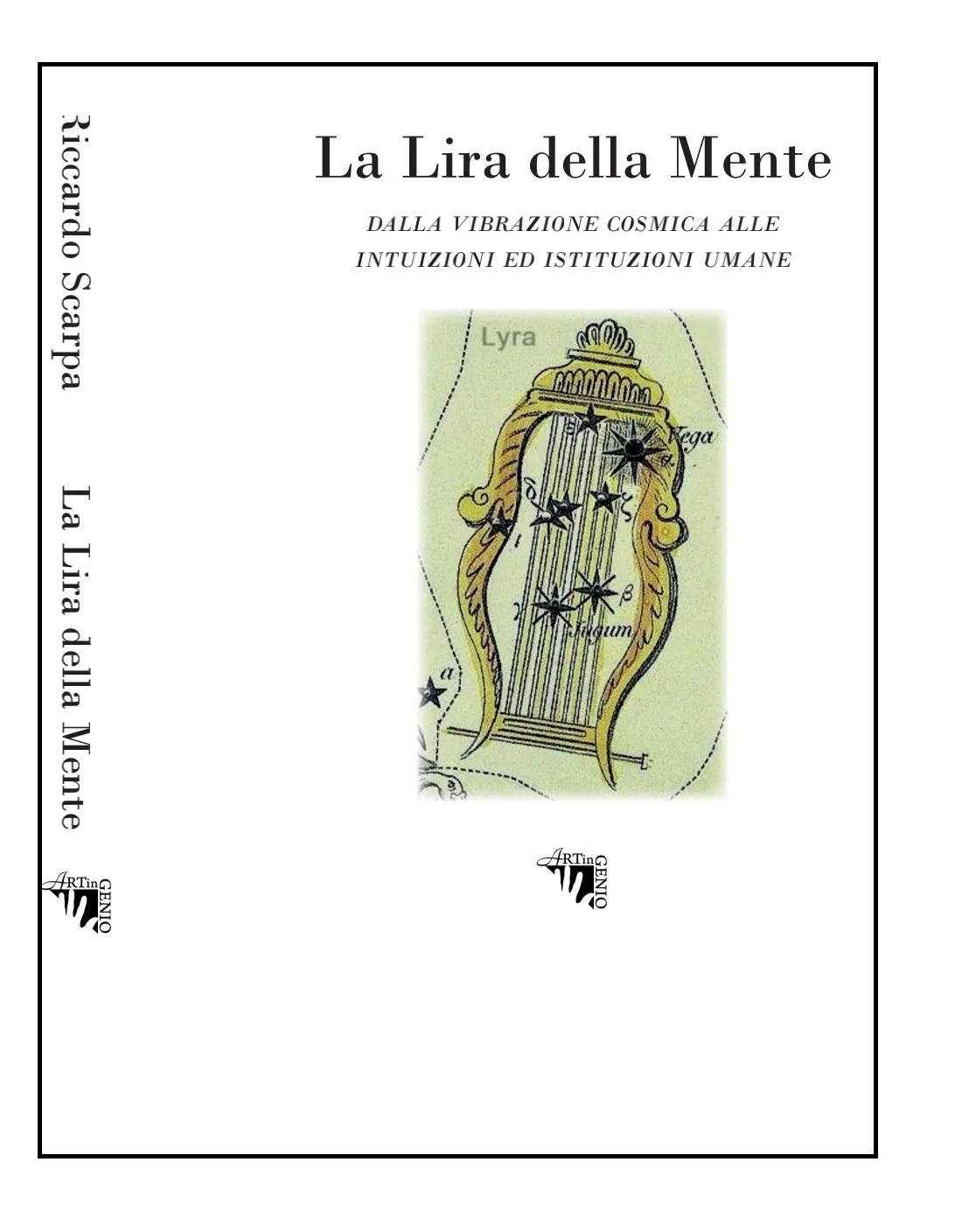
"LA LIRA DELLA MENTE" - (II)
- di
- RICCARDO SCARPA
- L’Ordine Invisibile: Suono, Spirito e Civiltà
- rec. di
- Gabriele Sabetta
La Lira della Mente – Dalla vibrazione cosmica alle intuizioni ed istituzioni umane di Riccardo Scarpa (nelle librerie per i tipi di ArtinGenio editrice) è un’opera complessa e ambiziosa, che esplora l’evoluzione del pensiero umano, le sue radici spirituali e filosofiche, e il legame tra materia e spirito. L’autore adotta un approccio che rifiuta le interpretazioni ideologiche dominanti e propone una visione olistica della conoscenza, dove la spiritualità, la filosofia e la scienza si intrecciano. Il libro è un invito a superare le divisioni tra le varie forme di conoscenza e a riscoprire l’unità della vita, della coscienza e della storia umana. L’autore suggerisce che solo comprendendo il legame tra spirito e materia, tra intuizione e istituzioni, l’uomo potrà ritrovare un equilibrio e una nuova direzione per il futuro.- ...
- L’opera parte da un presupposto fondamentale: tutti i regni della natura (minerale, vegetale, animale e umano) sono interconnessi da un principio universale, identificato nella vibrazione cosmica o Logos. Questa vibrazione primordiale è alla base della manifestazione dell’universo e si riflette in tutte le forme di conoscenza umana, dalle antiche tradizioni mistiche alle moderne teorie scientifiche. L’autore esplora il significato di Logos, la Parola primordiale, che ha dato origine all’universo. Attraverso un’analisi che parte dal Vangelo di Giovanni e arriva fino alla teoria delle stringhe, Riccardo Scarpa illustra come la vibrazione e il suono siano all’origine della materia e della coscienza. La materia, secondo questa visione, non è altro che energia a una determinata frequenza vibratoria.
- ...
- L’opera evidenzia come molte culture abbiano sviluppato una visione del cosmo basata su questa interconnessione: la scienza contemporanea, con la scoperta della radiazione cosmica di fondo e la teoria della relatività, conferma che l’universo è permeato da un’energia vibrante; Pitagora e la scuola italica vedevano nell’armonia musicale una rappresentazione della struttura dell’universo; le tradizioni spirituali orientali, compendiate ad esempio nei Veda e nelle Upanishad, descrivono il cosmo come il risultato di una vibrazione primordiale. L’autore esamina le principali tradizioni sapienziali dell’umanità, ponendo un particolare accento sulle filosofie orientali, greca e romana, collegando le antiche intuizioni religiose alla nascita della filosofia e alla formazione delle istituzioni umane. Un’ampia sezione del libro è dedicata a Roma antica, considerata non solo un’entità storica ma anche un’intuizione spirituale.
- ...
- Vediamo più nel dettaglio alcune sezioni del volume. Pitagora fu un maestro e un filosofo la cui figura, avvolta nel mito, rappresenta il punto di convergenza tra scienza, spiritualità e politica: egli fu incaricato dagli anziani di Crotone di ristabilire l’ordine civile e militare nella città, ottenendo il successo con la vittoria su Sibari e l’egemonia sulla Magna Grecia, ma la sua esperienza si concluse tragicamente con una rivolta che portò all’uccisione dei pitagorici, alla distruzione della sede della scuola e alla cacciata del movimento; tuttavia, il suo insegnamento sopravvisse nei discepoli e influenzò profondamente il pensiero occidentale. La dottrina pitagorica si fondava sull’idea che “tutto è numero”, concependo l’universo come governato da leggi matematiche e armoniche, in cui il celebre teorema non era solo un principio geometrico, ma assumeva un valore simbolico di giustizia e immutabilità delle leggi, riflettendo l’idea che, così come in un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti, anche la verità e l’ordine devono essere perfetti e universali. Pitagora, che si dice avesse viaggiato in Egitto, in Persia e a Babilonia, assimilò e integrò conoscenze mistiche e scientifiche provenienti da culture antiche, apprendendo dai sacerdoti egizi e babilonesi e contribuendo a creare un sistema iniziatico in cui il sapere veniva trasmesso oralmente, riservato ai soli iniziati e disciplinato da regole morali severe quali il divieto di sacrifici cruenti, il rifiuto di giuramenti sugli dèi e la pratica dell’esame di coscienza quotidiano; egli studiò persino la fisionomia umana per interpretare il carattere delle persone e selezionare rigorosamente i suoi seguaci, mentre sosteneva la metempsicosi, la trasmigrazione delle anime, affermando di ricordare vite passate, inclusa quella di un guerriero troiano. La sua influenza fu tale che il termine “filosofo” fu attribuito a lui, e il suo pensiero contribuì a plasmare le idee di Platone, Aristotele e di molte correnti successive, fondendo in un’unica visione il rigore matematico con una profonda ricerca spirituale e una concezione politica basata sulla giustizia universale, rendendo la sua figura un archetipo di ricerca della verità, in cui la vita era paragonata a una festa in cui alcuni competono, altri commerciano, ma i migliori osservano con saggezza e cercano l’essenza della realtà; in questo senso, il contributo di Pitagora non si limitò alla matematica, ma abbracciò ogni aspetto del vivere umano, lasciando un’eredità che ancora oggi stimola la riflessione sul rapporto tra mente, corpo e universo.
- ...
- Un’altra sezione del volume che vogliamo illustrare, è quella che approfondisce la vita e la dottrina di Siddharta Gautama, noto come “Buddha”, che significa “Illuminato”. Nato nella famiglia reale degli Shakya, nella regione dell’attuale Nepal, Siddharta fu allevato nel lusso e protetto da ogni forma di sofferenza dal padre, il re Suddhodana. Tuttavia, la sua esperienza del mondo esterno, attraverso gli incontri con un vecchio, un malato, un cadavere e un monaco asceta, lo portò a prendere coscienza della sofferenza umana e a cercare una via per superarla. All’età di ventinove anni lasciò il palazzo reale e intraprese un lungo cammino di ricerca spirituale. Si sottopose a severe pratiche ascetiche insieme a cinque discepoli, ma capì che l’automortificazione non portava alla “verità”. Dopo aver meditato sotto l’albero della Bodhi a Bodh Gaya, raggiunse l’Illuminazione, scoprendo le Quattro Nobili Verità e l’Ottuplice Sentiero come via per superare il ciclo delle rinascite (samsara). Le “Quattro Nobili Verità” spiegano la natura della sofferenza (Dukkha), la sua causa (il desiderio e l’attaccamento), la possibilità della sua cessazione (Nirvana) e il percorso per raggiungere questa liberazione (l’Ottuplice Sentiero). Quest’ultimo è composto da: Retta Fede, Retto Giudizio, Retta Parola, Retto Proposito, Retta Azione, Retto Sforzo, Retto Pensiero, Retta Meditazione. Buddha rifiutò qualsiasi speculazione metafisica su un’anima eterna o su un creatore divino, affermando che la realtà è impermanente e che l’ego è un’illusione. Il Buddhismo si diffuse grazie ai suoi discepoli, tra cui Ananda e Mahakashyapa, e trovò il suo primo grande patrono nel re Ashoka (III secolo a.C.), che contribuì a diffondere la dottrina in tutta l’Asia.
- ...
- Altre figura su cui si sofferma l’autore è quella di Zarathustra, noto anche come Zarathushtra Spitama. Nacque nell’antica Persia, probabilmente tra il 1500 e il 1000 a.C. Il suo nome significa “colui che tiene il cammello d’oro” oppure “splendore dorato”. Secondo la tradizione, il suo lignaggio apparteneva alla casa degli Spitama, un’antica famiglia nobile di guerrieri e sacerdoti. La Persia dell’epoca era segnata da forti contrasti sociali e morali, con una religione politeista dominata da sacrifici e riti tribali. La società attendeva un grande maestro capace di portare ordine, verità e giustizia. Fin da bambino, Zarathustra mostrò segni di una missione spirituale: si dice che una luce divina brillasse su di lui e che animali sacri, come i lupi e i cavalli, lo proteggessero. Da giovane si distinse per saggezza e integrità morale. Studiò a fondo le tradizioni religiose del suo tempo, ma avvertì presto la necessità di un nuovo insegnamento. Per questo motivo, lasciò la famiglia e si ritirò in meditazione nei deserti e sulle montagne, alla ricerca della verità ultima. Dopo anni di solitudine e ricerca spirituale, ebbe una visione mistica: Ahura Mazda, il Dio supremo, gli apparve e gli rivelò la verità sull’universo. In questo incontro spirituale, gli furono trasmessi i principi fondamentali della nuova fede: l’universo è il campo di battaglia tra il Bene (Spenta Mainyu) e il Male (Angra Mainyu o Ahriman); gli esseri umani devono scegliere consapevolmente da che parte stare, agendo con Buoni Pensieri, Buone Parole e Buone Azioni; il destino dell’anima dopo la morte dipende dalle scelte fatte in vita. Dopo questa rivelazione, Zarathustra iniziò a predicare, ma incontrò forti resistenze da parte della classe sacerdotale e dei capi tribali, che vedevano minacciati i loro poteri e i culti tradizionali. Dopo anni di difficoltà, Zarathustra trovò finalmente un potente alleato: il re Vishtaspa, che si convertì ai suoi insegnamenti e impose la nuova religione nel suo regno. Questo segnò l’inizio dell’espansione dello Zoroastrismo, che sarebbe poi diventato la religione ufficiale dell’Impero Persiano. I suoi seguaci fondarono templi del fuoco, luoghi sacri in cui si custodiva la fiamma perenne, simbolo della purezza e della presenza di Ahura Mazda. Zarathustra insegnò anche l’importanza di vivere in armonia con la natura e con gli altri esseri umani, rifiutando i sacrifici animali e promuovendo la giustizia sociale. Secondo alcune tradizioni, Zarathustra morì a 77 anni mentre difendeva un Tempio del Fuoco dall’assalto di tribù nemiche. Altri racconti narrano che fu colpito da un fulmine divino. Dopo la sua morte, la sua dottrina continuò a diffondersi, influenzando profondamente religioni successive come il Giudaismo, il Cristianesimo e l’Islam. Il concetto di un Dio unico, del libero arbitrio e del giudizio dopo la morte divennero parte integrante del pensiero religioso e filosofico occidentale. Zarathustra fu un profeta rivoluzionario che trasformò il pensiero religioso dell’antica Persia, ponendo al centro la lotta tra il Bene e il Male e l’importanza delle scelte morali. Il suo messaggio di verità e giustizia rimane ancora oggi una delle fondamenta della spiritualità universale.
- ...
- L’ultima parte del libro affronta il tema della Teosofia, intesa come sintesi delle diverse tradizioni spirituali. Scarpa ripercorre la nascita della scuola teosofica di Alessandria, dove Ammonio Sacca cercò di unificare le varie correnti del pensiero antico attraverso l’interpretazione analogica di miti e simboli. La Teosofia si basa sull’idea che tutte le religioni contengano frammenti di una verità universale. Le scuole misteriche dell’antichità, come i culti di Eleusi e di Mitra, cercavano di trasmettere questa verità attraverso riti e iniziazioni. Il cristianesimo introduce una nuova visione della spiritualità, separando la sfera religiosa da quella civile e ponendo le basi per l’evoluzione della società occidentale. Scarpa conclude sottolineando che la storia dell’umanità è il risultato di un processo di elevazione spirituale, in cui l’uomo cerca di comprendere il proprio ruolo nell’universo attraverso il linguaggio, la filosofia e le istituzioni.
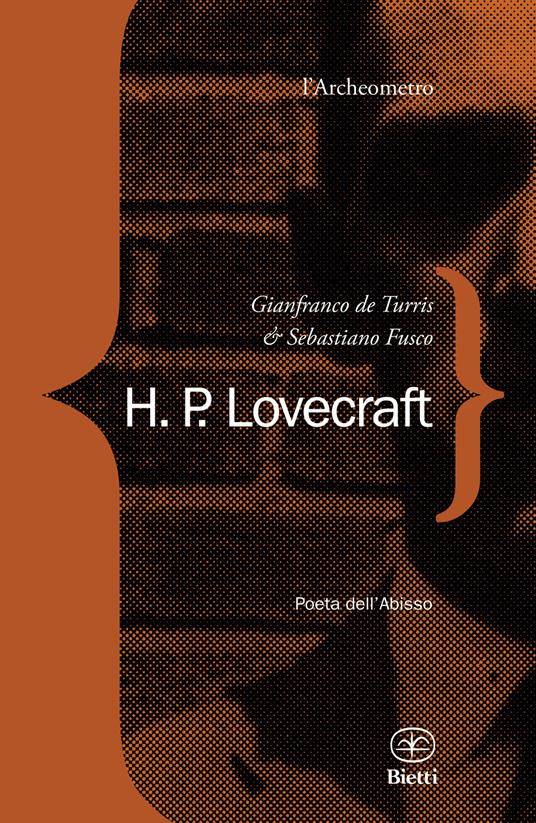
Lovecraft- poeta dell’abisso
- Un prezioso volume del duo
- de Turrisi Fusco
- rec. di
- Giovanni Sessa
de Turris-Fusco: “duo fantastico”- Gianfranco de Turris e Sebastiano Fusco vanno annoverati tra i massimi esperti di letteratura fantastica e fantascientifica. E’ da poco nelle librerie, per i tipi di Bietti, un loro prezioso volume, H. P. Lovecraft poeta dell’abisso (per ordini: 02/29528929). ...
- Il volume uscì, in prima edizione, nel 1979 per La Nuova Italia. Non si tratta però, si badi, di una ristampa. Nella nuova edizione, infatti, compare un’ampia Appendice che contiene una serie di saggi inerenti, tra le altre cose, ai rapporti tra la letteratura del “solitario di Providence” e l’esoterismo, alle traduzioni italiane delle sue opere e agli illustratori dei suoi libri. Inoltre, sono presenti due capitoli, espunti, all’epoca, dalla prima edizione. Essi riguardano le false leggende riguardanti Lovecraft e la sua eredità letteraria.
- ...
- Al “fantastico-duo” De Turris-Fusco va attribuito il merito, come si evince dalla lettura del testo, di aver chiarito come le prime edizioni dei libri dello scrittore in Italia, fossero parziali, tanto per i tagli apportati ai testi, quanto per l’inaffidabilità delle traduzioni.
- ...
- Lovecraft. Biografia esteriore ed interiore
- L’incipit del narrato è dedicato a una minuziosa ricostruzione della biografia dello scrittore, mirata a cogliere non semplicemente i dati esteriori della vita dell’intellettuale, ma altresì a ricostruirne la biografia interiore, essenziale per la comprensione della produzione letteraria. Lovecraft (1890-1937) non poté contare su una famiglia “normale”: in tenera età perse il padre, mentre sua madre: «legò a se il figlio con una affetto possessivo […] Circondava Howard di attenzioni protettive soffocanti» (p. 39), che non consentirono al bambino di crescere, come di solito avviene, con i suoi coetanei. Grazie alla biblioteca di famiglia, il ragazzo presto acquisì conoscenze fuori dal comune per la sua giovane età e, durante l’adolescenza, si cimentò con una serie di saggi, che ne mostrarono la propensione per la creatività fantastica. Dormiva di giorno e scriveva di notte. Il sonno, la dimensione onirica, diventarono per Lovecraft valvola di sfogo e rifugio nei confronti della realtà storico-sociale degli USA degli anni Venti, avvertita come intollerabile.
- ...
- Collaborò con riviste, procurandosi da vivere attraverso la revisione di testi di scrittori esordienti. Nel 1924 si trasferì da Providence a New York, in seguito al matrimonio con Sonia H. Greene, che naufragò già nel 1926: «Dopo il ritorno a Providence, la sua vita trascorse senza scosse né avvenimenti particolarmente significativi sino alla fine» (p. 47). La formazione di Lovecraft era di fatto materialista e meccanicista, ricordano i due autori. Egli ebbe, comunque, il coraggio intellettuale: «di riconoscere che esistono realtà diverse da quelle che appaiono ai nostri sensi; e […] la via che […] ci farà uscire dalle contraddizioni del nostro tempo è il sogno» (p. 27).
- ...
- Del Tragico
- Quella di Lovecraft fu, a parere di chi scrive, una gnoseologia originale e sui generis, sostanziata da una visione filosofica centrata su una rivalutazione del tragico. Lo si evince, in tutta evidenza, da alcune sue lettere pubblicate all’inizio del libro. In esse, tra l’altro, si può leggere: «Dato che l’intero piano della creazione è puro caos […] non vi è necessità di tracciare una linea fra realtà ed illusione. Tutto è mero effetto di prospettiva» (p. 22). Non esitono fatti, come seppe Nietzsche, ma interpretazioni degli stessi. Tale concezione è a-teleologica e, in tema, lo scrittore rileva: «Io non riesco a immaginare in altro modo lo schema della vita e delle forze cosmiche, se non come una massa di punti irregolari riuniti in spirali senza direzioni» (p. 22). Ancora più significativamente: «credo che il cosmo sia un insieme senza scopo e senza significato di cicli interminabili […] consistente soltanto di forze cieche che operano secondo schemi fissi ed eterni» (p. 23).
- ...
- La materia cui guarda il “solitario di Providence” è lucreziana, animata, non è “materia” da intendersi in senso moderno. Egli ha contezza del fatto che la trascendenza vive solo nell’immanenza, nella physis e, in essa, sancisce la magica possibilità dell’impossibile. Un cosmo leopardiano, quello di Lovecraft, orrido e meravigliante in uno. Il suo sguardo di “osservatore distaccato”, la sua curiositas di indagatore, è avulsa dal qualsivoglia antropocentrismo, come nelle corde del grande recanatese (Dialogo di un islandese e della Natura). Il conservatorismo esistenziale e politico dello scrittore fantastico, va inteso, allora, quale risposta al caos, un tentativo di ordinare, di dar “forma”, sia pure momentanea, a ciò che ordinato non è. Lo sforzo letterario che lo contraddistinse è mirato a presentare: «un tipo di visione magnificata che conferisce strani colori all’universo, e che riveste le circostanze della vita d’un fascino mistico ed un significato occulto» (p. 25).
- ...
- Simbolo e divino
- De Turris e Fusco ricostruiscono e analizzano, in modalità convincente, informata e organica, l’opera omnia di questo creatore di mondi immaginari, alla luce di una bibliografia critica assai ampia. Ne analizzano gli esordi, si soffermano sui “miti di Cthulhu”, sulla visione fantascientifica che traligna dalle sue pagine, sui rapporti con l’occulto, sulle lettere e le poesie, sulla struttura linguistica della sua prosa coinvolgente, nonché sul messaggio finale che la connota. Chiariscono, inoltre, le sue ascendenze culturali, da Dunsany a Poe, per citare solo alcuni degli “autori” di Howard.
- ...
- In particolare, notano che le figure simbolico-divine cui lo scrittore fa riferimento: «incarnano, il cieco terrore dell’individuo razionale posto di fronte ad un abisso cosmico» (p. 111), parallelo all’abisso che vive in interiore homine, nel foro interiore di ognuno di noi. L’uomo della ratio, attraverso gli universali e i concetti, staticizza l’essere sempre all’opera della vita, il carattere veicolare e metamorfico di ogni ente di natura, e richiude l’abisso. Lovecraft, di contro, tenta di ridare vigore alle potenze che abitano il cosmo e l’uomo, questa la funzione svolta dai “miti di Cthulhu”: «nella sua narrativa non trovano posto divinità benevole o malevole, ma soltanto manifestazioni cieche di forze indifferenti, che agiscono tanto a livello universale quanto individuale» (p. 118). Il lettore non sia tratto in inganno da questa affermazione: il tragico puro, quando venga vissuto in modalità autentica, concede, lo seppero gli Stoici, serenità. Ha tratto rasserenante di fronte all’orrido e al meravigliante della vita.
- ...
- Per questa ragione, Lovecraft, poeta dell’abisso, è libro da leggere e meditare, soprattutto oggi, in quanto la dismisura messa in campo dalla Forma-Capitale ha colonizzato l’immaginario degli uomini. In tal senso, la lettura di queste pagine ha effetto liberante nei confronti degli idola della post-modernità. Non è cosa di poco conto…
Gianfranco de Turris - Sebastiano Fusco, H. P. Lovecraft, poeta dell’abisso, Bietti, pp. 314, euro 24,00.
-
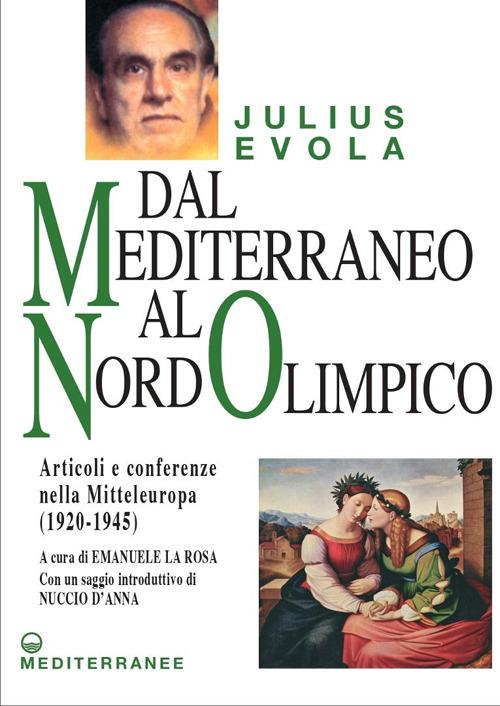
Dal Mediterraneo al Nord Olimpico- Una raccolta di articoli e conferenze di
- Julius Evola
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Una nuova raccolta evoliana
- Julius Evola è stato pensatore dalla produzione assai vasta. Nel corso della sua esistenza, in particolare a muovere dagli anni Venti del secolo scorso, intrattenne una serie di relazioni con personaggi di primo piano dell’ambiente politico e, soprattutto, culturale, italiano ed europeo. Compì numerosi viaggi nella Mitteleuropa, si recò, più volte, in Austria, Germania, Ungheria, Romania. È da poco nelle librerie una silloge, davvero preziosa, di articoli e conferenze del pensatore tradizionalista che permette di far luce sulle sue vaste relazioni internazionali, oltre che sulle sue intenzioni politiche-metapolitiche, negli anni decisivi che vanno dal 1920 al 1945. Ci riferiamo a Julius Evola, Dal Mediterraneo al Nord Olimpico. Articoli e conferenze nella Mitteleuropa (1920-1945) comparso nel catalogo delle Edizioni Mediterranee (per ordini: ordinipv@edizionimediterranee.net 06/3235433).
- ...
- Novità del libro
- Le traduzioni dei testi e la curatela del volume si devono a Emanuele La Rosa, collaboratore della Fondazione Evola, che in Archivi e biblioteche tedesche ha rintracciato articoli finora non noti o mai tradotti in italiano. La Rosa e Nuccio D’Anna, studioso di storia delle religioni e simbolismo, firmano i due saggi introduttivi, propedeutici alla comprensione dell’azione di interventismo "tradizionale" messa in atto da Evola nell’Europa centro-orientale. Il libro si segnala, inoltre, per la sua terza parte che raccoglie articoli dedicati ad Evola dalla stampa di lingua tedesca del tempo, molti ancora inediti nella nostra lingua, e per l’Appendice costituita dalla rassegna stampa dedicata all’Evola pittore. I viaggi, gli scritti e le conferenze del tradizionalista miravano alla costituzione di un fronte comune pan-europeo, rivoluzionario conservatore, atto, da un lato, a “rettificare” i limiti teorico-pratici del fascismo e del nazionalsocialismo e dall’altro capace di dare una risposta forte e convincente alla pervasività del moderno in ogni ambito della vita. Rileva D’Anna: «in questi suoi interventi non tralasciava di indicare comportamenti “esemplari”, forme di costume e modelli esistenziali considerati importanti in una società che in seguito al pesante crollo economico del 1929 era sprofondata in una pesante crisi d’identità» (p. 9). A parere di chi scrive, la rivista più prestigiosa sulla quale comparvero gli scritti di Evola fu Europäische Revue, del principe Rohan. Ad essa collaborarono, tra gli altri, W. F. Otto, Heidegger, Schmitt, Sombart, C. G. Jung e il nostro Ernesto Grassi. In ogni caso, anche su altri periodici: «Evola continuerà a muoversi […] verso un’unica direzione le cui caratteristiche fondamentali appaiono ordinate attorno a tradizioni sacre […] simboli e forme del pre-politico che trovano su un piano metastorico la propria autentica ragion d’essere» (p. 11). Per Evola, infatti, l’ordinamento dello Stato della Tradizione era connotato dalla sintesi di due potenze, quella temporale e quella spirituale (Melkitsedek), che il medioevo ghibellino tentò di ripresentare nella storia (sagra del Graal). Alla luce di tali posizioni il tradizionalista operò per rafforzare, in termini non meramente politici, l’alleanza italo-tedesca. In questa silloge compaiono, inoltre, scritti attraverso i quali Evola critica la versione meramente biologica del razzismo che si era affermata in Germania, nel nome di una razza dello spirito, tradizionale, consapevole della tripartizione umana in spirito, anima e corpo.
- ...
- Imperialismo pagano in Italia e Germania
- Da alcuni dei contributi evoliani si rilevano, come coglie La Rosa, differenze importanti tra la versione italiana di Imperialismo pagano e la sua traduzione tedesca del 1933: nella prima, il pensatore: «contrappone al “pericolo euro-cristiano” la funzione positiva di una ripresa della tradizione mediterranea, in quella tedesca si fa latore della tradizione nordico-germanica» (p. 31).
- Il cambiamento di prospettiva va imputato a ragioni biografiche (la rottura con Reghini, neo-pitagorico e sostenitore della vichiana antiquissima italorum sapientia, finita in tribunale) e a motivazioni ideali. Certo, come si evince dal saggio del curatore, ci fu una scelta strategica di Evola, di impianto “machiavellico”, mirata a spostare la sua influenza teorica nei paesi della Mitteleuropa, per la qual cosa le due versioni di Imperialismo pagano possono essere intese: «come due programmi politici differenti per forma e contenuto […] come una proposta (meta) politica ora offerta al governo fascista, ora a quello nascente nazional-socialista» (p. 32). Il mutamento teorico è spiegabile anche per ragioni ideali: dopo l’incontro con Guénon, Evola cambiò prospettiva rispetto alla civiltà mediterranea e guardò con altri occhi alla Rinascenza italiana. Mentre in Imperialismo pagano, Giordano Bruno e la filosofia del Rinascimento (come nelle opere filosofiche) hanno ruolo di un certo rilievo, dai primi anni Trenta il filosofo della vicissitudine universale e i neoplatonici del Quattrocento non sono più citati, se non termini negativi. In Rivolta, il tradizionalista giungerà ad affermare: «La vera Rinascenza (della Tradizione) è il Medioevo». Evola: «traslittera nell’idea imperiale quella della realizzazione dell’individuo […] la cui regola base è il principio di solidarietà tra gli elementi di un organismo» (p. 33). L’Impero diviene il modello metapolitico del filosofo, risposta tanto all’internazionalismo marxista quanto alla plutocrazia americana. Medesima curvatura “nordica” viene messa in atto rispetto ai simboli, dal fascio littorio si passa all’aquila imperiale: «Evola deve “machiavellicamente” operare attivando forze trainanti, simboli e miti […] che siano capaci di affascinare […] il pubblico cui si rivolge» (p. 35).
- ...
- La crucialità del pensiero evoliano
- Tale interventismo tradizionale non produsse gli effetti sperati né in Italia, né in Germania. Si evince, comunque, anche da questa importante raccolta, il lascito iperbolico del pensatore. Sul piano individuale esso è simbolizzato dall’individuo assoluto, latinamente “sciolto”, liberato, perfino da se stesso, proteso nella tensione esistenziale indotta dall’incipit vita nova. Il suo esistere è già, in se stesso, esemplare, rinvia, metapoliticamente, al sublime superamento delle organizzazioni politiche contemporanee. La sua arbitrarietà non può venir intesa dall’occhio moderno, educato alle distinzioni escludenti indotte dal logo-centrismo. Dal mediterraneo al Nord Olimpico è opera che fa ulteriore chiarezza sul pensiero abissale di Julius Evola, per questo da leggere e meditare con sguardo non-rappresentativo, assoluto, oltre la dicotomia soggetto-oggetto, in quanto, per Evola, fenomeno e noumeno dicono il medesimo…
Julius Evola, Dal Mediterraneo al Nord Olimpico. Articoli e conferenze nella Mitteleuropa (1920-1945), a cura di Emanuele La Rosa, Edizioni Mediterranee, pp. 331, euro 31,50.
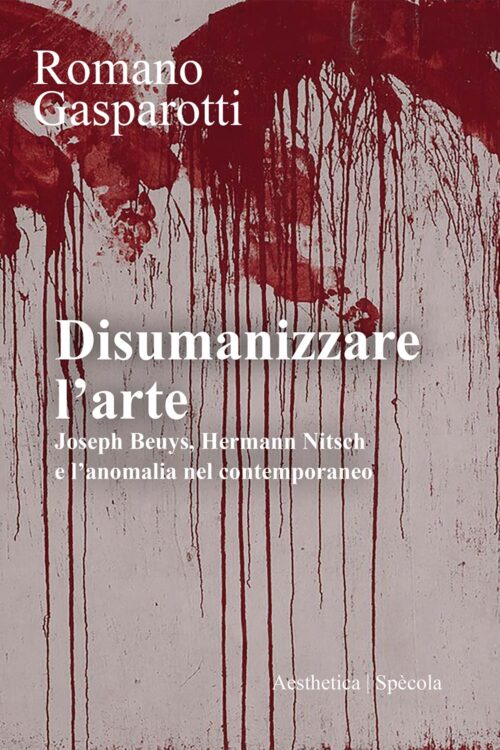
Disumanizzare l’arte- Romano Gasparotti
- a confronto con
- Joseph Beuys e Hermann Nitsch
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Romano Gasparotti, filosofo e performer di danza profonda, nella sua ultima fatica, "Disumanizzare l’arte. Joseph Beuys, Hermann Nitsch e l’anomalia del contemporaneo", nelle librerie per Aesthetica Edizioni (per ordini: info@aestheticaedizioni.it) si confronta con due artisti-filosofi di primissimo piano, Beuys e Nitsch, il cui pensiero e la cui opera non hanno, finora, avuto la considerazione che meritano. Gasparotti, con questo libro, riconosce la loro grandezza ed imprescindibilità, almeno per quanti guardino con interesse a un cogitare altro da quello prevalso in Occidente, centrato sul logo-centrismo e il primato del principio d’identità, nonché dei succedanei principi della non-contraddizione e del terzo escluso. L’autore conobbe personalmente Nitsch e, fin dall’adolescenza, fu attratto dalle prospettive teorico-pratiche di Beuys. Il metodo esegetico di cui si avvale non fa riferimento alla comparazione, in quanto tale strumento: «risulterebbe forzato […] perché è la natura stessa del lavoro dei due grandi maestri che lo respinge e lo rifiuta» (p.13).
- ...
- Disumanizzazione dell’arte
- Le similitudini, come mostrato da Magritte, sono espressione del pensiero logico-discorsivo, mentre il co-gitare kairosofico, rinviando all’“agitarsi in relazione agli altri”, vive di somiglianze. Non è casuale che Beuys giunse alla pratica che, nonostante la sua lezione centrata sul superamento dell’autonomia dell’arte, viene ancora definita “artistica”, a seguito di studi scientifici. Tali studi lo convinsero dei limiti della visione matematizzante del mondo. Le azioni artistico-teatrali di Nitsch, allo stesso modo: «costituiscono il più potente e radicale antidoto nei confronti degli effetti intossicanti del razionalismo iperapollineo» (p. 14). Questi mirò, sotto la spinta di una lettura non convenzionale del poema di Parmenide, a vivere, con l’Orgien Mysterien Theater, i “momenti sovrani” dell’esperire, vale a dire ebbrezza, erotismo, riso, l’“attimo immenso” dionisiaco. I due maestri hanno, di fatto, messo in atto la disumanizzazione dell’arte auspicata da Duchamp. Tale disumanizzazione mostra: «come il cogitare creativo che si mette all’opera […] dappertutto» riduca la logica a mera dimensione strumentale. Beyus e Nitsch testimoniano, come i Sapienti (da sapio: gli “assaporanti”) della Grecia, che “tutto è in tutto”, che ogni corpo e le stesse produzioni artistiche, sono veicoli nei quali momentaneamente pare “sostare” la dynamis, potenza-possibilità che, nella physis, è sempre in fieri.
- ...
- Ultrafilosofia
- Tale concezione ribalta il primato concesso da Aristotele all’atto e si pone oltre l’antropocentrico primato del “vedere” che “cosalizza” il mondo, senza, comunque, negarlo, sublimandolo in una visione sinestetica, che chiama in causa udito, tatto, olfatto e gusto. Il lavoro creativo, pertanto: «non si riduce affatto alla produzione autonoma e speciale da parte di un soggetto […] le sue manifestazioni in progress non sono sostanze, non sono oggetti» (p. 17). L’arte non è poiesis ma praxis sempre in opera, come si evince dal: «modello dinamico della musica, della danza e dell’azione teatrante» (p. 17). Beuys, memore della lezione warburghiana, ritiene la propensione melanconica dell’artista latrice di uno sguardo altro rispetto a quello meccanico-causale. Tale “visione” induce la dimensione festiva dell’arte totale quale ultrafilosofia, ben oltre le stesse intenzioni wagneriane. In essa, si incontra il tratto ritmico-relazionale-fluente della vita, tacitato dal dialogo, strumento sul quale la logica diairetica, ha costruito la modernità e la post-modernità. Di contro, la conversazionalità improvvisante libera il dire dalle ossificazioni semantiche: «La conversazione […] dà corso ai liberi flussi e controflussi di una prassi corale dal carattere estemporaneo […] mai finalistico» (p. 23). Non con-vince, persuade.
- ...
- Disforia, mito e tragedia
- L’operare nel flusso della vita, da parte dei due artisti, è “disforico”: «La disforia, intesa in senso lato, contraddistingue l’anomalia dell’arte contemporanea, mandando in corto circuito, senza negarla, la tradizionale macchinazione prometeica che è […] volta a programmare […] controllare euforicamente ogni forma del pensare e del fare» (p. 27). Beuys e Nitsch hanno espresso tutto questo in un gioco di mascheramenti, in quanto: «ogni forma di vita si presenta nel suo typos ricorrente unico […] tanto quanto anonimo e generico» (p. 31), rinviante al mito. Non al mito inteso, sic et simpliciter, come qualcosa che sta “prima” di altro, ma quale: «dinamica e plastica manifestazione, sempre risorgente nelle sue imprevedibili figure, della forza di un cogitare, che proviene da un incrollabile fuori e non appartiene a nessuno» (p. 33). L’arte di Beuys e Nitsch è sacra e magica, sciamanica, liberante: pone gli uomini nella possibilità di esperire il mondo come lo percepiscono gli altri uomini, gli animali o le piante. Un sacro che affascina e terrifica in uno: la visione tragica, lo intese Nietzsche, sa che la vita “mangia se stessa”. Alimentarsi, mangiare è un sacrum-facere nel quale sperimentiamo che “tutto è in tutto”. Violenza “pura”, l’avrebbe definita Benjamin. I due maestri, nel loro speculare, mettono all’opera: «la cangiante pluralità dei mondi stessi, nel ri-velare il mistero della loro provenienza» (p. 47), come nelle corde della tragedia attica.
- ...
- Figurazioni del possibile
- Le opere di Beuys e Nitsch sono figurazioni del possibile, in quanto non riducibili all’oggetto, all’excrementum (Derrida). Suggeriscono di portarsi oltre la pittura e la scultura intese retinicamente, in quanto: «Ogni emergenza sensibile […] è l’evidente segnalarsi del momento traboccante di una materia viva ed effervescente in perenne autoformazione» (p. 63). “Ogni uomo è artista”, rilevò Beuys, anche gli uomini che camminano per le strade sono: «instancabilmente impegnati nell’opera condivisa di una danza collettiva» (p. 95). In natura tutto danza, le api, gli insetti, i pianeti in quanto ogni “ente” testimonia, nella sua animazione, la “vicissitudine universale” della “materia”, come colsero, in modalità diversa, Bruno e Spinoza. L’arte, come la intesero i due maestri, è allora davvero ultrafilosofia, mette in scacco i limiti del pensiero logocentrico. A essa è necessario rivolgersi per liberare le nostre vite dallo sguardo relativo, divisivo ed escludente sul quale è costruito il mondo nel quale viviamo. Le pagine di Gasparotti, se opportunamente lette, risvegliano lo sguardo assoluto sulla realtà. Esigono, non semplici lettori, ma uomini disposti a compiere un “cambio di cuore” radicale al fine di cogliere l’aporia, il non, che ogni positivo dice.
Romano Gasparotti, Disumanizzare l’arte. Joseph Beuys, Hermann Nitsch e l’anomalia del contemporaneo, Aesthetica Edizioni, pp. 165, euro 16,00.
- L’ODIO e il NEMICO
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Nel prologo del dramma di Montherlant “La guerre civile”, questa, presentandosi, dice “Sono la guerra della piazza inferocita, la guerra delle prigioni e delle strade, del vicino contro il vicino, del rivale contro il rivale, dell’amico contro l’amico. Io sono la Guerra civile, io sono la buona guerra, quella dove si sa perché si uccide e chi si uccide: il lupo divora l’agnello, ma non lo odia; ma il lupo odia il lupo”. Già Clausewitz, col Vom Kriege aveva individuato, anche nella guerra tra Stati lo spazio per l’odio nel sentimento ostile che s’accompagna, ma non sempre, a molte guerre internazionali, mentre ad ogni guerra è connaturale l’intenzione ostile.
- ...
- Nel dibattito sull’assassinio di Charlie Kirk l’odio ha avuto un posto rilevante: e non pare che l’abbia occupato abusivamente, almeno a seguire la tesi di Montherlant. Quel che consegue da questa e dall’opinione di Clausewitz è che non è un elemento necessario in tutte le guerre onde ve ne sono state condotte senza odio: nel libro (postumo) che raccoglie scritti di Rommel, il titolo era Guerra senza odio, riferendosi a quella praticata dal generale tedesco.
- ...
- Ma non è così per le guerre civili: la coesione in un gruppo sociale, e così in un popolo, presuppone una certo tasso d’amicizia che valga a co-fondare l’unità politica con l’idem sentire de re-publica; se questo non c’è o è carente, i contrasti d’interesse, volontà, opinioni diventano determinanti e corrodono l’unità politica, fino (talvolta) a sfociare nelle guerre civili. Il carburante principale delle quali è l’odio, come ritenuto da Montherlant.
- ...
- Una delle caratteristiche di quello contemporaneo è che divide le comunità in senso orizzontale: da una parte le élite e il loro seguito, dall’altra la parte maggioritaria o comunque in crescita dei governati. Resta il fatto che, almeno in unità politiche con popolazione omogenea, quindi tale per lingua, religione, costumi, storia (e gli altri “fattori” indicati da Renan) occorre (creare, o) aumentare divisioni esistenti in grado di detronizzare quella principale a fondamento dell’unità politica. Ove non si può contare su differenze reali o almeno decisive, occorre lievitarle di guisa da creare un (nuovo) nemico che abbia la conseguenza, naturale in ogni conflitto, di rinsaldare la coesione del gruppo sociale che a quello si oppone. A portata di mano, per realizzare tale operazione, c’è l’intensificare l’odio al nemico scelto. In mancanza di differenze reali si corre così il rischio di crearne di immaginarie.
- ...
- Una variante delle quali è di identificare il nemico quale nemico dell’umanità o di caratteristiche umane (vedi i “diritti umani”) come sottolineato già un secolo fa da Carl Schmitt; a cui non erano estranei neppure i nazisti quando consideravano i popoli dell’Unione Sovietica degli untermenschen, cioè sotto-uomini, destinati a estingursi o a servire quello tedesco. Molto meglio per assicurare la pace e l’intesa tra popoli la concezione (e la prassi) romana che gli stranieri non erano così diversi (alienigeni) dai romani da non potersi accordare in una pace e una coesistenza concorde e nel comune interesse.
- ...
- Per cui l’odio è un moltiplicatore dei conflitti, se rivolto a creare nemici all’interno dell’unità politica, inversamente proporzionale alla coesione e potenza della stessa, nei conflitti internazionali, può diventare un elemento di coesione, ma non (o poco) controllabile.
-
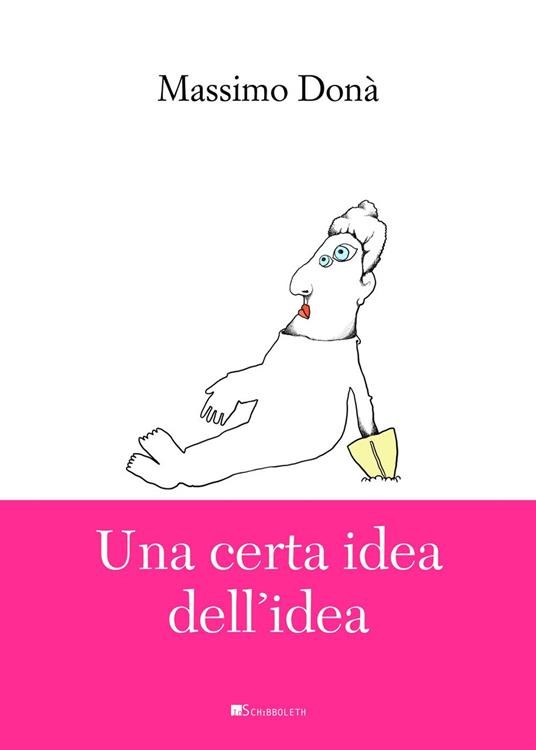
"Una certa idea dell’idea"- L’ultimo saggio del filosofo Massimo Donà
- Una filosofia della singolarità
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- È nelle librerie, per InSchibboleth editore, l’ultima fatica di Massimo Donà, Una certa idea dell’idea (per ordini:info@inschibbolethedizioni.com). Un volume che, fin dal titolo, immette nel cuore delle problematiche teoretiche che stanno al centro della filosofia donaiana. Libro agile, che crediamo di poter definire, sommario e summa della visione del mondo del pensatore veneziano. Abbiamo scritto, in altro contesto, essere il pensiero di Donà, filosofia ritmica della singolarità. In queste pagine, l’autore immette il lettore nelle complesse problematiche che il testo discute, con prosa coinvolgente, strutturata in domande e risposte, che egli pone, innanzitutto, a se stesso e, di rimando, al possibile interlocutore. Non si tratta dell’ennesima applicazione del metodo dia-logico, ma esempio di civiltà del conversare: un con-versare corale che non mira a con-vincere, ma a rendere persuasi (Michelstaedter) i partecipanti alla cerca. Non poteva essere diversamente: a venir messo in questione è il primato dell’idea, del concetto, dell’universale, insomma del lógos come si è affermato a muovere dalla filosofia classica per giungere a Hegel.
- ...
- Oltre gli universali
- Allo scopo il filosofo-musicista (è jazzista) recupera il valore della fantasia, servendosi degli studi prodotti in tale ambito, tra gli altri da Ernesto Grassi e Gianni Celati. La via teoretica cui guardò Grassi non era: «fondata tanto sul lógos universalizzante e incontrovertibile, quanto piuttosto su una giusta mistura di individualità e universalità» (p. 12), come nelle corde della “ragione poetica” del dimenticato Gaetano Chiavacci. Un via che “salva” il singolare, l’individuale, di fronte al quale perpetuamente sorge la domanda filosofica. Una posizione che guarda al “poetico” e al “fantastico”, esperiti come originari.
- ...
- La fantasia, infatti, non è da intendersi quale negazione del lógos, ma come suo presupposto. Il fantastico restituisce: «la vera complicazione che caratterizza l’umana esistenza, le mille sfumature di cui la medesima è fatta […] i suoi mille modi d’essere - e non solo quelli riconducibili alla regolarità» (p. 14) Insomma, è necessario porsi oltre gli universali, in quanto dell’unicità di ogni vita: «il linguaggio razionale non può dire e non dice nulla» (p. 14). L’individuale testimonia: «l’originaria manifestatività di quel che sorge libero da ogni vocazione destinale […] punto di partenza di un percorso del tutto imprevedibile» (p. 15). La filosofia della singolarità procede verso l’abisso che anima ogni “esser-qui”, “evento” sempre esposto al novum, alla dissonanza nei confronti della regolarità previsionale della scienza.
- ...
- Linguaggio e immagine
- Tale “vedere”, si serve del linguaggio in modalità indicativa, non dimostrativa, si affida a una scrittura immediata che si dà: «nella forma di un semplice linguaggio immaginale» (p. 18). Le immagini riflettono il flusso, la continua metamorfosi della dynamis, ben oltre la quiete apparente imposta dai concetti. Non si tratta di una realtà illusoria, al contrario: l’illusione è quella indotta dalle staticizzazioni degli universali: «Realissima è […] proprio la molteplicità […] dove ogni individuo si costituisce come unico ed irripetibile» (p. 21). Si tratta, in fondo, non tanto di conoscere ma di capire, scardinando il dualismo che vige in ogni rappresentazione, in cui il soggetto è distinto dall’oggetto. La realtà della vita sempre all’opera nega le significazioni, le distinzioni escludenti prodotte dalla logica identitaria: «l’unicità conviene a tutto ciò che non si lascia accomunare a nulla» (pp. 23-24). Essa è tacitata nell’esperire il mondo in termini di oggettualità. È necessario, pertanto, porsi alla cerca del “chi” non del “che cosa” degli essenti. In tal caso, si scopre l’incondizionatezza pura. L’ente è colto nella sua irriducibilità al mondo che, comunque: «non sarà mai qualcosa d’altro rispetto ad esso» (p. 27).
- ...
- Del Principio
- Ma cosa anima gli essenti? Il principio. Esso non è un essente, ma non è posto, in alcun caso: «al di là dell’essente» (p. 30). Le cose portano alla presenza il medesimo, il non originario, non dicono nulla di determinato: «ma mostrano […] quel Principio il cui mostrarsi […] è identico al suo non mostrarsi mai» (p. 31). La vera filosofia ha, quale presupposto, la fede in questa “sacra negazione”. Non può essere, sic et simpliciter, sapere acquisitivo, apodittico, affermativo. Guarda l’aporia custodita dalla vita, scopre che le cose, leopardianamente, non sono mai quel che dicono di essere. Il vero filosofare conduce oltre la permanenza e stabilità dell’idea, sospingendoci nell’in-tra di essere e nulla, sulla soglia del tempo, oltre la quale vivono gli “opposti” assoluti. È via erratica in quanto, come colto da Abelardo (status), anche l’universale esiste: «ma senza mai essere ancora quel che è» (p. 47). La fantasia ha ruolo di primo piano perché destruttura le griglie del fenomenico empirico e lascia vedere: «quello che c’è», fenomeno e noumeno si danno in uno. Lo seppe Kandinsky: guardando il “movimento puro” si entra nel “cuore del reale”: «la vita è caratterizzata da una continua lotta, in virtù della quale gli opposti continuano a far emergere l’indisgiungibilità della luce e del buio di cui siamo tutti contraddittorie, ma divine manifestazioni» (p. 59).
- ...
- Della fantasia e del gioco del mondo
- Gianni Rodari ha insegnato che la fantasia immaginativa è: «alimentata da quei “binomi di concetti” che ci consentono di rompere il rigido involucro che solitamente supporta le parole» (p. 63). I significati quotidiani vanno ricomposti, al fine di concedere loro la gratuita ludicità del linguaggio infantile: «il bambino comincia presto ad intravvedere questo più o meno sotterraneo commercio tra essere e non essere; e a “giocare”», rileva Donà.
- ...
- Il pensatore veneziano presenta, in una esegesi compiuta e con persuasività d’accenti interpretativi, quanto Aristotele e Platone, in particolare nel Parmenide e nel Sofista, sostennero in merito al rapporto Essere/Nulla. Coglie le grandi intuizioni di questi pensatori, ma ne mostra, altresì, i limiti. Donà afferma che Platone ebbe ben chiara: «la co-originarietà dei due principi […] L’Uno e la Diade» (pp. 87-88), per la qual cosa, chiosa l’autore, l’idea non può esser posta in un altrove sovramondano. L’Ateniese non lesse il mito come ciò che, semplicemente, indica “un prima” del lógos, anzi esso rappresenta un’ulteriorità teorica rispetto alla ragione discorsiva. Donà, infine, si confronta con lo statuto dell’immagine. Con Andrea Emo, nota: «Le immagini sono le metempsicosi dell’unica anima, dell’eterna unica fenice che si brucia e si consuma in un’immagine, e rinasce in un altro nido, altra e medesima, e con nuovi colori […] la sua sola giustificazione sono altre immagini» (p. 99).
- ...
- Tutto ciò è testimoniato dall’arte che, quando è veramente tale, ha valenza filosofica, “capisce” il mondo e riflette le “verità della natura”, abisso da cui tutto sorge e a cui tutto fa ritorno. Libro liberante, chiarificatore, Una certa idea dell’idea, in qualche modo nietzschiano, “per tutti e per nessuno”.
Massimo Donà, Una certa idea dell’idea, InSchibboleth, pp.120, euro 15,00.
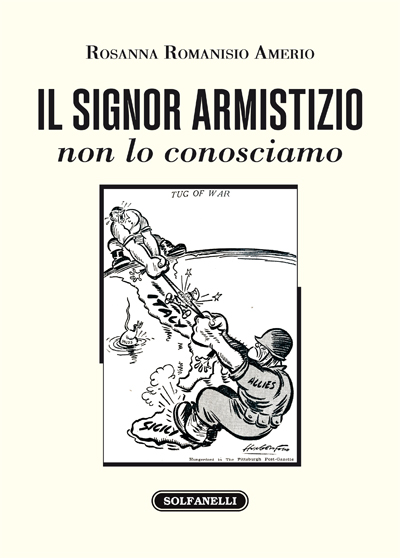
A proposito dell’Armistizio dell’ 8 settembre- Un’importante ricostruzione storico-giornalistica di
- Rosanna Romanisio Amerio
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Rosanna Romanisio Amerio, appassionata studiosa di storia nonché pubblicista di vaglia, come ha mostrato la curatela, condivisa con Gianfranco de Turris, di un’opera di Enrico de Boccard, ha da poco dato alle stampe un volume che mira a fare (finalmente!) chiarezza sull’armistizio dell’8 settembre 1943, le cui conseguenze hanno profondamente inciso sulla storia italiana contemporanea. Stiamo parlando dell’ampio volume, Il Signor Armistizio non lo conosciamo, nelle librerie per i tipi di Solfanelli (per ordini: 335/6499393; edizionisolfanelli@yahoo.it,). Il testo è aperto dalla presentazione di Gianluca Barneschi e da una breve nota di Alessandro Allemano.
- ...
- Barneschi rileva quanto segue: «le lettura e lo studio del risultato delle pluriennali fatiche di R. Romanisio Amerio […] aiutano a capire cosa effettivamente accadde in quella tragica estate […] grazie ad acquisizione documentali, anche recentissime» (p. 5). Il volume è impreziosito da un importante apparato fotografico e dalla raccolta dei documenti dei quali l’autrice si è servita nella stesura del testo.
- ...
- Romanisio Amerio, fin dall’incipit di queste pagine, precisa di non essere una storica di professione. In realtà, i documenti che ha ritrovato, in Archivi italiani e non solo, mostrano che la curiositas che ha animato la sua ricerca è sostenuta da una non comune acribia investigativa e, spesso, anche dal dubbio scettico che, in molti casi, la storiografia accademica non conosce. La studiosa precisa, a proposito del metodo seguito ne, Il Signor Armistizio non lo conosciamo: «la ricerca è qui raccontata come in un diario» (p. 28). Ciò rende le sue pagine godibili anche dal lettore meno informato, tanto da trasformare il narrato, centrato su basi documentali incontestabili, un’avvincente spy story. Tra i documenti inediti, ritrovati dalla ricercatrice, va, innanzitutto segnalato lo: «Short Military Armistice, il cosiddetto “armistizio breve” del 3 settembre 1943, corredato dalla firma del generale di brigata Giuseppe Castellano e […] del maggiore generale Bedell Smith, capo di S. M. dell’esercito USA» (p. 15). Si tratta dell’ “armistizio di Cassibile” che, in realtà, fu firmato nel Fairfield Camp, allestito nell’antica Masseria S. Michele, nei pressi di Cassibile. Il documento fu redatto in tre copie, di cui il Ministero degli Esteri italiano conserva solo una copia priva di firme, in quanto l’originale fu distrutto per ordine del capo di S. M., generale Vittorio Ambrosio. Un altro documento ritrovato è quello dell’armistizio firmato a Malta il 29 settembre 1943, l’ “armistizio lungo”, che ebbe due versioni corredate dalle firme di Badoglio e Eisenhower. Nella seconda si legge che le condizioni poste furono: «accettate […] dal Maresciallo Badoglio e da Eisenhower» (p. 15).
- ...
- L’autrice ricostruisce secondo i canoni del miglior giornalismo d’inchiesta le intricate vicende che caratterizzarono la caduta del fascismo a muovere dal 25 luglio, nonché i contatti, epistolari e non, intercorsi tra le parti in causa. L’indagine si sviluppa, inoltre, attorno alle tracce del cippo-ricordo dell’armistizio che gli Alleati posero nel luogo della sottoscrizione dell’“armistizio breve”, asportato nel 1955 da Enrico de Boccard. Vengono presentati e discussi i testi inediti di Franco Montanari, diplomatico che accompagnò il generale Castellano, con funzione di interprete durante le trattative, e i Diari inediti del diplomatico Luca Pietromarchi, sostituito in questo incarico inizialmente affidatogli, proprio da Montanari. Romanisio Amerio si intrattiene sul ruolo giocato nelle trattative da Dick Mallaby, agente segreto britannico e ricostruisce l’intricata avventura di Giacomo Zanussi che, per primo, ebbe la possibilità di visionare il testo dell’“armistizio lungo”. Si tratta di una ricostruzione puntuale e oggettiva degli eventi, carica, si badi, di un coinvolgimento empatico nella discussione degli stessi, motivata dal fatto che la studiosa essendo italiana ha contezza che l’armistizio, nel bene e nel male, segnò una cesura tragica della storia patria.
- ...
- Per tale ragione, il capitolo davvero dirimente del testo è l’ultimo, nel quale Ella si interroga sulle conseguenze dell’armistizio e sul suo senso profondo. Mentre gli Alleati, rileva, potevano contare su una complessa e articolata organizzazione nelle trattative, il fronte italiano non era unito e poteva contare su singole personalità, la principale delle quali era rappresentata, anche per i rapporti intrattenuti con la Casa Reale, da Badoglio. Nel discutere tale contesto storico, l’autrice si serve della più accreditata bibliografia storica, avvalendosi anche di notevoli fonti giornalistiche. La prima conseguenza dell’armistizio, è ben noto, fu l’esplodere della guerra civile che vide contrapposte le brigate partigiane e l’esercito della neonata RSI. Con la “fuga al Sud”, il Re e Badoglio scelsero definitivamente il fronte alleato. Questa scelta viene giustificata, dalla scrittrice, per l’impellenza, per gli italiani, che vivevano una situazione di evidente minorità politica e militare, di tentare di salvare il salvabile, innanzitutto bisognava ricostruire l’Italia. È bene precisare che Romanisio Amerio presenta tale lettura con il beneficio del dubbio.
- ...
- Chi scrive, di contro, fa propria, in merito all’armistizio dell’8 settembre, la tesi di Galli della Loggia: l’armistizio segnò la “fine della Patria”, cui fece seguito la colonizzazione politica e spirituale italiana da parte dell’Occidente. Negli anni Settanta, non è affatto casuale, che in Italia si registrasse una recrudescenza della guerra civile che sancì l’instaurasi, anche da noi, della post-modernità, del capitalismo computazionale, della dismisura che ammorba, ancora oggi, le nostre vite. Pertanto, il nostro giudizio sull’armistizio, è forse più negativo di quello espresso dall’autrice.
- ...
- Nonostante ciò, il libro che abbiamo sinteticamente presentato, fornisce al lettore molte informazioni e documenti sui quali vale la pena soffermarsi e riflettere. Essi chiariscono molti eventi di quel concitato frangente storico.
Rosanna Romnisio Amerio, Il Signor Armistizio non lo conosciamo, Solfanelli, pp. 363, euro 30,00.
- DAZI e MAZZI
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
-
- I
Mentre da gran parte della stampa si levano grida di dolore per i dazi all’Europa annunciati da Trump e sono calcolati i danni (le minori esportazioni) che ne conseguiranno alle economie europee, nessuno – che mi risulti – ha affiancato, come determinante del comportamento (e della decisione futura) di Trump, quanto vi concorrano presupposti, regole e regolarità della politica. Tra questi il problema del nemico, inteso nel senso del competitore ostile, prescindendo dallo stato di guerra e di pace. E’ chiaro che in un pluriverso politico tutti i soggetti si trovano in uno stato di ostilità, che può avere carattere agonale o polemico (Freund). Ma gli Stati sono collocati in una graduazione di ostilità, come ci dimostra la storia. Per la Francia generalmente il primo posto è di chi occupa la riva destra del Reno, cioè la Germania; Italia e Spagna, pur confinanti sono per lo più collocati a gradini inferiori della “scala”. Ovviamente, anche per evitare un confronto in posizione sfavorevole, occorre affrontare un nemico per volta e garantirsi che gli altri (potenziali) nemici conservino lo stato di neutralità, o meglio si comportino da alleati. Lo sapevano bene i Romani il cui divide et impera è la sintetica espressione di questa regola, che de Benoist considera la prima (e più importante) della lotta politica. Ossia la riduzione (del numero) dei nemici. In questa situazione Trump che ha trovato il modo di alzare il tono del conflitto con mezzo mondo, Cina in testa, difficilmente può non accordarsi con l’Europa. Anche perché – e qua si torna, almeno in parte, sull’economico – U.E. e U.S.A. hanno per lo più gli stessi problemi: delocalizzazione, dumping commerciale dei paesi emergenti, immigrazione fuori controllo. E avere gli stessi problemi non divide ma è un incentivo ad allearsi: nel secolo scorso UK, U.S.A. e U.R.S.S. divennero alleati perché avevano in comune gli stessi problemi; l’espansionismo tedesco e giapponese. Questo li indusse a superare le differenze di interessi ed ancor più quelle ideologiche.- ...
- Infine se a seguire una certa convinzione, onde a determinare, almeno parzialmente affinità e non affinità politiche (e campi di maggiore o minore affinità) è l’appartenenza alla stessa “civiltà” (Kultur) è palese che U.E. ed U.S.A. sono la filiazione politica del cristianesimo occidentale, col suo millenario bagaglio di idee, convenzioni e costumi, estesi ad ogni campo: dal religioso all’economico, dal giuridico alla scienza. Il che aiuta: ha ragione la Meloni quando parla di occidente: una cultura comune unisce assai più di quanto interessi – per lo più occasionali e limitati – possano dividere. A patto di non fare di questi ultimi il criterio (esclusivo) di scelta politica. Il che talvolta, succede.
- II
La notizia della “conclusione” della trattativa USA-Europa sui dazi ha – come era prevedibile – alzato i toni del confronto politico, così come della confusione che approcci ideologici e comunque settoriali comportano. Qualche settimana fa provavo a valutare i comportamenti degli attori nella trattativa sulla base di regole (e costanti) politiche, a lato di quelle più invocate, economiche, ed ora, anche se sullo sfondo, alle conseguenze sociali. Ci riprovo ad individuare gli idola taluni sfornati da tempo e ora aggiornati. Il primo è la cattiveria (e l’ignoranza) di Trump. Il quale, secondo i suoi detrattori, ha il vizio capitale: a) di agire per conseguire l’interesse (del popolo) americano, e b) di non applicare idee di qualche Balanzone di regime, colme di buone intenzioni e condite da zuccherosi appelli. A cui bisogna notare che da qualche secolo (o anche di più) si ritiene che il governante capace sia quello che realizza l’interesse della comunità, e non quello che predica bene e anche quando razzola altrettanto bene, non consegue il reale interesse comunitario (un tempo chiamato – o meglio sussunto –al bonum commune).- ...
- Al riguardo gran parte dei commentatori concorda sul fatto che l’accordo è più vantaggioso per gli U.S.A.. Non sono in condizione di giudicare, specie a lungo termine, né i benefici né le perdite. Sta di fatto che se Trump ha “messo nel sacco” la baronessa, bisogna ammettere che è stato bravo: se qualcuno sceglie un mediatore per trattare lo vuole fedele e capace, non uno sprovveduto remissivo. Di questo tipo di governanti ne abbiamo avuti tanti in Italia (e qualcuno anche in Europa): da chi vagheggiava di un’economia renana al “ce lo chiede l’Europa” per giustificare la loro arrendevolezza senza assumersene la responsabilità (si sa che servilità e viltà vanno quasi sempre a braccetto). Così che tacciare il Tycoon di aver messo l’Europa nel sacco conseguendo vantaggi per gli americanI è fargli un complimento.
- ...
- Terzo: non è che a indebolire l’Europa nel negoziato è stato proprio quello che il vicepresidente Vance aveva rimproverato ai governanti europei: di aver perso il consenso dei propri elettori? Come mi è capitato di sostenere, questo è uno dei fattori di potenza del governo: il sostegno non unico, ma principale che assicura la coerenza tra vertice e base, governanti e governati. Se l’avversario sa che è dubbio o carente, ne approfitta, nei frangenti estremi muovendo guerre, in altri facendolo pagare nelle trattative. Nella specie ha concorso con la frammentazione istituzionale dell’U.E., potenziandone gli inconvenienti.
- ...
- Quarto: sarebbe colpa dei sovranisti. Questo non si capisce proprio (se c’è qualcosa da capire in un’affermazione di propaganda di bassa categoria). Se è sovranista Trump e riporta tale successo, il fascino del sovranismo dovrebbe crescere. La tesi è comunque quanto mai debole per più ragioni. La prima è che a condurre la trattativa è stata la Von der Leyen, dato che la competenza (giuridica) appartiene alla Commissione U.E. (pare), il tutto tra gli strepiti dei centrosinistrati nazionali i quali l’hanno invocata quale migliore dei negoziatori possibili. Ma se la Von der Leyen ha il potere (di negoziare) ha pure la responsabilità del negoziato: il nesso tra potere e responsabilità è un nesso naturale (e quanto mai opportuno); cosa che i centrosinistrati carichi di battaglie perse e risultati negativi vedono come l’orco i bimbi. In secondo luogo, dato che il tutto costituisce, a prenderlo sul serio, un tradimento, occorrerebbe qualche prova del fatto o almeno indicare un qualche interesse a favorire l’arcinemico Trump. Ma delle prime non ce n’é, e del secondo, non si capisce quale vantaggio ricavi Orban o la Meloni dal favorire gli interessi americani, a scapito di quelli nazionali.
- ...
- A cercare una spiegazione più aderente alla realtà è che la debolezza istituzionale e politica dell’Unione si ripercuote sui rapporti internazionali, dazi americani compresi. Neppure usare la baronessa come capro espiatorio, addebitandole responsabilità maggiori di quelle – istituzionali - che le competono è condivisibile,. Se un’entità politica ha poco potere, di conseguenza ha poco diritto, come sosteneva Spinoza: tantum juris quantum potentiae. E chi la rappresenta ha mezzi modesti, non superiori ai risultati.
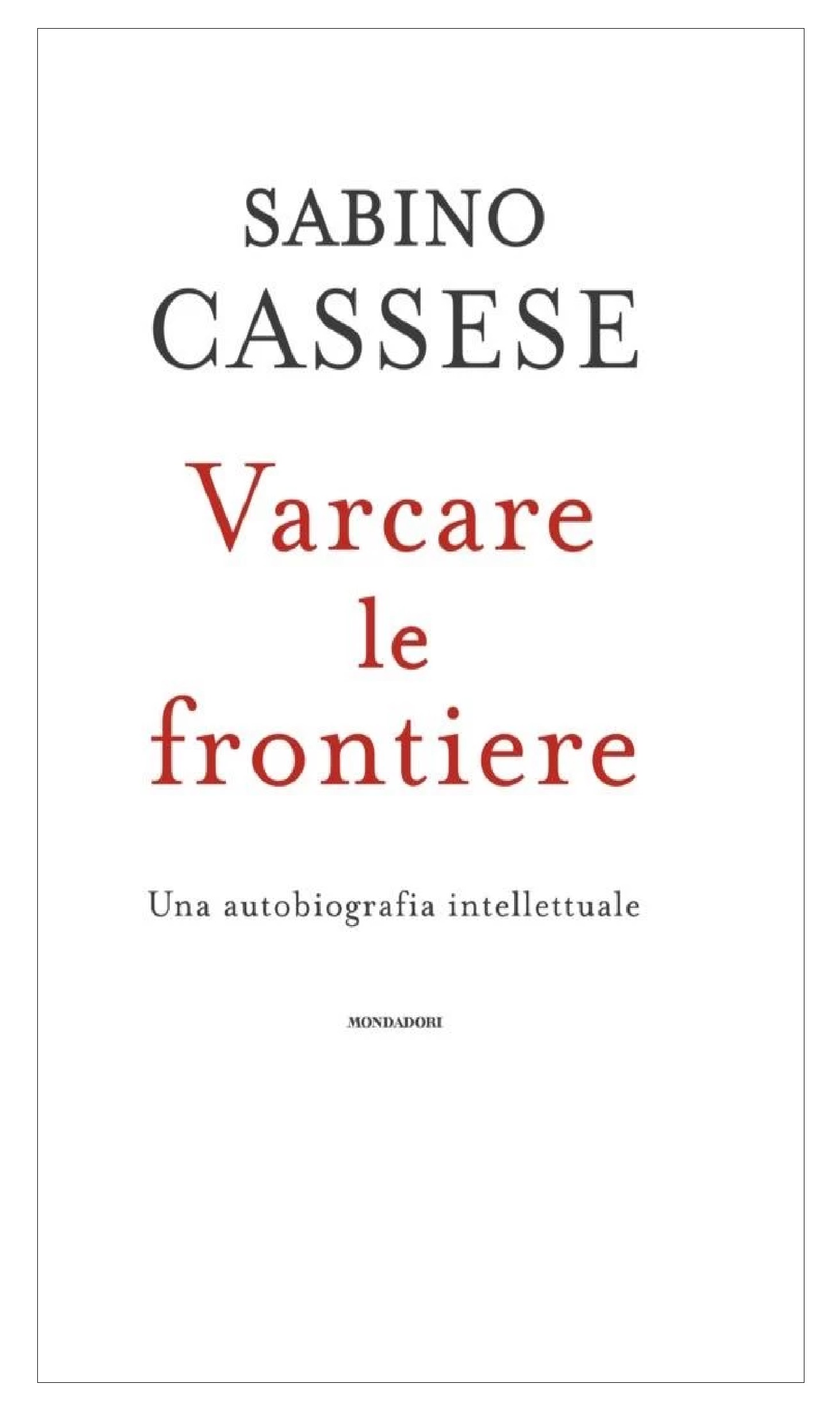
Sabino Cassese, - Varcare le frontiere.
- Una autobiografia intellettuale,
- (Mondadori 2025, pp. 280, € 20,00)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Quanto mai ben scelto il titolo di questa autobiografia intellettuale di Sabino Cassese. In primo luogo per l’opera svolta dall’autore e per la varietà delle esperienze e degli incarichi ricoperti: da quelli presso le università – italiane ed estere - agli impegni presso l’ENI e nel settore bancario; dall’attività di governo a quella di consulente di Ministeri ed enti pubblici; dell’incarico di Giudice della Corte costituzionale alla costante presenza nel dibattito pubblico. La poliedricità di tali attività compensa largamente quello che i suoi colleghi d’università in genere sono: insegnanti – studiosi, serrati nelle tane (d’avorio) della didattica, ovvero insegnanti - avvocati, legati alla realtà dell’applicazione del diritto, fino al punto di esserne spesso distratti dall’insegnare (ma almeno abituati al confronto quotidiano con il diritto concreto).
- ...
- Tuttavia le frontiere si possono varcare anche in altro modo e così Cassese relativamente allo studio del diritto ricorda che “Lo studio del diritto era, negli anni Cinquanta, diverso da oggi. Era ispirato ai principi del purismo (ricordo solo la teoria pura del diritto di Kelsen; ma i kelseniani sono stati molto peggiori di Kelsen stesso). La maggior parte dei manuali si apriva con numerose pagine dedicate a dimostrare l’autonomia di quella disciplina dalle altre, giuridiche e no”. Cassese si era convinto anche per l’insegnamento di M.S. Giannini che “Mi fu chiaro fin da allora, anche se non in maniera analitica, che vi sono problemi, non discipline; che è sbagliato parlare di un metodo esclusivamente giuridico come unico metodo del giurista; che il purismo comporta una separazione che non consente di esaminare l’ordinamento nella sua complessità; che il positivismo conduce all’omissione di tutti i dati che non consistono nella legge e nella norma”.
- ...
- Chiudendo le frontiere con la storia, la sociologia e la scienza politica, il normativismo perde di senso (e quindi di giustizia concreta) e di esatta applicazione quanto guadagna in purezza. Peraltro a valorizzazione la norma come elemento primario del diritto, corre il rischio, nelle decisioni amministrative o giudiziarie, di ridursi a fondarle su una norma piuttosto che sul diritto. Incorrendo così nell’errore, stigmatizzato da Celso quasi venti secoli fa: Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus. Praeposita, iudicare vel respondere.
- ...
- Inoltre allargare la prospettiva d’esame, invece di costruire mura, ha il vantaggio di garantire meglio una visione d’insieme. L’eccessiva specializzazione soffre l’inconveniente contrario: come scriveva Spengler, la prima assicura una visione da aquila, la seconda da ranocchia. Per cui, come sostiene Cassese “La famosa frase di Vittorio Emanuele Orlando secondo la quale i giuristi sono stati troppo filosofi, politici, storici e sociologi e troppo poco giureconsulti andrebbe oggi rovesciata. Lo sono stati troppo poco”. In ogni caso a sottovalutare il momento applicativo del diritto. Il quale si realizza, nello Stato moderno, con l’organizzazione di un’amministrazione burocratica che rende effettiva la tutela (anche) dei diritti, anche attraverso il monopolio della violenza legittima (Weber).
- ...
- Hegel aveva espresso in un paragrafo dei Lineamenti di filosofia del diritto, tale carattere dello Stato moderno “Lo Stato è la realtà della libertà concreta”. Dimenticarlo o sottovalutarlo significa farne l’immaginazione della libertà astratta (nel senso che quelle proclamate nella legge non sono le regole di fatto applicate).
- ...
- Sostiene l’autore, poiché “il diritto non è mai immobile va studiato quindi nel suo sviluppo storico”. Tale affermazione è del tutto condivisibile e va collegata a quanto Cassese scrive sul neo-positivismo kelsenisano e al giudizio che Maurice Hauriou dava di Kelsen (e di Duguit); che le loro concezioni del diritto erano statiche, mentre quella del doyen de Toulouse – fondata sull’istituzione – ne considerava il continuo movimento, di guisa che, in uno dei passi critici, la paragona all’agmen; a un’armata in marcia che cambia forma ma mantiene la struttura essenziale.
- ...
- Il libro si conclude con un appendice in cui l’autore enumera le proprie attività in oltre sessant’anni di lavoro: vastità e varietà sono impressionanti e corroborano il senso del titolo, le frontiere sono state varcate: da quelle tra disciplina, oggetti e “campi” trattati, tra diritti nazionali e “rami” del diritto. Ottima ragione per leggere il saggio; e per il recensore che deve chiudere con questa raccomandazione per non incorrere nelle censure del direttore alle recensioni lunghe.
-
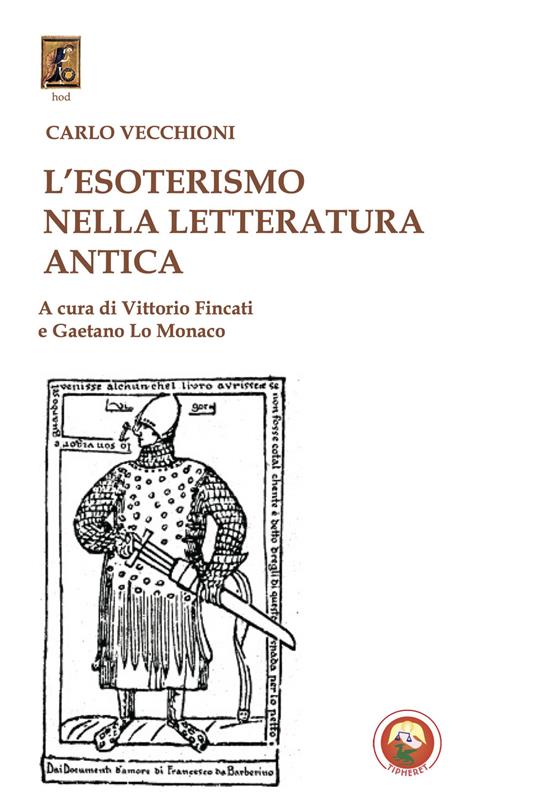
- "L’esoterismo nella letteratura antica"
- di
- Carlo Vecchioni
- rec. di
- Giovanni Sessa
È da poco tornato nelle librerie per Tipheret editore il volume di Carlo Vecchioni, L’esoterismo nella letteratura antica (per ordini: edizionitipheret@gmail.com pagg.171, Euro 20) Il testo è curato da Vittorio Fincati e Gaetano Lo Monaco, autori, rispettivamente, della contestualizzante Presentazione e dell’Introduzione.- ...
- Il libro, già uscito nel 2001, per la solerzia di Fincati, non è opera di un autore contemporaneo, ma di uno studioso che visse tra Settecento ed Ottocento. Carlo Vecchioni (1777-1858) fu vicepresidente della Suprema Corte di Giustizia di Napoli e Commendatore del Real Ordine di Francesco I di Borbone. Suo interesse prevalente fu lo studio delle origini del simbolismo di Dante e della Divina Commedia. L’opera del grande fiorentino, come si evince in tutta chiarezza nel volume che presentiamo, fu letta dal dotto partenopeo in chiave simbolica ed esoterica. Anzi, la sua esegesi può essere considerata tra le più rilevanti e fondative di tale corrente ermeneutica.
- ...
- Tra i primi a servirsi del lavoro del Vecchioni figura, lo ricorda Lo Monaco, Gabriele Rossetti, rosacroce e carbonaro di origini abruzzesi, che di lui scrisse: «Per dimostrare al chiarissimo autore (Vecchioni) ch’io lo considero come a me associato nella ricerca della verità, io riporterò le sue citazioni e le sue parole a preferenza […] non è solamente stima, ma anche gratitudine quella che mi impegna ad operar in tal guisa» (p. 11). A dire del Rossetti, il Vecchioni non avrebbe portato a termine il suo lavoro ma, in qualche modo e per ragioni ignote, si sarebbe fermato alle premesse, rintracciando, nelle pagine che presentiamo, i presupposti e i precedenti sapienziali cui Dante guardò nel comporre il Poema. Il volume, infatti, è articolato in molti capitoli, nei quali l’autore si intrattiene sulla “prisca sapienza” presente nella letteratura dell’antico Egitto, nei testi greci, nei Misteri d’Eleusi. Le sue interpretazioni discutono i nessi sussistenti tra linguaggio e simbolo negli Oracoli, nella favole, sottolineando la stretta connessione che univa in uno, almeno allora, poesia e filo-sofia. Rintraccia, in particolare i “nascosti sensi” presenti in Omero e gli “ascosi sensi” di Virgilio. Il libro è scritto in un italiano ottocentesco, solo la prosa dei primi due capitoli è stata adeguata al lettore contemporaneo, modernizzata. La sua prosa è comunque godibilissima. Da quanto detto, si comprende che Vecchioni si colloca tra i dantisti che si sono sottratti alla vulgata corrente, sia essa accademica o meno.
- ...
- Anticipa o si pone in sequela, lo nota Lo Monaco, di un numero considerevole di interpreti danteschi tra i quali, in modalità diversa, possono essere annoverati Boccaccio, Foscolo, Pascoli ma anche Caetani, Kremmerz, Lebano, Perez, Valli e Reghini. Non casualmente, Boccaccio fa dire a Dante: «son, Minerva oscura […] E ‘l nobil mio volume feci degno di temporal e spiritual lettura» (p. 13). Il dotto veneziano Gaspare Gozzi scrisse, alla metà del Settecento: «che la Commedia poteva essere compresa soltanto attraverso l’interpretazione allegorica […] Beatrice era la personificazione della Scienza divina» (p. 14). È noto che nell’Ottocento l’esegesi misteriosofica di Dante trovò il proprio momento saliente. Ne fu ispiratore il lucano Francesco Lomonaco. Ugo Foscolo parlò del sommo Poeta, quale riformatore religioso. Scopo di Foscolo era: «quello di dimostrare che nella mente di Dante la favola era santificata per un sistema occulto insieme e perpetuo e concatenato» (p. 15). Il massone Reghellini sostenne Dante essere affiliato a società segrete attive nel suo tempo. Rossetti fu ancor più preciso: il “sapere riposto” di Dante avrebbe guardato a quanto avevano statuito, a riguardo, Greci e Romani. Virgilio avrebbe condotto Dante alla scoperta di tale Via realizzativa.
- ...
- Più tardi, Giuliano Kremmerz scrisse, giustamente piccato: «...e Dante che ha scritto il più completo rituale d’iniziazione magica […] doveva essere ammirato sette secoli più tardi per l’adulterio di Francesca o la fame di Ugolino» (p. 17). Lo stesso Arturo Reghini, in tema, chiosa: «Il soggetto della Commedia è l’uomo, o meglio la rigenerazione dell’uomo, la sua metamorfosi in angelica farfalla, la Psiche di Apuleio» (p. 19). Lo stesso Pascoli vide nel Poema un’opera “misteriosofica”, ricca di simbolismi arcani, nel quale ruolo centrale è svolto dalla “morte mistica”. Per Perez, inoltre, Beatrice avrebbe rappresentato la “Sapienza degli Eletti”, l’intelligenza attiva che unendosi all’intelletto possibile, trasforma chi se ne faccia latore. Valli, è risaputo, ritenne che Dante appartenesse ai “Fedeli d’Amore”.
- ...
- Il libro di Vecchioni concede al lettore gli strumenti esegetici per entrare nelle vive cose di tali letture esoteriche. Forse tali interpretazioni possono parere a taluno unilaterali, da integrarsi con letture diverse. Resta il fatto che esse presentano, comunque, una loro dignità ermeneutica che non consente di guardare altrove con ritrosia, come se nulla fosse stato detto in tema.
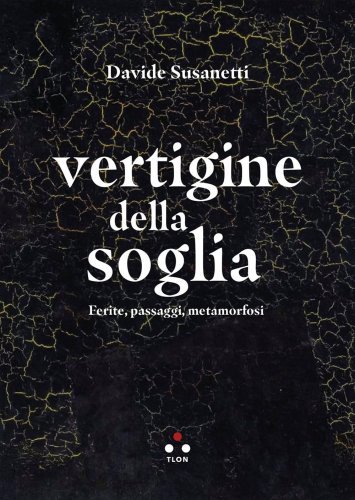
V ERTIGINE DELLA SOGLIA- Le “stazioni” del risveglio di
- Davide Susanetti
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Un libro rigenerante
- Ci siamo confrontati con diversi volumi della vasta produzione libraria del grecista Davide Susanetti. Usciamo rigenerati dalla lettura della sua ultima fatica, Vertigine della soglia. Ferite, passaggi, metamorfosi, nelle librerie per i tipi di Tlon Edizioni (pp. 133, euro 14,00). Queste pagine trasmettono l’intensità e la profondità dell’iter speculativo dell’autore che, si badi, non è centrato solo su vasta erudizione, su una non comune conoscenza del patrimonio mitico universale, ma ha tatto di sapere realizzato, vissuto nelle vive carni. Vertigine della soglia attraversa, in modalità allusiva e simbolica, ventidue “stazioni”, nelle quali si dipana, come attestato dai ventidue Arcani maggiori dei Tarocchi, qualsivoglia cammino iniziatico e mistico.
- ...
- Le sue pagine testimoniano il percorso di vita di Susanetti e invitano a porsi sul medesimo sentiero. L’autore avvisa il lettore: il cammino realizzativo richiede la capacità di accettare lacerazione e dolore ma, nonostante ciò, la meta cui invia è il sempre possibile, che mai si immaginava di poter conseguire. Iniziazione, dal latino inire: «è quel movimento che conduce a varcare un confine. A compiere un passaggio. È ingresso in un dominio o in una sfera altri da quel che stava fuori […] Un altro che rende liberi» (p. 9).
- ...
- Uno e molti. Verso la soglia
- Per comprenderlo è necessario muovere dall’inizio testimoniato dalle antiche storie, vale a dire da Phanes, lo “Splendente”, il “Manifesto”, che principiò a dispiegarsi quale presenza molteplice. Zeus inghiottì Phanes con tutto ciò che era apparso e: «da capo, riportò alla luce tutto ciò che aveva assorbito» (p. 11). Il padre degli dèi dopo aver ripetuto il passaggio dall’uno ai molti, generò Dioniso quale suo successore. I miti dionisiaci attestano che tale potestas divina era dio “nato due volte” (secondo altri racconti, nato “tre volte”). Questi accolse i doni dei Titani che lo sbranarono mentre si guardava riflesso nello specchio. Zeus fulminò i Titani e di essi rimase: «un cumulo di cenere […] e residui di bianco di cui si erano cosparsi. Dal depositarsi di quella materia fu plasmato il genere umano» (p. 14). Nella realtà, da quel momento, Dioniso appare, di volta in volta, presente e assente. Quando pare celarsi o scomparire, il suo ritorno rende la vita perpetua primavera: in essa gli uomini recuperano l’amicizia con tutti gli enti della physis. Egli è il dio che “scioglie”, che fa venir meno ogni forma e, per questo, è avvertito, all’inizio, come “straniero”, estraneo alla dimensione della vita civile, per il suo mettere in questione ogni identità e confine. Per approssimarsi alla soglia bisogna accettare la lacerazione dionisiaca, mettere in discussione appartenenze e ruoli “umani, troppo umani”. L’uomo deve comprendere di essere lacerto inconsapevole del divino: «La verità del passaggio è forse il nostro stesso passare attraverso la ripetizione» (p. 17) della lacerazione perpetratasi all’origine.
- ...
- Memoria e Via Sacra
- I Misteri greci mostrano che, nel momento del passaggio dalla vita alla morte, è necessario abbeverarsi alle acque del lago della Memoria (alla seconda sorgente che si incontra nel mondo delle ombre, non alla prima, che prepara l’anima a una nuova nascita mortale) per imboccare la Via Sacra: «dove […] i posseduti di Dioniso procedono in gloria di esistenza divina» (p. 20). Pitagora e, più recentemente, Gurdjieff, consigliavano all’iniziando di rammemorare ogni particolare vissuto in una data giornata, al fine di: «evadere dal tempo, per sottrarsi a quello scorrere indefinito che si traduce in labilità ed assenza» (p. 22). Memoria non è potenza che conserva: al contrario, come seppe Andrea Emo, coincide con oblio, con la dimenticanza di tutto ciò che è riferibile all’Io. La maggior parte degli uomini, sostenne Eraclito, vive nella condizione dei dormienti, come in un sogno che: «ciascuno prende come misura della realtà» (p. 25). Chi voglia avvicinarsi alla soglia deve, al contrario, cogliere il “comune” e vedere: «come gli opposti che discordano siano connessi […] dalla più bella armonia» (p. 27), ponendosi oltre le attestazioni della conoscenza logocentrica. Tutto è pùr, gli enti sono la momentanea solidificazione di un principio che li anima ed è sempre all’opera.
- ...
- Maritare il mondo. Il gioco del mondo
- Allo scopo, la psiche deve chiudersi al tempo edipico della pólis e ogni uomo, come Socrate, deve farsi átopos, “senza collocazione”, allo stesso modo in cui l’ “attimo immenso”, nel quale soglia e passaggio si mostrano, è altro rispetto al fluire cronologico degli istanti. Solo nel kairos, per quest’uomo “senza luogo”, balugina la lucentezza dell’origine. Il mondo, quale lacerto dell’origine, va, come disse Pico della Mirandola, “maritato”. Ogni suo frammento è tessera, simbolo rinviante alla pienezza indivisa dell’“ora prima”. Aión è un bambino che gioca, sapiente è l’uomo che vive in sintonia con tale dimensione ludica. Il “gioco del mondo” dice in uno anima e corpo: «“Anima” è ciò che scopriamo nel “corpo” e del “corpo” quando non diamo per scontata la vita che ci abita e che di solito ignoriamo» (p. 47), la vita divina. Anima è termine medio che attraversa e unisce gli opposti e simpateticamente invia, quale copula mundi, all’Uno-Tutto. La bellezza dei corpi è segnavia che agevola il percorso di dis-velamento del misterium vitae. Il bello sospinge, anagogicamente, verso: «il regno degli archetipi che sono al contempo pure forme e pure energie da cui la realtà sensibile è plasmata» (p. 55). L’immaginazione consente, precisa Susanetti, di portarsi oltre la mera descrittiva del mondo fenomenico, verso l’oltre che si apre di là della soglia e consente all’uomo: «di trasformarsi e di […] riguadagnare una dimensione di sé che era sopita e dimenticata» (p. 61). È la via indicata, tra gli altri, da Novalis nell’Enrico di Ofterdingen che conduce all’onirico e immaginale “fiore azzurro”: «Occorre prestar fede all’incanto del fiore […] fiore e viandante sono il medesimo» (p. 72).
- ...
- Il filo-sofo Eroe
- Lo seppe Bruno-Atteone in, De gli eroici furori. Il filo-sofo è eroe che rinunciando a se stesso, facendo il vuoto in sé, si protende nella caccia al mistero dell’essere. Vedere Diana nuda: «significa convertirsi in ciò che ella vede e in ciò che ella è» (p. 83). Pico della Mirandola, ricorda Susanetti, sostenne l’uomo esser simile al camaleonte, atto ad assumere colori e natura diversi, a seconda del contesto in cui agisce. Gli fece eco Nietzsche, che definì l’uomo “un ponte”. L’oltre cui guardano mistica e iniziazione, precisa l’autore, sono altro dalle tendenze trans-umaniste di tanta cultura contemporanea, in quanto l’umano che tecnologia e digitale mirano a estinguere: «costituisce solo uno dei piani possibili della realtà» (p. 92). L’oltre, di cui si dice in queste pagine, sostenuto dalle potenze dell’analogia e del simbolo, eccede la ragione calcolante, è: «trapasso all’invisibile e all’impalpabile che non appartiene alla tre dimensioni» del reale della scienza moderna (pp. 92-93). Esso conduce a una: «Identità che non toglie la differenza e a una differenza che diversamente abbraccia l’identità» (p. 94). In prossimità della soglia si deve compiere il “salto”. L’“ora” cui si perviene, è l’“ora” del mito e della favola, nella quale si dissolvono le tentazioni proprie di progetti apprensivi e nella quale, forse, si palesa la possibilità di una comunità diversa dall’attuale, in cui il filo-sofo, stante la lezione di Plotino, è sempre felice in quanto ha contezza della natura non entificabile del principio e vive nella e della libertà-origine, altra dai simulacri di libertà che infestano il presente.
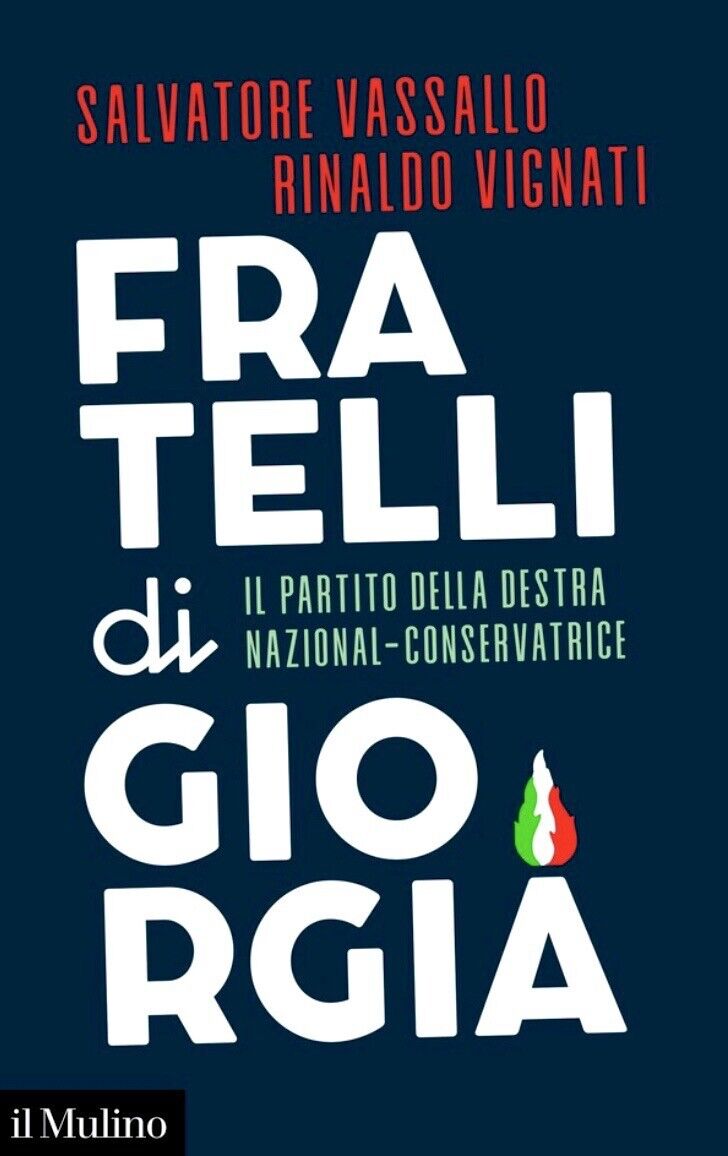
Salvatore Vassallo e Rinaldo Vignati
- "Fratelli di Giorgia"
- (Il Mulino, Bologna 2023, pp. 291, € 18,00)
- rec. di
- TEODORO KLITSCHE DE LA GRANGE
- Il saggio di Vassallo e Vignati a partire dagli albori della Repubblica analizza l’evoluzione della destra: dal MSI, passando per AN ed arrivare all’oggi, ossia a Fratelli d’Italia. Il tutto realizzato sia attraverso l’analisi di programmi, flussi elettorali, dichiarazioni dei leaders che mediante informazioni raccolte da vari esponenti.
- ...
- Gli autori distinguono tre fasi, caratterizzate da diverse classi dirigenti. La prima, quella del MSI, dove la classe dirigente del partito era formato da ex appartenenti al PNF e, in particolare da reduci della RSI: cioè un insieme fortemente connotato, distinto dai partiti ciellenisti, ostracizzato e, anche per questo consolidato nella continuità con i valori del fascismo, sia del regime che della fase terminale. Nella seconda, di AN, la classe dirigente è nella totalità o quasi costituita da persone che, per motivi anagrafici – essendo quasi tutti nati dopo il 1945 – col fascismo non avevano avuto rapporti come Fini, Gasparri, La Russa, Alemanno; altri che al massimo erano stati balilla (come Matteoli e Tatarella).
- ...
- Quanto a FdI i "fratelli di Giorgia" erano diventati militanti del MSI all’inizio degli anni Novanta, durante la crisi della Prima Repubblica, e avevano fatto pratica della politica come professione dopo la svolta di Fiuggi in epoca bipolare. Sono loro (la terza generazione della Fiamma) a costituire l’ossatura organizzativa di FdI”. Pur nella continuità con la propria storia “oggi nel codice di condotta di FdI sono esclusi i saluti romani, i pellegrinaggi collettivi a Predappio o l’uso del termine «camerata»”. Soprattutto non c’è in vista alcun pericolo di deriva autoritaria e gli esami e le accuse di fascismo alla Meloni sono del tutto infondati “L’attribuzione a FdI di quella categoria (o di suoi derivati) si fonda sull’uso di definizioni metastoriche, soggettive e concettualmente dilatate del «fascismo»”.
- ...
- Per cui, scrivono gli autori “...a chi si domanda «quanto fascismo c’è oggi in FdI?» suggeriamo di distinguere tra fascisti, neofascisti, postfascisti e afascisti. La prima generazione di fondatori del MSI era formata da fascisti (da persone che avevano avuto un ruolo, piccolo o grande, nel regime, e soprattutto nella sua ultima incarnazione, la RSI) e da neofascisti”. Con la svolta di AN si “compie il passaggio dal neofascismo (via via ridotto, a partire dagli anni ottanta, a puro nostalgismo testimoniale) al postfascismo: afferma cioè la piena integrazione nel sistema democratico”. Con FdI “...la generazione di Giorgia Meloni è piuttosto definibile come formata da democratici afascisti: il processo di integrazione democratico è proseguito e il fascismo ha smesso completamente di esercitare una funzione di ispirazione. È stato ormai definitivamente relegato a momento storico di un passato irripetibile, che ha poco o niente da offrire per orientare l’azione politica, che così viene percepito anche dall’elettorato a cui oggi FdI si rivolge”.
- ...
- Quanto alla democrazia interna, FdI lascia (molto) a desiderare “In pratica l’intera intelaiatura organizzativa è posta nelle mani del presidente e dell’Esecutivo nazionale, dei Presidenti dei Coordinamenti regionali e provinciali”. Per cui “Il sostanziale dissolvimento delle strutture territoriali e degli organi assembleari del partito si accompagna a una direzione fortemente centralizzata nelle mani del leader”.
- ...
- Per l’appartenenza ideologica, FdI è stata classificata come “destra estrema”, come populista, ma appare meglio riconducibile ad un partito nazionale conservatore “Giorgia Meloni e i suoi Fratelli, hanno appreso che il patriottismo nazionalista e il conservatorismo, già di fatto elementi chiave del loro bagaglio ideologico, potevano diventare un appropriato/utile «marchio». L’etichetta di conservatore consente di dare un nome alla destra all’interno del campo più largo del centrodestra italiano, conferendole una identità distintiva rispetto alle altre componenti”. Oltretutto il meglio “spendibile” in Europa.
- ...
- Il saggio è accurato e non partigiano: due caratteri per consigliarne la lettura. Quello che manca, anche se in un paragrafo gli autori valutano l’incidenza della fortuna e della virtù (le “categorie” machiavelliche) nella valutazione del rapido e travolgente successo di FdI è quanto vi abbia concorso la decadenza sia della società che del sistema politico italiano. Se l’Italia è stata il primo paese dell’Europa occidentale ad avere un governo totalmente anti-establishment (il Conte 1), le levatrici di tale successo, proseguito in quello di FdI sono la peggiore crescita economica dell’Europa, ossia quella italiana e l’incapacità della classe dirigente a garantirla (così come le altre crisi). Un buon favore della Fortuna al governo Meloni.
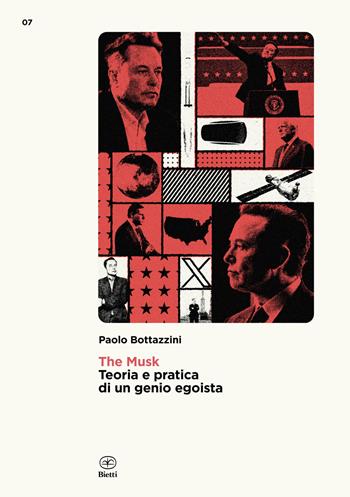
Teoria e pratica di un genio egoista- Un saggio di Paolo Bottazzini dedicato a
- Elon Musk
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Elon Musk è il personaggio del momento. Se ne parla ovunque, di continuo, non sempre in modo pertinente. L’interesse per la sua figura è stato accentuato, dapprima, dalla sua vicinanza politica a Trump, mentre, ultimamente, si è tornati a riflettere sul suo ruolo per la presa di distanze dalla presidenza USA. Usciamo dalla lettura di un libro critico e interessante dedicato al magnate americano. Si tratta del saggio di Paolo Bottazzini, The Musk. Teoria e pratica di un genio egoista, comparso nel catalogo di Bietti. Il volume è articolato in tre capitoli. Nel primo, l’autore, docente incaricato presso l’Università degli Studi di Milano e pubblicista, presenta i tratti costitutivi della psiche di Musk soffermandosi, in particolare, sulla sua formazione, sulle idee attraverso le quali si è costituito il suo immaginario. Il secondo e il terzo capitolo, al contrario, indagano, in modalità organica, successi e insuccessi di questo originale genio dell’impresa. In queste brevi note discuteremo i plessi più rilevanti del primo capitolo, in quanto consentono al lettore di aver contezza della visione del mondo di questo protagonista della storia contemporanea.
- ...
- Il narrato di Bottazzini è sostenuto, da un lato, da ampia documentazione e da una non comune conoscenza delle fonti, come nelle corde della migliore saggistica, dall’altro, da una prosa affabulatoria e coinvolgente che agevola la lettura. Il ritratto di Musk è, in sintesi, quello di un eroe post-moderno che fa di scienza e tecnica gli strumenti salvifici cui l’umanità deve guardare per tutelarsi da un possibile e probabile disastro epocale. Paradossalmente, il tratto post-moderno del magnate statunitense è sostanziato da una visione solida dell’impresa, rinviante al capitalismo delle origini e, per nulla, a quella smart dell’attuale fase computazionale e globalizzante. Componenti significative del mondo della comunicazione e ampie fasce sociali sono state attratte da alcune componenti della personalità di Musk. Hanno esercitato una presa rilevante sulle masse: «Le dimensioni spettacolari dei suoi guadagni, la tendenza alla provocazione attraverso dichiarazioni lapidarie su X.com (ex Twitter) […] l’eccentricità da nerd o da autistico nei rapporti con il prossimo, il progetto di colonizzare Marte […] la prolificità da record» (p. 13). Musk ha, più volte, dichiarato di aver trovato un modello archetipico di riferimento in Samvise Gamgee, personaggio del Signore degli Anelli, in quanto questi scopre nel mondo un senso (“C’è del buono in questo mondo”), per il quale è necessario battersi.
- ..
- Questa scelta lo ha indotto a un’azione ottimistica e determinata, sintonica alla “follia” dei primi capitalisti, che operarono in una realtà ostile alle loro idee. Con Carlyle, egli è convinto che la riflessione teoretica non è atta a dirimere qualsivoglia dubbio cognitivo: solo l’azione volitiva dell’eroe può dare ordine alla realtà: «Il lavoro […] è il metodo attraverso cui si vince la mancanza di senso del reale e si conquista un significato che innerva di sé […] lo spazio sociale comune» (p. 15). Tale modello attivo rinvia alla filosofia individualista di Ayn Rand, per la quale: «l’egoismo si riduce al diritto civile di proprietà privata, e al diritto naturale di esercitare una libertà di impresa che non deve fermarsi davanti a nulla» (p. 18). Musk, quindi, è latore del capitalismo della dismisura. Laureato in fisica, ben presto ha sposato il primato dell’ingegneria, fondando tale scelta sulla prospettiva fantascientifica di Asimov e di Douglas Adams. Non è casuale che un personaggio di Asimov, Hari Seldon sia: «in grado di divinare l’imminenza del tracollo dell’umanità» (p. 25). L’eroe Musk si ritiene investito dal compito di salvare l’umanità. Nell’attuale contingenza storica si correrebbe, infatti, il rischio di perdere l’:«enciclopedia dei saperi in cui si distilla la coscienza della nostra civiltà» (p. 25). La sua prolificità (quattordici figli!), quanto l’idea di colonizzare Marte, sono conseguenze del terrore provato da Musk di fronte all’apprensione per la continuità dell’umanità nel futuro.
- ...
- Pensare il futuro è compito da lui affidato alla setta dell’“Altruismo Efficace”, retta dal suo delfino, William MacAskill. Questi ha elaborato le idee di lungotermismo e di rischio esistenziale.
- ...
- Con il primo concetto si indica la necessità di pensare anche ai “venienti”, alle generazioni future e al loro benessere e, per far si che ciò si realizzi, è necessario evitare i rischi esistenziali, quali epidemie, catastrofe nucleare, cambiamento climatico. In particolare, Musk e i suoi sono convinti che sia indispensabile tenere sotto controllo le fasi recessive che investono la storia, al fine di evitare drammi sociali come quelli provocati dalla crisi del 2008. Spesso, si badi, le intraprese di questi gruppi, hanno prodotto effetti deleteri, come mostra il caso della speculazione cripto-valutaria perpetrata da Sam Bankmann-Fried, vicino all’“Altruismo Efficace”. La previsionalità statistica domina la visione del mondo muskiana. Tale tendenza lo ha indotto a una visione distorta dei rischi impliciti nel potenziamento dell’Intelligenza Artificiale, centrata, di fatto, sull’articolo di fede delle proprietà emergenti che si mostrerebbero quando si raggiungono determinate soglie di potenza di calcolo. Allo stato attuale delle cose, tutto ciò non è prevedibile. Si tratta di un errore di prospettiva dettato dal fatto che, per Musk, la cura della situazione attuale dovrebbe nascere all’interno dello stesso orizzonte di pensiero che ha indotto la condizione presente: il paradigma logico-operativo del capitalismo liberista che si dà nel Ge-Stell, nell’Impianto della tecno-scienza.
- ...
- In sostanza, la proposta di Musk è un nuovo storicismo escatologico neo-gnostico mosso dalla volontà di emendare il mondo e la vita, nel nome di uno stato finale della storia. Sua intenzione reale è quella di preservare lo stato attuale delle cose, la governance, prevenendo i rischi che il sistema vigente corre.
- ...
- Musk, lo si è visto, è attento lettore di fantasy e fantascienza, ma la sua esegesi di questi generi letterari è parziale. Disconosce che la vita e la storia sono il regno del possibile che tende, di continuo, agguati alla previsionalità statistica e deterministica. Il libro di Bottazzini può essere, in questo senso, strumento indispensabile per quanti vogliano tornare a guardare con occhi critici alla nostra attualità e ai suoi miti.
Paolo Bottazzini, The Musk. Teoria e pratica di un genio egoista, Bietti, Milano 2025, pp. 181, euro 16,00.
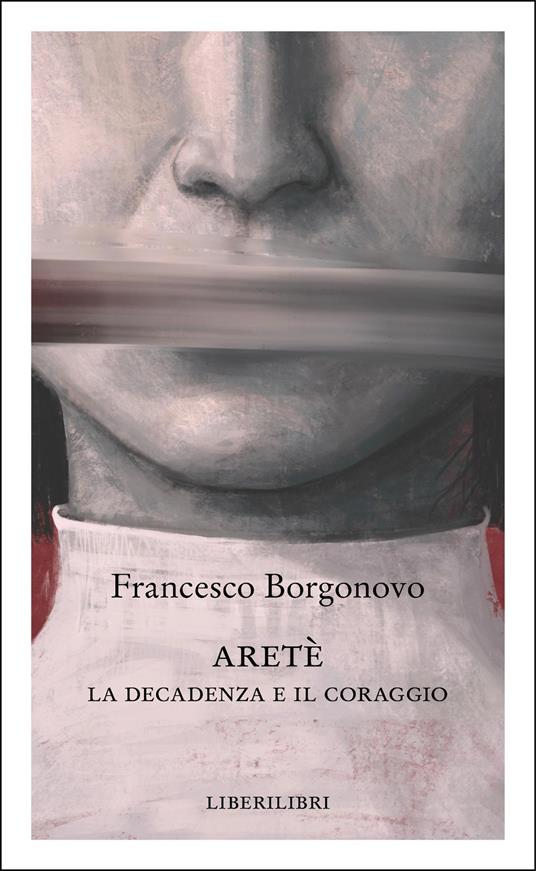
Aretè. - La decadenza e il coraggio
- di
- Francesco Borgonovo
- (Liberilibri 2025, pp. 271, € 18,00)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- I pensatori che hanno scritto della decadenza (di civiltà, Stati, élite, comunità) hanno per lo più osservato che in tali epoche prevalgono – soprattutto a livello di classi dirigenti – idee compassionevoli e lacrimose: ad essere esaltate sono le vittime e non gli eroi. Basti leggere (per tutti) quanto scrivono Pareto e Schmitt. Nel saggio di Borgonovo ciò che connota la decadenza attuale è qualcosa di sinergico ma non coincidente con un “buonismo” o un umanitarismo sfinito ed immaginario: l’accidia.
- ...
- Questa, scrive l’autore è “Peccato capitale per i cristiani, l’accidia viene spesso assimilata alla pigrizia ma non è esattamente la stessa cosa. In greco indica la mancanza di kedos, che è il pentimento, il compatimento ma anche la cura. Accidia è, dunque, l’essere incapaci di passione, noncuranti, indifferenti. E sì, anche pigri. Ma pure (e soprattutto) sconfortati, apatici, depressi... e, da quando abbiamo voluto far crollare il Cielo questo demone è più potente e il suo nome è legione: panico, ansia, angoscia, depressione, decadenza, rassegnazione, sottomissione, paura, conformismo, omologazione, vigliaccheria… La piattezza ci ha esasperato e fatto disperare, e ci ha fatto perdere la voglia di vivere e di combattere. La banalità a partita doppia ha ucciso i nobili sentimenti che hanno fatto grande la nostra civiltà: se non v’è più nulla di superiore, resta l’inferno”.
- ...
- L’accidia deriva dall’assenza dell’aretè (greca, assai vicina alla virtus romana) che abbonda, di converso, nelle fasi ascendenti delle comunità umane. Questa è “prima di tutto, la capacità di svolgere bene il proprio compito, di eseguire questo compito con perizia… In Omero aretè è «la forza e la destrezza del guerriero o del competitore, soprattutto il valore eroico...»”. Nel medioevo è intesa “come dono di sé prima di tutto. Il prode non si tira indietro, il cavaliere è generoso e non bada troppo al proprio tornaconto”. La potenza del denaro, tipica dell’età di decadenza (v. Hauriou) è una “potenza basata sulla forza dell’invidia e dell’avarizia umane, nient’altro. Così le nazioni diventano naturalmente ogni giorno più invidiose e avare. Mentre gli individui fluiscono via in una codardia che chiamano amore. La chiamano amore e pace, e carità, e benevolenza, mentre si tratta di mera codardia. Collettivamente sono orribilmente avari ed invidiosi” scrive l’autore citando Lawrence.
- ...
- Anche se emergono nella decadenza attuale, idee e pulsioni liberticide è l’assenza di coraggio che la caratterizza “La consapevolezza della decadenza, la forza di accettarla e il coraggio di osteggiarla. Un coraggio che è larghezza di cuore, disposizione del dono di sé, amore gratuito e insieme predisposizione alla battaglia. La libertà ci manca perché ci difetta il coraggio di guadagnarla. Il coraggio di accettare le sfumature del pensiero, le opinioni contrarie, la pluralità conflittuale del mondo. Il coraggio di guardare in faccia il reale e di cambiarlo sul serio, senza costruirgli attorno padiglioni artificiali”.
- ...
- Non si può non condividere con Borgonovo che è il coraggio ciò che più caratterizza sia le comunità in ascesa, ma più ancora le loro classi dirigenti. Ed è il coraggio, la capacità di sacrificarsi per gli altri ed assumerne i rischi che costituisce l’essenza dell’etica pubblica, del governante e del cittadino, come già nel Gorgia sosteneva Callicle. Il che pone tuttavia l’interrogativo fondato sull’opinione di don Abbondio: che se uno il coraggio non ce l’ha non se lo può dare. E l’alternativa consiste nel chiedersi se la decadenza dipende dalla pusillanimità o se questa dalla decadenza. Tuttavia è sicuro che coraggio, consapevolezza, accettazione del rischio ne costituiscono la terapia o, quanto meno il Katechon paolino.
- ...
- Borgonovo ricorda i tanti pensatori (a partire da Lawrence) i quali hanno avvertito la tara accidiosa della modernità decadente, Non è possibile ricordarli tutti e si rimanda quindi alla lettura del saggio. Ma qualche considerazione del recensore. La prima che la virtù (stretta parente dell’aretè) sia considerata essenziale alla coazione comunitaria (ed al successo) e così nota già Platone ed è il contraltare machiavellico della fortuna. Il virtuoso è quello che prepara gli accorgimenti adatti a contrastarla, e non chi si piange addosso o attende il soccorso degli altri. La seconda: tra coloro che hanno considerato essenziale all’ordine il coraggio della lotta e l’inutilità del vittimismo ci sono parecchi esimi giuristi: da Jhering a Forsthoff, da Calamandrei ad Hauriou. Alcuni, come Santi Romano hanno insistito sulla vitalità degli ordinamenti (propiziata dal coraggio e dall’assunzione dei rischi)- Tra questi il più vicino alla tesi di Borgonovo è proprio Hauriou, il quale tra i caratteri ricorrenti delle fasi di crisi indica l’affievolirsi dello spirito religioso e il progredire (a dismisura) di quello critico nonché la capacità dissolutoria del denaro (ossia di un’economia prevalentemente finanziaria); oltre alla perdita del senso del limite. Tutte cose che troverete – tra l’altro –, mutatis mutandis, in questo interessante saggio.
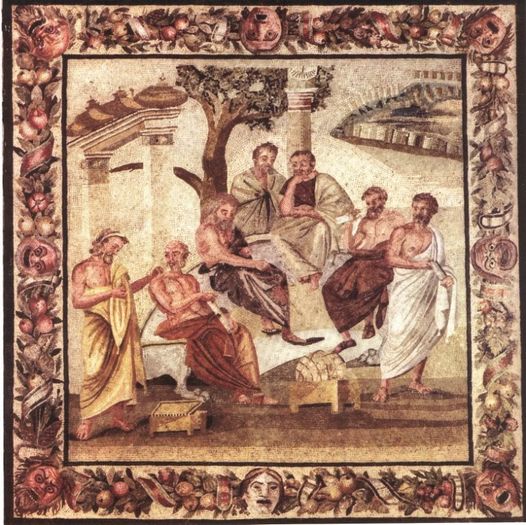
DAZI e MAZZI - di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Mentre da gran parte della stampa si levano grida di dolore per i dazi all’Europa annunciati da Trump e sono calcolati i danni (le minori esportazioni) che ne conseguiranno alle economie europee, nessuno – che mi risulti – ha affiancato, come determinante del comportamento (e della decisione futura) di Trump, quanto vi concorrano presupposti, regole e regolarità della politica.
- ...
- Tra questi il problema del nemico, inteso nel senso del competitore ostile, prescindendo dallo stato di guerra e di pace. E’ chiaro che in un pluriverso politico tutti i soggetti si trovano in uno stato di ostilità, che può avere carattere agonale o polemico (Freund). Ma gli Stati sono collocati in una graduazione di ostilità, come ci dimostra la storia. Per la Francia generalmente il primo posto è di chi occupa la riva destra del Reno, cioè la Germania; Italia e Spagna, pur confinanti sono per lo più collocati a gradini inferiori della “scala”.
- ...
- Ovviamente, anche per evitare un confronto in posizione sfavorevole, occorre affrontare un nemico per volta e garantirsi che gli altri (potenziali) nemici conservino lo stato di neutralità, o meglio si comportino da alleati. Lo sapevano bene i Romani il cui divide et impera è la sintetica espressione di questa regola, che de Benoist considera la prima (e più importante) della lotta politica. Ossia la riduzione (del numero) dei nemici. In questa situazione Trump che ha trovato il modo di alzare il tono del conflitto con mezzo mondo, Cina in testa, difficilmente può non accordarsi con l’Europa. Anche perché – e qua si torna, almeno in parte, sull’economico – U.E. e U.S.A. hanno per lo più gli stessi problemi: delocalizzazione, dumping commerciale dei paesi emergenti, immigrazione fuori controllo. E avere gli stessi problemi non divide ma è un incentivo ad allearsi: nel secolo scorso UK, U.S.A. e U.R.S.S. divennero alleati perché avevano in comune gli stessi problemi; l’espansionismo tedesco e giapponese. Questo li indusse a superare le differenze di interessi ed ancor più quelle ideologiche.
- ...
- Infine se a seguire una certa convinzione, onde a determinare, almeno parzialmente affinità e non affinità politiche (e campi di maggiore o minore affinità) è l’appartenenza alla stessa “civiltà” (Kultur) è palese che U.E. ed U.S.A. sono la filiazione politica del cristianesimo occidentale, col suo millenario bagaglio di idee, convenzioni e costumi, estesi ad ogni campo: dal religioso all’economico, dal giuridico alla scienza. Il che aiuta: ha ragione la Meloni quando parla di occidente: una cultura comune unisce assai più di quanto interessi – per lo più occasionali e limitati – possano dividere.
- ...
- A patto di non fare di questi ultimi il criterio (esclusivo) di scelta politica. Il che talvolta, succede.
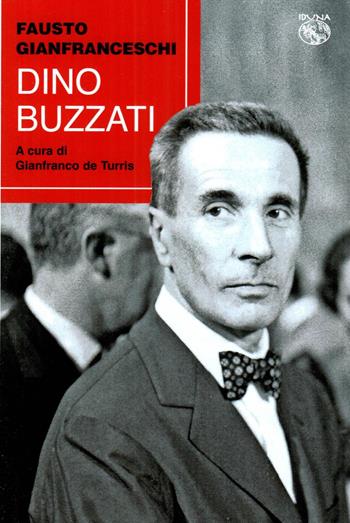
"Dino Buzzati"- Torna nelle librerie la monografia di
- Fausto Gianfranceschi
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Dino Buzzati è uno dei nomi più significativi della letteratura italiana del Novecento. Eppure, la sua figura ha rappresentato, per troppo tempo, un “caso a parte” nelle lettere patrie. Alieno alle mode culturali del tempo in cui visse, discreto per carattere e dotato di un temperamento sognate, fu estraneo al “politicamente corretto” che, fin dagli anni dell’immediato dopoguerra, andava organizzandosi in consorterie intellettuali legate al gran carro della partitocrazia. A rivelarne la genialità scrittoria, si distinse, tra i primi, Fausto Gianfranceschi, intellettuale libero dai condizionamenti del mainstream, in una monografia, comparsa da poco in nuova edizione nel catalogo di Iduna con il titolo, Dino Buzzati (per ordini: associazione.iduna@gmail.com). Il volume, curato da Gianfranco de Turris, uno dei massimi studiosi del fantasy, è articolato in due parti di cinque capitoli, ed è chiuso dalla raccolta di tre introduzioni di Gianfranceschi a volumi di Buzzati e da una Appendice che presenta un’intervista rilasciata dallo scrittore bellunese, poco prima della morte, al curatore e dall’intenso “coccodrillo” che de Turris scrisse in occasione della scomparsa del giornalista-scrittore.
- ...
- Dalla lettura si esce con la ferma convinzione che l’autore del Deserto dei Tartari sia uno scrittore di spessore, assolutamente attuale, nella sua inattualità, anche oggi. La prosa di Gianfranceschi risulta efficace nel concedere al lettore, non solo accesso proficuo alla biografia esteriore del bellunese, ma anche ai meandri più nascosti della sua complessa psiche. Nella prima parte, il volume si intrattiene sul personaggio Buzzati e presenta un’esegesi organica della sua produzione letteraria. Buzzati, nato a Belluno: «ha tratto due eredità da questa origine: il rigore nordico […] e l’unica passione immutabile della sua vita, quella per la montagna. Sciatore, rocciatore, non ha mai abbandonato questi sport» (p. 17). Attratto dai silenzi alpini e boschivi amò, di un amore profondo, Milano (dove lavorò al Corriere della sera, ricoprendo incarichi disparati): «ne conosce gli angoli segreti e tranquilli, mentre le voci della metropoli lo mantengono in contatto con il dinamismo collettivo» (p. 17). Buzzati, in ogni luogo e circostanza della vita si mantenne in: «attesa del meraviglioso quale inclinazione dell’animo ad accogliere manifestazioni insolite della natura e della realtà umana» (p. 18). Seppe, per questo, elevare l’attività di cronista ad una osservazione attenta dei casi umani, mirata non semplicemente a cogliere i dati esteriori in quanto osservato, ma anche la profondità da essi celata, attestante, in molti casi, la possibilità dell’impossibile: «Il lato favoloso, l’essenza mitica di ogni fenomeno» (p. 18).
- ...
- Per questo, i temi e le strutture (analizzati nella seconda parte del volume) che animano la produzione letteraria buzzatiana sono: «tragici e significativi» (p. 21). La creatività, nel nostro autore, è dominata dalla fantasia, la sua vocazione alla frammentarietà: «dipende dall’urgenza di questa fantasia sempre in moto e sempre avida di macinare una situazione» (p. 22). Lo si evince fin dal primo libro del 1933, Bàrnabo delle montagne, così diverso dalle letteratura del tempo, forse prossimo solo al “realismo magico” di Bontempelli. Le sue pagine evidenziano il lavoro di scandaglio della realtà messo in atto dallo scrittore, teso a dis-velare: «l’irrazionale sotto le strutture apparentemente razionali della vita moderna» (p.24). Buzzati conduce ad ascoltare risonanze vaghe proprie di alcuni particolari del reale che, ai più, appaiono insignificanti. In Bàrnabo, l’elemento magico-favoloso è insinuato in modalità lieve, pudica, mentre erompe prepotentemente nel Segreto del Bosco Vecchio, nel quale la natura recupera appieno la sua animazione principiale. Nella physis tutto pensa, come seppe la tradizione ermetica, in quanto “tutto è in tutto”. La vocazione della letteratura buzzatiana, per Gianfranceschi, è essenzialmente “religiosa”. L’apprensione moderna alla natura è impersonata, nel Segreto, dall’aridità del Colonnello, incapace di cogliere l’invisibile nei fenomeni.
- ...
- Solo con Deserto dei Tartari, lo scrittore conseguì vasta notorietà. L’attesa di Drogo testimonia che l’eterno coincide con l’attimo immenso, rivelatore dell’essenza profonda della vita. Buzzati ci pone di fronte a una meditazione della morte che, a ben vedere, è meditazione attorno alla temporalità aperta. Drogo è: «l’eroe coinvolto in un’irriducibile tensione: assorbito dalla routine […] attratto dall’altra nella cerchia dei pochissimi che guardano più in alto verso il “grande evento”, verso l’illuminazione» (p. 47). Con, Sessanta racconti, tale visione consegue tratto compiuto: «il mondo dei morti si sovrappone a quello dei vivi […] nelle delicate favole L’assalto al grande coniglio e Il Mantello» (p. 50). Lo scrittore indica la via che rende possibile liberarsi dall’inganno “retorico”, avrebbe chiosato Michelstaedter, del tempo. Per sfuggire alle sue maglie non bastono i progetti spensierati imbastiti, per tutti, dalla “società dei consumi”. Essi, al massimo, possono indurre, visto il loro inevitabile fallimento, ad insediare gli uomini nel nostos, nella nostalgia. Il bellunese è animato da “carità” nei confronti delle cose della vita. Tale atteggiamento lo rende edotto del fatto che il “risveglio" è possibile. La vita stessa è appesa alla dimensione originaria della possibilità. I protagonisti dei racconti buzzatiani sconfiggono le perfidie e le delusioni della vita. L’amore, forza cosmica, rende il miracolo possibile. Il suo magismo letterario mira a rilevare: «le trasmutazioni fra paesaggio, cose, eventi, immagini ed emozioni » (p. 151).
- ...
- Per tale ragione, il presunto kafkismo di Buzzati: «si risolve nel rinvio a modelli ispiratori dislocati in un passato molto profondo» (p. 162), a modelli archetipici e mitici, e il suo mondo può esprimersi solo in modalità immaginale. La visione del Nostro ha un precedente illustre nella pittura di Bosch, nella sua figuratività (non casualmente lo scrittore è stato anche valente pittore) che ha: «tratti insieme umani, bestiali ed è ripresa dal mondo degli oggetti dove si nota la profusione di realismo e il pervadente desiderio di esprimere l’immateriale» (p. 149). Il Buzzati di Gianfranceschi va letto quale antidoto alla visione moderna della vita. Dino Buzzati è libro, per dirla con de Turris, esemplare. Induce a pensare un mondo diverso rispetto a quello in cui viviamo, in quanto è latore della possibilità dell’impossibile.
- Fausto Gianfranceschi, Dino Buzzati, a cura di G. de Turris, Iduna, Sesto S. Giovanni (Mi) 2025, pp. 233, euro 20,00.
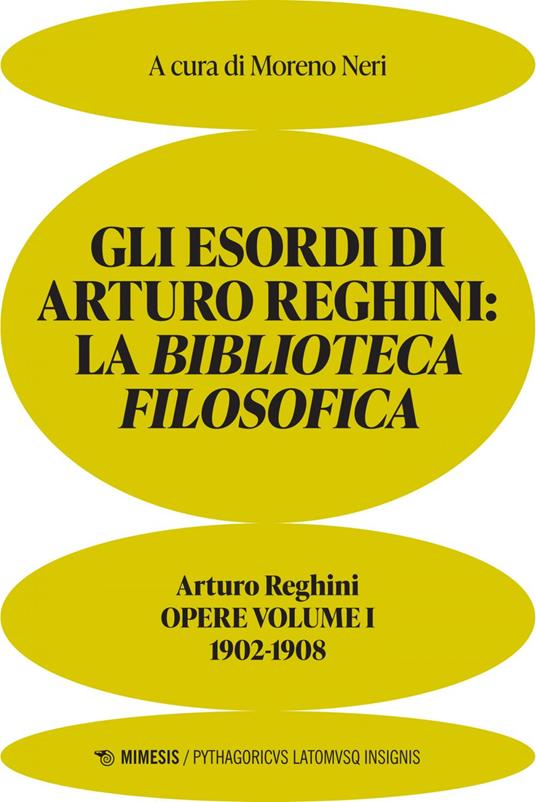
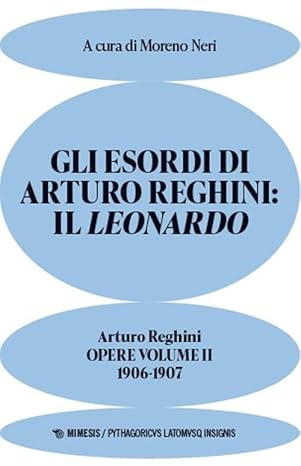
I primi due volumi dell’OPERA OMNIA di - Arturo Reghini
- La Biblioteca Filosofica (1902-1908) e Il Leonardo (1906-1907)
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Arturo Reghini è autore di grande interesse. Nato a Firenze nel 1878 da una stirpe di antico lignaggio, poliglotta che vantava una conoscenza rilevante di molte lingue antiche e moderne, fu animato da: «larghe curiosità in campi non convenzionali del sapere e da una non comune erudizione» (p. 17). Negli ultimi anni c’è stata una recrudescenza di interesse per il suo pensiero anche se, ad oggi, le ristampe delle sue opere, non hanno avuto il tratto “scientifico” e sistematico che solo può consentire al lettore di entrare nelle vive cose della sua proposta speculativa e realizzativa. Finalmente, grazie alla meritoria iniziativa della casa editrice Mimesis, e all’opera di impeccabile curatela di Moreno Neri e di un gruppo di studiosi che lo affiancano, sono nelle librerie i primi due volumi della sua Opera omnia. Si tratta de, Gli esordi di Arturo Reghini: la Biblioteca Filosofica (1902-1908) e di, Gli esordi di Arturo Reghini: Il Leonardo (1906-1907). L’opera completa dell’esoterista, che presto verrà data alle stampe nella sua interezza, non mira, sic et simpliciter, a riproporre in ordine cronologico gli scritti già noti, ma propone al lettore anche testi comparsi in riviste di difficile reperimento, alcuni dei quali ignoti perfino agli studiosi più accreditati del neo-pitagorico.
- ...
- I due volumi appena pubblicati raccolgono le prove letterarie degli esordi di Reghini che, a differenza di altri esegeti reghiniani, Neri considera dirimenti per comprendere le posizioni mature del matematico-massone. Per tale ragione, l’attento curatore ricostruisce con acribia critica, l’ambiente, animato da vivaci stimoli intellettuali e spirituali, nel quale questi primi scritti maturarono, vale a dire il milieu della Firenze “scapigliata” di inizio secolo, incarnata da Papini e Prezzolini, e quello, altrettanto significativo, gravitante attorno alla Biblioteca Teosofica, poi divenuta Filosofica, che fu diretta proprio dal nobile fiorentino. Reghini fu intellettuale che attraversò da uomo libero l’esperienza teosofica, si avvicinò al Martinismo, per giungere, infine, a un originale neo-pitagorismo massonico. Una delle sue iniziali prove letterarie è da individuarsi nella prima traduzione italiana del romanzo di Stevenson, Lo strano caso del dott. Jekyll e del Signor Hyde, apparso a puntate sulla rivista, La Nuova Parola, nel 1902-1903.
- ...
- Altro lavoro di una certa rilevanza, pubblicato nel primo volume dell’opera omnia, è la relazione tenuta dallo studioso al Congresso della Federazione delle Sezioni Europee della Società Teosofica nel 1904. Si tratta di uno studio matematico (Reghini si laureò a Pisa in tale disciplina) applicato alla fisiologia dell’occhio. Dagli elenchi della Società Teosofica, Reghini risulta iscritto a essa, a muovere dal 1902, in quel di Torino. Il 1 agosto dello stesso anno, egli pubblicò su La Stampa un articolo dedicato agli: «insoliti eventi luminosi di Berbenno» (p. 19). Su La Nuova Parola comparve un ulteriore testo del Nostro: «dedicato all’ultimo libro di Herbert Spencer» (p. 19).
- ...
- Gli ambienti teosofici frequentati da Reghini ebbero, ricorda Neri, rapporti significativi con la “massoneria di frangia”, tanto che il Nostro fu iniziato alla Loggia “I Rigeneratori” di Rito A. e P. di Memphis e Mizraim di Palermo, della quale faceva parte Sulli-Rao, fondatore della Libreria Editrice Ars Regia di Milano. In tali ambienti, Reghini legò con Eduardo Frosini, “il polimorfo esoterico”, con il quale chiuse i rapporti a partire del 1914, per poi intrattenere con lui una burrascosa polemica, dopo l’ascesa al potere del fascismo. Rientrato a Firenze nel 1903, Reghini aderì alla Loggia “Michele di Lando”, ricostituitasi successivamente come Loggia “Lucifero”, aderente al Rito Simbolico. A tale opzione latomica, Reghini rimarrà fedele per il resto della vita. Neri, nell’informata introduzione, rileva, in particolare, come la “Lucifero”: «fosse in procinto di diventare anche il luogo degli spiriti più progressisti e riformisti» (p. 36), tanto che molti massoni eletti a Firenze nel Consiglio comunale con la lista nathaniana nel 1907 erano appartenenti a questa Loggia. A differenza del semplice “radicalismo” democratico di questi ultimi, Frosini e Reghini criticavano gli ambienti massonici dell’epoca, perché avevano, di fatto, obliato l‘impegno esoterico-iniziatico. Al loro fianco si posero alcuni collaboratori del Leonardo. Frosini assunse la risoluzione di uscire dalla “Lucifero”, in quanto riteneva si fosse trasformata in un sodalizio “puramente politico”: «Uscimmo, non per dormire, ma per svegliare» (p. 45) scrisse. Le sue furono speranze deluse.
- ...
- Nel medesimo frangente Reghini, attraverso la direzione della Biblioteca Filosofica e con la collaborazione al Leonardo, inaugurata dal significativo articolo, Giordano Bruno smentisce Rastignac, si pose quale epicentro di un appassionato dibattito intellettuale e spirituale, mirato a individuare l’esistenza di una tradizione iniziatica italica. Con la rivista e la biblioteca: «promosse una vera rivoluzione […] che perseguiva l’affermazione di valori dell’interiorità contro quelli dell’esteriorità» (pp. 64-65), facendosi latore di un personalismo pagano radicale. Fu, tra l’altro, autore del saggio, Imperialismo pagano che divenne, in seguito, il titolo di un libro di Julius Evola. Il Reghini degli anni degli esordi fu vicino a Roberto Assagioli, padre della psicosintesi. Questi, da studioso critico della psicanalisi, era convinto che: «“al di fuori della coscienza” non esistono solo “tendenze di natura inferiore”, ma esistono anche regioni superiori in cui “sono accumulate preziose energie […] mirabili possibilità di più alta vita spirituale”» (p. 111). Per questa ragione, in Appendice al secondo volume dell’opera omnia, compaiono: «i primi scritti di Assagioli […] per far meglio comprendere obiettivamente e in chiave temporale le affinità tra entrambi e le dinamiche di quel che si muoveva in quel tempo» (p. 81). I due autori condizionarono l’ultima serie, “magico-occultistica”, del Leonardo, dalla quale, ben presto, Papini e Prezzolini presero le distanze. Il primo, dopo l’infatuazione futurista, si convertì al cattolicesimo, il secondo guardò con sempre maggior interesse al neo-idealismo.
- ...
- L’introduzione di Neri ricostruisce, in modo compiuto, i tratti del pensiero degli esordi di Reghini contestualizzandolo storicamente, e si intrattiene, inoltre, sui personaggi con cui l’esoterista entrò in relazione, tra gli altri, Giovanni Amendola, Rocco Amedeo Armentano, Decio Calvari. Presenta il tratto umano, oltre che intellettuale, dei protagonisti della vita culturale di quella lontana stagione. Scrive, in fondo, per la ricchezza e varietà delle documentazione presentata e discussa, una vera enciclopedia dell’esoterismo, del teosofismo e della massoneria italiana del primo decennio del “secolo breve”.
- Arturo Reghini, Gli esordi di A. Reghini: La Biblioteca Filosofica 1902-1908, a cura di M. Neri, Mimesis, pp. 216, euro 18,00. Id., Gli esordi di A. Reghini: Il Leonardo 1906-1907, a cura di M. Neri, Mimesis, pp. 212, euro 18,00.
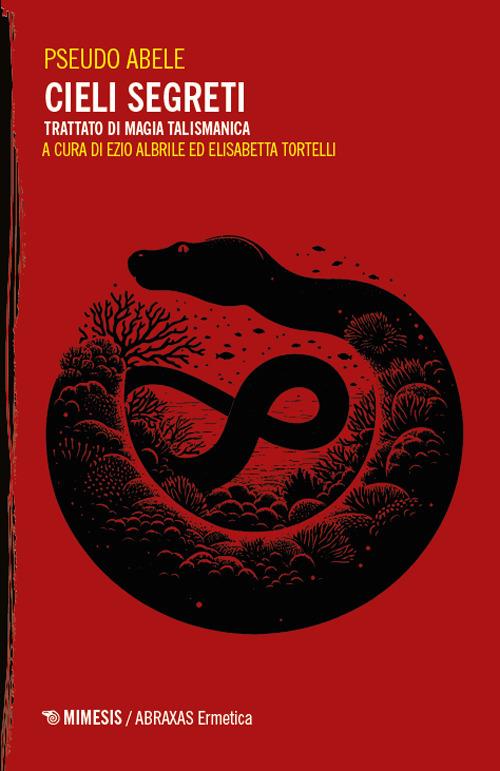
"Cieli segreti"- Trattato di magia talismanica
- rec.di
- Giovanni Sessa
- È nelle librerie per i tipi di Mimesis, un libro che contribuisce a fare chiarezza su uno degli snodi più significativi della cultura della Rinascenza, vale a dire sulla ripresa in essa di contenuti magico-esoterici. Ci riferiamo al volume attribuito a Pseudo Abele intitolato, Cieli segreti. Trattato di magia talismanica (per ordini: 02/24861657, mimesis@mimesisedizioni.it, pp. 165, euro 15,00). Il libro è curato da Ezio Albrile, antropologo e storico delle religioni, e da Elisabetta Tortelli, docente di Letteratura italiana e dottore di ricerca in civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento, cui si deve la traduzione del testo dal latino all’italiano e la contestualizzante e organica introduzione. Il manoscritto è custodito in un Codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze contenente ventitré testi magici e astromagici sabei. Risale al sec. XV, ma la traduzione dall’arabo al latino avvenne tra il 1140 e il 1270. La traduzione latina che Tortelli ha trasposto in italiano, con il titolo Cieli segreti, è quella del Liber Planetarum ex scientia Abel, articolato in sette trattati, nella versione di Roberto di Chester.
- ...
- Tortelli scrive: «Il comune denominatore che ispira i testi astrologici e astromagici […] è l’incrollabile convinzione che la vita di ogni elemento dell’universo dipenda dal moto e dall’influsso degli astri» (p. 21). Ciò lo si evince anche dal testo che presentiamo, articolato in sette libri secondo la successione Luna-Sole-Mercurio-Venere-Marte-Giove-Saturno, cui vanno aggiunti il liber Lunae e il Liber Solis L’importanza del Liber planetarum è rilevabile fin dal prologo. In esso è contenuta, in sintesi, la leggenda che narra come, in vista del diluvio, Abele figlio di Adamo, trascrisse i principi della scienza magico-talismanica, rivelatagli dal padre, su lapidi marmoree. Dopo aver soddisfatto tale compito, decise di seppellire le lapidi perché, di tale sapere, potessero benificiare i posteri. Dopo il diluvio, le lapidi furono rintracciate da Ermete Trismegisto che: «avrebbe deciso di divulgare questa antichissima sapienza, trascrivendo i testi […] nei sette libri» (p. 37). In realtà, la figura di Abele rinvia al primo Ermete della genealogia dei tre Ermete, tesi fatta propria da Roberto di Chester. Il Liber planetarum è: «uno dei più interessanti scritti del corpus ermetico di origine arabo-latina che si diffuse in Occidente tra il XII e il XIII secolo» (p. 37). Gli insegnamenti contenuti nel libro di Abele-Ermete riguardano prevalentemente la scientia ymaginum, la scienza dei talismani.
- ...
- Tale sapere è strettamente connesso con le “elezioni”, con il momento astrologicamente più opportuno, individuato dal mago-sapiente, per realizzare i talismani stessi, affinché questi potessero svolgere un’azione significativa sulla vita di chi li possedeva e li indossava. I talismani, di diversa fattura e tipologia, sono oggetti manipolati o indossati dal possessore: «per costituire un polo d’attrazione delle forze astrali e hanno un’azione diversa dagli amuleti» (p. 38), in quanto questi sono dotati di un potere occulto di tipo naturale. I talismani, al contrario, derivavano la propria potestas dalla sagace azione del mago che: «valutava il momento della costellazione dominante, considerando l’aspetto che la Luna e il Sole o gli altri pianeti intrattenevano tra loro e con i dodici segni dello zodiaco» (p. 39). Il mago svolgeva, quindi, funzione di medium, posizione teorica tipicamente neoplatonica, in quanto atto a congiungere microcosmo e macrocosmo, alto e basso, cielo e terra, imbrigliando le potenze planetarie nella pietra talismanica. La sua efficacia: «scaturisce dall’incantesimo […] ossia dalle formule proferite dal mago che comanda agli spiriti (astrali) di insinuarsi» in esso (p. 39). Questo ritorno a una visione simpatetica della physis, ricorda Tortelli, fu avversato da Giovanni di Salisbury, esponente della Scuola di Chartres e, in modalità più radicale, da Tommaso d’Aquino. I due pensatori videro nella trattatistica astromagica del periodo, il rischio dell’evocazione demonologica: si trattava, a loro dire, di un ritorno all’antico, che l’ortodossia cattolica non poteva accettare.
- ...
- Tale cultura esoterico-astrologica era, di fatto, centrata su un celebre testo magico-ermetico, il Picatrix, che offriva precise indicazioni sulla realizzazione dei talismani implicanti: «l’incisione di determinate immagini su specifiche pietre in determinati periodi» (p. 43). La sua influenza è evidente nel De vita di Marsilio Ficino, mitigata, come del resto in Pico della Mirandola, dal riferimento alla Grazia divina, vera artefice degli influssi. Tale scelta avrebbe salvato i due filosofi dall’accusa di riproporre una visione “pagana” del mondo. In ogni caso, la visione astromagica e simpatetica del cosmo, circolava ampiamente nell’Italia del Quattrocento e durante il Rinascimento, influenzando l’iconografia del periodo. Tortelli, al riguardo, rinvia all’esegesi della Sala dei Mesi del Palazzo Schifanoia: «“I grandi talismani murali di Schifanoia conservano l’inquietante fascino tramandato […] dal manuale di magia Picatrix, ma diventano, al contempo, oggetti di contemplazione”» (p. 47). Medesima visione si mostra nella creazione della volta celeste nella scarsella della Sacrestia Vecchia della chiesa di San Lorenzo a Firenze: «pittura murale, concepita forse come un gigantesco e potente talismano» (p. 22). Non dissimile è la rappresentazione pittorica della scarsella della cappella dei Pazzi nella Chiesa di Santa Croce, realizzata, come la prima, per celebrare, il 6 luglio 1439, il Concilio di Firenze indetto per riunificare chiesa d’Oriente e d’Occidente. In tutto questo ebbe ruolo di primo piano Toscanelli, cartografo, geografo e astrologo di grande rinomanza. In Firenze, in sequela con il diffondersi di tali saperi, dei quali i Medici si servirono anche per ragioni politiche, si diffuse il culto dei Re Magi.
- ...
- Consigliamo vivamente, la lettura di, Cieli segreti: le sue pagine chiariscono la complessità e la crucialità della cultura della Rinascenza. In quella congerie storica fu messo in atto il tentativo di dar vita a un Nuovo inizio della storia europea. Il neoplatonismo fiorito a Careggi, impregnato di esoterismo e magismo, fu una filosofia epistrofica mirante a recuperare l’origine che dice, in uno, la meraviglia della vita e il suo tratto tragico.
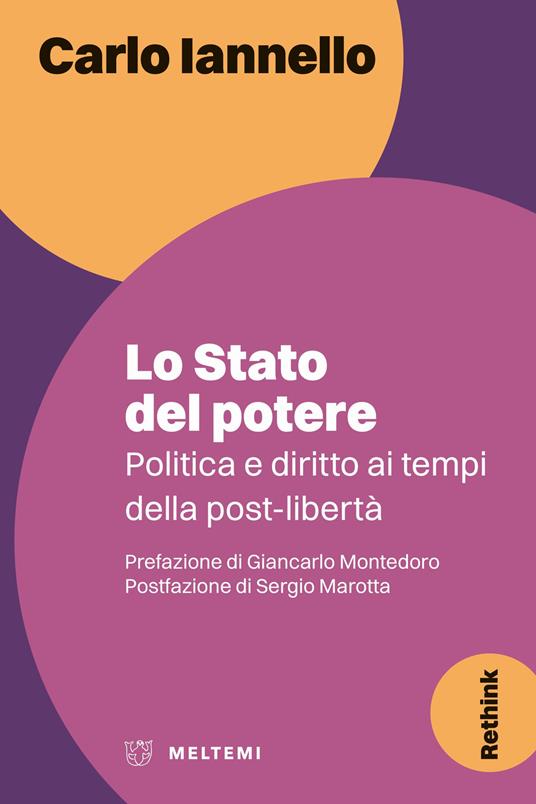
Lo Stato del potere- Politica e diritto ai tempi della post-libertà
- di
- Carlo Iannello
- (Meltemi 2025, pp. 267, € 18,00)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Tanti sono i saggi pubblicati negli ultimi anni che valutano la situazione politica generale e, in particolare, la contrapposizione tra globalisti e sovranisti (con i primi in evidente ritirata). Pochi quelli che ne analizzano gli effetti sul diritto pubblico e nelle istituzioni; tra questi ultimi, il saggio recensito.
- ...
- Scrive Iannello: “Questo libro riguarda le politiche, comunemente definite neoliberali, che hanno provocato un’espansione del tutto inedita dell’area del mercato nell’Occidente capitalista a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, producendo cambiamenti radicali non solo in campo economico e sociale, ma anche nei sistemi costituzionali degli Stati occidentali... Il diritto è stato, infatti, il principale strumento che ha consentito la messa in atto delle nuove politiche. Tuttavia, le riflessioni, di carattere prevalentemente settoriale, non hanno abbracciato, da una prospettiva ampia, e in particolar modo costituzionale, l’influenza che queste nuove politiche hanno dispiegato sul complessivo sistema dei poteri pubblici... Il diritto espressione del paradigma neoliberale ha messo in discussione, al tempo stesso, gli architravi su cui si reggeva l’edificio dello stato liberal-democratico e quelli su cui poggiava il costituzionalismo del Novecento… Tutto ciò ha avuto ripercussioni, al tempo stesso, sul godimento delle libertà e sul governo della società e dell’economia, provocando effetti all’interno dello Stato e oltre lo Stato” (il corsivo è mio).
- ...
- Ne è derivata, secondo l’autore, una neutralizzazione della dimensione politica. Il costituzionalismo dello Stato liberal-democratico ha conosciuto varie fasi: nella prima (fino all’inizio del XX secolo) la funzione dello Stato era di garantire lo spazio delle libertà individuali “classiche”; in una seconda fase, iniziata circa un secolo fa, ha tutelato anche le libertà “sociali”, tipiche del Welfare State. Con la fase neo-liberale, iniziata negli ultimi decenni del secolo passato, la funzione dello Stato è divenuta quella di garantire l’ordine di mercato, anche all’interno di settori e procedimenti pubblici. Sostiene Iannello “per il neoliberalismo, invece, il mercato non rappresenta affatto un ordine spontaneo ma è, al contrario, una costruzione artificiale del diritto. Il mercato da promuovere è quello concorrenziale. Al potere pubblico viene, pertanto, affidato il compito di creare l’ordine giuridico del mercato concorrenziale”. Per fare ciò è necessario l’intervento del potere statale, la cui funzione principale è divenuta così quella di garantire la concorrenza. Il tutto attraverso diverse soluzioni.
- ...
- Da un canto con la “creazione di ircocervi istituzionali, cioè di nuove autorità, indipendenti dal potere politico, denominate garanti del mercato, di natura giuridica ibrida (per metà amministrazione e metà giudice) e di dubbia compatibilità con i principi costituzionali”; ma dato che non bastava “Il paradigma del mercato concorrenziale, sperimentato con successo in questi settori un tempo riservati alla mano pubblica, è stato quindi esteso ben al di là degli ambiti tradizionalmente considerati economici, coinvolgendo il cuore dello Stato sociale”. Così “Le università, ad esempio, sono sottoposte a valutazione e i loro finanziamenti hanno una quota premiale, che si conquista nella misura in cui si sia vinto un gioco competitivo le cui regole sono fissate in sede legislativa”. Il tutto senza considerare “la sostanziale differenza fra un controllo di qualità di un prodotto industriale (che ha parametri oggettivi su cui fondarsi) e quello di un’opera dell’ingegno (la quale) non è stata presa in considerazione… Il controllo di qualità, pertanto, ha come parametro privilegiato dati quantitativi o formali, cioè il numero dei prodotti pubblicati o il rating delle riviste su cui si è pubblicato. Ciò che nel mondo accademico si risolve, peraltro, in un evidente incentivo al conformismo”. E Dio solo sa se di tale conformismo, già abbondante di suo, ce ne fosse bisogno. Così per altri settori onde “conclusivamente, si deve osservare che in questo scenario di nichilismo giuridico, in cui le costituzioni hanno perso la loro forza prescrittiva e il diritto è disancorato dal suo nomos originario (nel nostro caso, i valori etico-sociali della Costituzione), non ci pone più il problema della giustizia del diritto positivo tenuto in piedi solo dal mero rispetto delle procedure. In questo scenario, anche le libertà individuali, diverse dalla mera libertà economica, finiscono con l’essere minacciate, proprio perché non necessarie, quando non ostative, al corretto funzionamento del mercato”.
- ...
- Così l’ordine neo-liberale finisce col ridurre le libertà “classiche”, per dedicarsi alla salvaguardia della concorrenza.
- A tale riguardo non si può non condividere, almeno per l’Italia, quanto scrive Iannello: nell’ultimo trentennio sono state poste in essere decine di norme volte a rendere più difficile, costoso, defatigante il concreto esercizio di diritti conclamati rumorosamente quanto sabotati silenziosamente; per lo più se, loro contraddittori erano (e sono) le pubbliche amministrazioni.
- ...
- Ed è chiaro che le grandi imprese multinazionali e non, non hanno per la tutela delle loro pretese, tanto bisogno di un Giudice, data la posizione di forza che hanno, anche nei confronti di tanti Stati; parafrasando il detto di Hegel, se non c’è Pretore tra gli Stati, non se ne sente granché la necessità neppure tra questi e le macro-imprese.
- ...
- Nel capitolo conclusivo, l’autore sostiene che la subordinazione della politica all’economia non è ineluttabile “né il destino della società, né quello dell’uomo, può essere la riduzione alla sola dimensione economica e il dominio dalla tecno-economia”. L’auspicio è invertire l’ordine delle priorità “per ricostruire gli Stati nazionali e per fondare, finalmente, una federazione europea in continuità con i principi liberaldemocratici e con il costituzionalismo del Novecento, che sia custode della civiltà e della libertà e che riponga al centro, coerentemente, la persona umana”.
- ...
- Due osservazioni per concludere questa recensione. Non è prevedibile come finisca l’ordine neo-liberale, anche se si vede che sta collassando, ma non si percepisce chiaramente come sarà sostituito. Anche per questo è interessante il saggio di Iannello, perché mostra come valori manifestati e istituzioni volte a preservarli si convertono in ordini concreti diversi e talvolta opposti. Specie se vengono ignorati (e spesso occultati) regolarità, leggi sociali, presupposti. Ad esempio nella contrapposizione globalisti/sovranisti sembra che i secondi vogliono la sovranità e gli altri sopprimerla. In effetti se ai tempi di Sieyès l’alternativa era tra sovranità del monarca o della nazione, nell’attuale è tra quella delle macro-imprese (élite, classi dirigenti) sovranazionali o del popolo (anche attraverso la rappresentanza di una scelta). Tant’è che gli Stati non sono in via di eliminazione, ma di sottomissione perché il loro apparato di regolazione e di coercizione è indispensabile per l’ordine voluto dalla sovranità globale.
- ...
- In secondo luogo, scriveva Maurice Hauriou, che la dottrina teologica più propizia alla libertà è quella del diritto divino provvidenziale: in effetti anche questo saggio appare condividerla. Un’opera interessante che amplia la prospettiva da cui si considera l’epoca attuale.
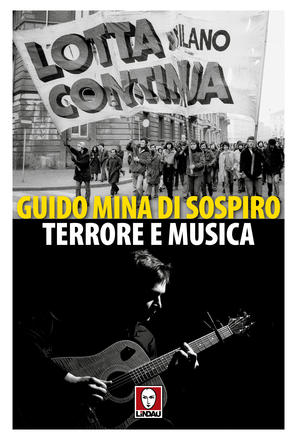
"Terrore e musica" - Un libro di
- Guido Mina di Sospiro
- rec. di
- Giovanni Sessa
- (Guido Mina di Sospiro, Terrore e musica, Lindau, Torino 2025, pp. 256, euro 19,00)
- In Italia, gli anni Settanta del secolo scorso sono stati un decennio cruciale. Da un lato, sotto il profilo politico, in quel frangente storico si assistette al radicalizzarsi degli scontri tra “opposti estremismi”, furono gli “anni di piombo”, seconda fase della guerra civile italiana. Il mondo della cultura, al contrario, mostrava una non comune vivacità, in particolare in ambito musicale. Tale duplicità dei Settanta è ben testimoniata dall’ultima fatica di Guido Mina di Sospiro, Terrore e musica, nelle librerie per i tipi di Lindau (pp. 256, euro 19,00). Il volume è articolato in una premessa, in 19 capitoli e tre brevi Appendici. Presenta, nella prosa affabulatoria, snella e graffiante dell’autore, i pregi della migliore narrativa mentre, per la puntuale ricostruzione storica degli eventi narrati, in forza di una non comune conoscenza della documentazione storica e giornalistica in tema, può anche essere letto quale saggio su cultura e politica in quel decennio tragico e, per certi versi, cruciale per la comprensione della contemporaneità.
- ...
- In realtà, Terrore e musica, è qualcosa di più di un semplice romanzo e di un saggio documentato. È, fondamentalmente, la storia dell’educazione sentimentale, della formazione dell’autore che ha, quale sfondo di scena, la città in cui visse dopo il ritorno in Italia dall’Argentina, dove è nato. Mina di Sospiro discende da un’antica famiglia, e la città in cui trascorse l’adolescenza è Milano, epicentro delle tensioni sociali e politiche allora in essere. Mina è abilissimo nel ricostruire, in medaglioni dal tratto fotografico, veri e propri “scritture di luce”, le atmosfere di Milano, città grigia e nebbiosa, per la quale l’autore prova un sentimento commisto di amore e odio, come Joyce per Dublino. Fa rivivere, sulla pagine, il primo incontro con il preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci. Questi lo introdusse al “clima” dell’epoca, nel quale il giovane che si affacciava alla vita avrebbe dovuto muoversi, mostrandogli una vetrata della presidenza crivellata dai colpi di proiettili delle “avanguardie proletarie” che “animavano” quella scuola. Ricorda, inoltre, i picchetti davanti all’ingesso, che spesso si concludevano con pestaggi. Dalle descrizioni si evince lo sconcerto che egli allora provò di fronte a tali scene drammatiche. Mise in atto, per poter sopravvivere in tale realtà, una sorta di “mascheramento” sostanziato di distanza atarassica nei confronti dei sostenitori del “tutto è politica”.
- ...
- La maschera di Mina è quella dell’impolitico in senso manniano, che è, si badi, essa stessa in qualche modo politica, in quanto centrata sul rifiuto di un presente inaccettabile. Mentre esteriormente l’adolescente sembrava partecipare alla “recita” dei più, il suo foro interiore si formava e rafforzava soprattutto nell’interesse per la musica. Mentre Milano viveva giornate drammatiche (il pestaggio e la morte di Sergio Ramelli, come quelle di alcuni militanti di sinistra, sono rievocati con toni commossi) e l’Italia precipitava nella “strategia della tensione” (eterodiretta, oggi è chiaro, dagli effettivi detentori del potere), Brigate Rosse e stragisti divennero protagonisti indiscussi della cronaca. Il nostro autore, nella Milano delle “bottiglie Molotov”, incontrò il noto Maestro di chitarra Brambilla, che: «si sentiva in dovere di insegnare […] l’armonia, quindi gli accordi, la progressione degli stessi» (p. 21). Mina, a riguardo, chiosa: « la chitarra mi diede, fin dall’inizio, una sensazione di felicità che rasentava l’ebbrezza» (p.21). La medesima sensazione che provava nel frequentare i concerti con gli amici o durante le onnivore letture nelle sale della biblioteca Sormani.
- ...
- Queste letture compensavano la formazione di parte, politicizzata, che veniva impartita nelle aule del liceo. I docenti del Leonardo, la loro personalità e cultura, vengono presentate in stilizzazioni sferzanti e riuscite. La professoressa Sprezzante riteneva che: «la matematica si fosse fermata a Cartesio, la fisica a Newton, la geometria a Euclide» (p. 36). Disprezzavano, la docente e i suoi colleghi, il “qualunquismo” dell’uomo della strada: dalle loro “lezioni” di marxismo alla gauche caviar era possibile difendersi solo con il ricorso all’ironia. La scoperta della musica di Monteverdi risultò essenziale per comprendere la realtà di quegli anni: «Fu Monteverdi a inaugurare gradualmente i tre secoli del periodo tonale adottando l’accordo di settima dominante» (p. 31). In musica, un campo gravitazionale, rileva Mina, mette in atto una forza eccezionale capace di indirizzare l’ascolto. In politica, le ideologie: «erano in grado di esercitare forze gravitazionali (che) costringevano la gente a uccidersi a vicenda» (p. 32), in nome dell’astrazione concettuale che nulla sa della vita e del primato della persona. Una diversa visione del mondo il giovane incontrò nel trattato di Sallustio, Sugli dèi ed il mondo e durante la prima rappresentazione della, Passione secondo Matteo di Bach, diretta da Antoine-Pierre de Bavier, organizzata dalla madre di Mina. Una sorta di musica delle sfere, illuminante, calata nella realtà nebbiosa e magica della Milano della P 38, delle chiavi inglesi e dell’eroina dilagante tra i giovani. Lungo la strada della sua educazione sentimentale, a un certo momento, per il nostro autore, libri, musica, viaggi, amori adolescenziali, non parvero più adeguati alla scelta di vita da “convitato di pietra” negli “anni di piombo”. Subentrò un ulteriore distacco, più profondo, dalla realtà storica. Mina lo ha di fatto trascritto, assieme ad amici fidati, nel cortometraggio, Heroes and Villains, proiettato nella Cineteca di Milano. Mina ricorda l’ostracismo incontrato nel promuovere questa produzione cinematografica. Allora, bisognava essere parte di una “cordata” politica per ottenere l’attenzione di critica e di pubblico. Da uomo libero, l’autore si sottrasse al ricatto ideologico. Fu sollevato dalla delusione, dalla scoperta della musica di Nick Drake: «Ne avevo imparato anche i testi e passavo […] tempo a cantarli e a suonarli» (p. 215).
- ...
- Nella chiusa del volume, il valente scrittore nota: «l’idea che la violenza sia giustificabile, anzi necessaria, permea la storia e l’antropologia italiane» (p. 233). Un insegnamento da tenere in debito conto. Terrore e musica è, a parere di chi scrive, libro jüngeriano. Elegge il foro interiore a luogo di custodia della libertà, in un mondo che tende, sempre più, a negarla.
-
INTERVISTA A MACHIAVELLI - (DEL 27/06/2025)
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
Dato l’alternarsi di guerra e pace, di riarmi controversi, di canti di vittorie e te deum intonati da tutti i contendenti, siamo andati a chiedere, come sempre, l’opinione a Machiavelli, il quale ci ha ricevuti con l’usuale cortesia.- ...
- Che ne pensa della situazione europea dopo le dichiarazioni di Trump sul riparto delle spese NATO?
- Che il Presidente americano cerca di risparmiare. Soprattutto perché è convinto – ed ha ragione – che la Russa di Putin è molto meno pericolosa dell’URSS anche per l’Europa, onde può essere affrontata riducendo l’impegno americano, almeno quello convenzionale. Onde gli europei devono farsene carico. Coloro i quali pensano che Putin sia un nuovo Lenin, un nuovo Trutzky o anche un nuovo Stalin non hanno capito la “natura” di guerra civile mondiale del vecchio bolscevismo.
- ...
- E il riarmo europeo è un rimedio?
- A metà. Ai miei tempi ancora meno. Comunque, come scrissi, sono gli uomini e il ferro a procurare danaro e cibo, non viceversa; e aggiunsi che il disarmato ricco è premio del soldato povero. La conseguenza è duplice: che tutte le storie raccontate dai vostri governanti sulla povertà dei russi che avrebbero dovuto soccombere alla ricchezza dell’occidente, andavano, semmai, ribaltate. Secondariamente per non ripetere un simile errore dovete considerare che l’altra metà è di assicurarsi una reale volontà di combattere tra i cittadini prima e nell’esercito, poi. Elemento decisivo della quale è la sintonia tra vertice e popolo. Che, come dice il vice-Presidente Vance, in Europa è, a dir poco, carente.
- ...
- Per conservare la pace, serve preparare la guerra? Oppure le armi la inducono?
- Non so se la Meloni abbia letto Vegezio, ma per confortarne il pensiero basta il buon senso. L’opposta tesi omette di ricordare che la guerra dipende non solo dalla mia volontà, ma da quella del nemico. Il quale può essere dissuaso se l’obiettivo che si propone non può essere realizzato per la nostra preparazione militare. D’altra parte ho scritto che la fortuna è arbitro di metà delle azioni umane, ma l’altra metà è a nostra disposizione: prepararsi alla difesa è costituire un argine alle inondazioni della storia. E virtù dei governanti apprestarlo; ma anche di questa da voi ce n’è poca, e mal distribuita.
- ...
- Cosa ne pensa che nella guerra USA-Iran-Israele tutti cantino vittoria? Non è impossibile?
- Sicuramente. Ma può essere utile quando una sconfitta è evidente; evitare di far nascere dalla sconfitta il revanscismo, di cui i francesi (ma non solo) sono gli esperti: onde la sconfitta di oggi è gravida della guerra di domani. Ma se tutti si dichiarano vincitori, almeno tale convinzione è il vaccino migliore contro le velleità di rivincita.
- ...
- Ma se c’è un nemico non è necessario batterlo?
- Sì, ma non eliminarlo con un bellum internecinum. E’ col nemico che si fa la pace. Più la guerra è relativizzata, più è facile avviare trattative di pace. Se ogni guerra è psicologica, e voi fate guerre più psicologiche che in altre epoche, ai gazzettieri e ai talk-show è affidato il messaggio di vittoria o sconfitta. Come c’è la guerra, c’è anche la pace psicologica. Propiziata da rappresentazioni disformi dal reale, ma tranquillanti. Scrissi che in guerra l’inganno (al nemico) è sempre lecito; e non posso non dire che per fare la pace non sia lecito distorcere la realtà, raccontandosene un’altra, quanto meno verosimile, che consenta di salvare la patria e la sua indipendenza.
- ...
- La ringrazio molto, caro Segretario.
- Mi torni a trovare, una chiacchierata sul mondo mi tiene in esercizio.
-
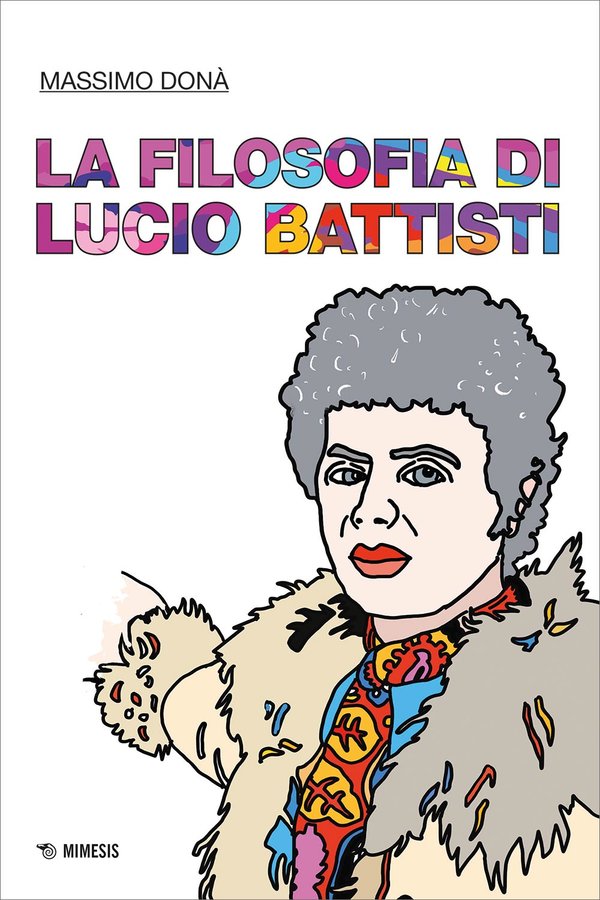
"La filosofia di Lucio Battisti"- Un saggio di
- Massimo Donà
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- (Massimo Donà, La filosofia di Lucio Battisti, Mimesis, 2025, pp. 137, euro 14,00)
- Massimo Donà, filosofo, musicista e strumentista di primo livello, ha dedicato un numero considerevole di volumi all’esegesi teoretica della produzione musicale di artisti del secolo XX, tra essi Miles Davis, i Beatles e i Rolling Stones. Non si è occupato, sic et simpliciter, della sola musica “alta”, colta (cfr., in tema, il suo Filosofia della musica, 2006) ma anche di musica considerata, dal pensiero corrente, “leggera”. Donà ha contezza che la distinzione tra cultura “alta” e “bassa” è l’esito, al pari degli altri dualismi che parcellizzano il pensiero e la vita, del primato del concetto impostosi nella filosofia europea. In ultimo, eccolo a confrontarsi con una delle icone della musica, non solo italiana, degli anni Settanta e Ottanta, Lucio Battisti. Lo fa nel suo ultimo libro, La filosofia di Lucio Battisti, comparso nel catalogo Mimesis. Un testo che induce nel lettore il medesimo effetto magico-incantatorio prodotto delle atmosfere aleggianti nei brani del musicista di Poggio Bustone. Il filosofo veneziano mostra di avere una conoscenza non comune tanto del repertorio di Battisti, quanto della letteratura critica in argomento, che egli interpreta con persuasività d’accenti.
- ...
- Il libro è aperto da un prologo e si sviluppa in quattro capitoli nei quali vengono attraversate e discusse le fasi più rilevanti della produzione del Lucio nazionale, dagli esordi alla collaborazione con Pasquale Panella. Sostanzialmente, Donà legge Battisti quale esempio mirabile del processo de-costruttivo della “forma-canzone”. In questo senso, il compositore avrebbe, di fatto, realizzato in musica, la de-costruzione che Derrida auspicava per il “sistema” in filosofia. Anche per questa sola ragione, i testi e le musiche del nostro, risultano meritevoli di un’esegesi teoretica. L’autore de, La filosofia di Battisti, ricostruisce, in prima istanza, le suggestioni culturali che, a partire dagli anni Sessanta, investirono anche il nostro paese. Esse furono vento innovatore mirante a liberare gli uomini da qualsivoglia staticità, in quanto: «Per rimanere veramente fermi […] bisognava correre il più velocemente possibile» (p. 17). Bisognava imparare: «ad abitare il “paradosso”» (p. 17), la contraddizione che anima ogni vita. Tutte le cose, stante la lezione di Calvino, sono, di fatto, intrascendibile parzialità, nelle quali si dice il medesimo non originario.
- ...
- Le “canzoni”, in quel frangente, subirono una metamorfosi radicale: in forza dell’influenza della musica afro-americana, custodivano in sé diversi moduli ritmici, il tre quarti e il quattro quarti. Lo si evince anche da 29 settembre, uno di primi brani del reatino. Si tratta di un racconto musicale breve in cui sono messe in scena da Mogol, in modalità impressionistica, due giornate caratterizzate da un tradimento, non si sa se onirico o reale. Il brano ha andatura sincopata e spiraliforme, non presenta alcuna strofa distinta dal ritornello ed è aperto dalla voce di uno speaker radiofonico. Parole e musica sono trascrizione dell’avvento del post-moderno: da quel momento, nulla sarebbe più stato come prima nell’arte e nella vita. La copertina, del resto, riproduceva un’immagine di Mario Schifano, interprete della pop art. Di lì a poco, con Dolce di giorno e Per una lira, Lucio sarebbe diventato, in prima persona, interprete delle proprie composizioni, proseguendo lungo la strada della de-costruzione. Donà si intrattiene sui rapporti che Lucio strinse con musicisti dell’epoca, con le case discografiche, introducendo il lettore in tutte le produzioni dell’artista. Per mostrare il tratto filosoficamente rilevante di Battisti, è opportuno soffermarsi sull’esegesi donaiana di, La luce dell’est, un brano, sotto il profilo poetico-musicale, davvero magistrale.
- ...
- Fu composta nel 1972 e produce sull’ascoltatore una vera e propria ipnosi sonora. In essa, Lucio si mostra capace: «di essere decostruttivo anche nei confronti del proprio anelito decostruttivo» (p. 65). Egli non fu, quindi, servo neppure della propria libertà e non si vietò di tornare a precedenti modelli compositivi. Con, Amore e non amore, Battisti: «sembra aver preso coscienza del fatto che, in verità, nelle cose tutte gli opposti vivono […] inseparabili» (p. 56). È diventato empedocleo, parla di: «un “gioco” di forze contrastanti […] Forze che dividono e uniscono […] E così fanno essere tutto quel che è » (p. 58). Per questo, la sua musica pretende di valere in uno, come “bella” e “popolare”. Il tema degli opposti fa mostra di sé anche sulla copertina di, Giardini di marzo, a dire il gioco, perpetuamente in fieri, di luce e ombra. Battisti, successivamente, guardò alla musica latino-americana. Iniziò a farlo con, Anima latina, prima del viaggio in Sud America, e proseguì, così, a contaminare il suo dire con sonorità etniche, a ibridare la musica elettronica con il sitar, animato da consapevolezza hegeliana: aveva ormai acquisito chiara contezza che l’andare avanti è sempre un tornare indietro, come si evince dai suoni e dai testi di, Orgoglio e dignità.
- ...
- L’iter di Battisti si concluse con la collaborazione con il poeta ermetico Panella, a seguito della chiusura del rapporto con Mogol. La critica ha finora ritenuto le opere di questa fase creativa di Lucio, le meno riuscite. Donà ribalta tale giudizio. Nella produzione musicale Battisti-Panella, infatti, si fanno ancor più evidenti le implicazioni filosofiche: «il nostro torna a mirare gli opposti; e li vede su un ponte che “connette”, ma non determina e neppure significa» (p. 107). Tutto diviene astratto, la parola si fa musica. L’attualità, il quotidiano, sono anagogicamente ripensati al fine di produrre nell’ascoltatore disincanto per la condizione umana. L’artista scopre che l’aporia è nella vita stessa, insegna agli uomini a sopportarla serenamente attraverso l’arte, quale novello Leopardi. Lucio vede nelle cose quel medesimo che l‘approccio empirico è incapace di trascrivere. Il nostro è divenuto “scrittore di luce”, fotografo (cfr. M. Donà, Filosofia della fotografia, 2025). Non ci sono messaggi da lanciare, non c’è più nulla da capire, come seppe l’Evola dadaista. Non è casuale che il suo ultimo album si intitolasse, Hegel. In esso, di fatto viene messa a tema l’arché che ogni autentico poietes prova a sperimentare e a vivere. Battisti è ancora lui: «pur nella differenza radicale rispetto al passato» (p. 134). La de-costruzione della “forma-canzone” lo ha condotto alla non canzone, al frammento, in modalità profetica e inusitata. Tale lacerto è, si badi, custode dell’arché. Questa, in sintesi, la lezione del Battisti musicista-filosofo di Massimo Donà.
-
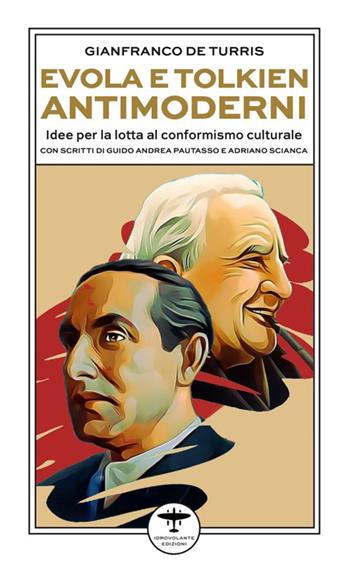
Evola e Tolkien antimoderni- Un saggio di
- Gianfranco de Turris
- rec. di
- Giovanni Sessa
- È da poco comparso nelle librerie per i tipi di Idrovolante Edizioni, un volume davvero prezioso di Gianfranco de Turris, Evola e Tolkien antimoderni. Idee per la lotta al conformismo culturale (per ordini: idrovolante.edizioni@gmail.com, pp. 190, euro 14,00). Il libro si articola in due parti. La prima è dedicata all’analisi, puntuale e organica in ogni suo momento, della vita e dell’iter intellettuale e spirituale del tradizionalista romano, mentre la seconda presenta l’itinerario esistenziale dell’uomo Tolkien e gli aspetti più significativi della sua produzione letteraria centrata sul fantastico. Il volume è chiuso dall’Appendice “Teatrino tolkieniano” nella quale de Turris mette in luce le contraddizioni in cui sono rimasti imbrigliati certi critici italiani malevoli, a seguito dell’uscita del film, Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Il testo è, inoltre, arricchito dalla premessa di Adriano Scianca e dal saggio introduttivo di Guido Andrea Pautasso.
- ...
- De Turris ha scritto pagine fondamentali su questi due autori. Quale curatore dell’opera omnia di Evola e Presidente della Fondazione che porta il nome del filosofo è, di certo, il massimo esperto del pensatore tradizionalista. Del resto, Evola e Tolkien sono gli autori cui ha dedicato la sua vita di studioso. È stato animatore del Premio Tolkien, istituito nel 1980, e direttore della rivista «Minas Tirith», nonché curatore e prefatore di alcune opere del professore oxoniense. Pautasso scrive, con pertinenza argomentativa, che l’obiettivo che muove queste pagine, è da individuarsi nella volontà di far cogliere al lettore la prossimità dei due autori: «L’accostamento Evola-Tolkien emerge dalla fondata condivisione della dimensione simbolica e mitopoietica dell’antimodernità». Essi sostanzialmente operarono da «Demiurghi di un’altra Civiltà», in pieno secolo XX. Evola e il filologo di Oxford furono quasi coetanei. Il primo, infatti, nacque nel 1898 e chiuse i suoi giorni nel 1974, il secondo, nato nel 1892 morì nel 1973. Come uomini, per formazione e carattere, furono diversi. Evola, dapprima dadaista e idealista magico, poi cultore della tradizione ermetica e fondatore del “Gruppo di Ur”, dopo l’incontro con Guénon, realizzatosi sul finire degli anni Venti del “secolo breve”, aderì al tradizionalismo integrale.
- ...
- Nel Secondo dopoguerra si fece latore: «di un “anarchismo di destra” in un mondo che ha (aveva) perso tutti i valori, acerrimo critico del cristianesimo […] antidemocratico e vicino al fascismo». Il secondo, al contrario fu: «amoroso padre di famiglia, conservatore, studioso delle lingue, amante dei Miti del Nord, nemico di ogni totalitarismo, cattolico romano». Nonostante tali differenze caratterizzanti due diverse equazioni personali, essi furono assolutamente prossimi nella valorizzazione del Mito e dei simboli. La loro produzione scrittoria pone come centrali i medesimi valori simbolico-anagogici: l’albero, la montagna, la caverna, il viaggio, la regalità dall’alto, per citarne solo alcuni. In forza di essi, svilupparono: «una implacabile critica della modernità», che permise loro di attraversare da “convitati di pietra” le crisi, tragiche e drammatiche, del Novecento.
- ...
- Non furono, insomma, questa la chiave di volta dell’interpretazioni di de Turris, intellettuali integrati nel loro tempo, ma degli apocalittici. Tale distinzione fu colta, in un suo volume, da Umberto Eco, con il quale, lungamente e tra i primi, il nostro autore polemizzò in merito al senso liberatorio proprio della letteratura fantastica. Evola e Tolkien vedevano nell’accelerazione catagogica verso la quale la modernità pareva avviata, una sciagura inenarrabile, sia sotto il profilo spirituale che esistenziale. La via d’uscita era rappresentata, per loro, da un radicale cambio di paradigma culturale atto a recuperare una kultur radicata nel Sacro. Furono, per questo, critici della tecnoscienza. Evola riteneva che il Gestell, per dirla con Heidegger, condizionasse gli uomini in profondità: «pur se ci offre infinite (apparenti ed effimere) meraviglie». La scienza moderna ha di fatto realizzato la desacralizzazione del mondo ponendo la Natura quale dimensione meramente quantitativa, mera res extensa, di fronte alla res cogitans-uomo, divenuto “padrone dell’ente”. La realtà animata e meravigliante della physis è stata, dall’Impianto tecnico, devastata, deturpata, sfruttata per ragioni legate all’utile e alla produzione.
- ...
- Le macchine, comprese quelle che hanno creato l‘infosfera, ci determinano, condizionano il nostro immaginario. Tolkien, ricorda de Turris, durante il Secondo conflitto mondiale, definì l’aereo da guerra : «il vero male», utilizzato, in quel frangente storico dai diversi totalitarismi su piazza. Dopo la guerra, persino l’abitare, a dire del grande scrittore, aveva perso il suo tratto poetico: «Questa casa così graziosa è diventata inabitabile […] è agitata e tormentata dal rumore, avvolta dai fumi. Questa è la vita moderna». Da antimoderni senza compromessi, Evola e Tolkine hanno scritto pagine memorabili sulla Natura. Il tradizionalista, durante le sue pratiche alpinistiche di primo livello, ha riscoperto la montagna quale “regno degli dèi”, nel quale sarebbe stato possibile tornare a far esperienza del sacro, che avvolge, perfino nell’Età Ultima, la vita. Il filologo-narratore fu, invece, cantore impareggiabile della campagna inglese e dei suoi borghi rurali, della monumentalità dei suoi alberi secolari.
- ...
- Il mago bianco Saruman, venduto a Sauron, è simbolo dell’uomo moderno. Distrugge, come lui, i boschi, forgia armi di distruzione e crea nuovi esseri malvagi, gli Uruk-hai. La Natura che altro non è se non il volto dell’origine, del principio, si ribellerà alla devastazione, in forza dell’intervento degli Ent. Questo libro ci dice che l’antimodernismo non è sterile nostalgia, ma prelude al superamento del moderno e del post-moderno. Evola e Tolkien, se abbiamo ben inteso il messaggio di de Turris, furono sostanzialmente animati da una visione ultramodernista, mirata al superamento del tempo presente. L’intera produzione saggistica di de Turris mira a fornire le giuste coordinate perché ciò accada. Una testimonianza da non dimenticare…
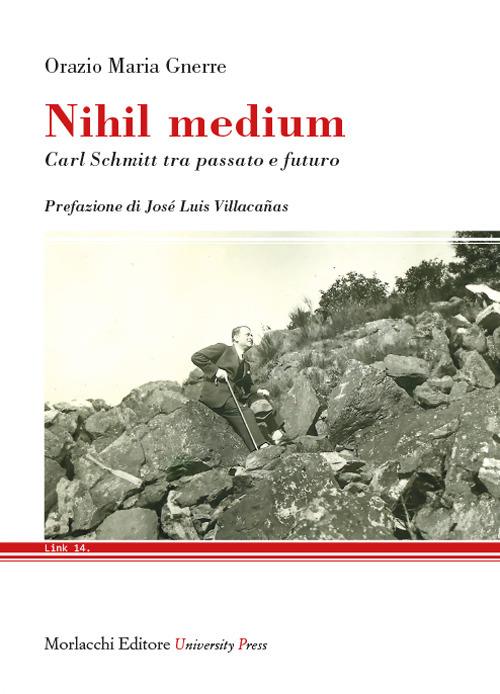
Nihil medium- Carl Schmitt tra passato e futuro
- di
- Orazio Maria Gnerre
- (Morlacchi Editore, Perugia 2024, pp. 185, € 18,00)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Bene ha fatto l’autore a scrivere questo ampio saggio. Carl Schmitt, infatti “è uno dei pensatori che maggiormente hanno influenzato e previsto il tempo presente, grazie alla sua visione complessa e multifattoriale della realtà, che lo ha portato ad indagare diversi campi del sapere per definire una prospettiva globale delle principali questioni politico-sociali della modernità avanzata”.
- ...
- L’attualità di tante intuizioni di Schmitt è impressionante, anche se l’oblio di cui il giurista di Plettemberg era circondato nel secondo dopoguerra non era sorprendente. E non solo per la di esso adesione al partito nazista (anche se in Italia il passaggio dal fascismo alla Repubblica nata dalla resistenza è stato diffuso, perfino nell’alta burocrazia), ma anche di più per l’incompatibilità di molte tesi di Schmitt con gli idola ideologici del nuovo regime italiano (e non solo). Tuttavia a partire dagli anni ‘70 Schmitt era progressivamente rivalutato (e tradotto). Merito all’inizio soprattutto di Miglio e Schiera. Già a metà degli anni ‘80, a pochi mesi dalla morte del giurista di Plettemberg, Maschke poteva indicare nel saggio in memoriam pubblicato su Der Staat l’Italia, tra i paesi europei, come quello in cui il pensiero (e la figura) del giurista renano era all’epoca il più studiato.
- ...
- La differenza dalla situazione attuale, rispetto agli anni ‘80 è che il crollo del comunismo ha modificato la situazione politica. Onde la fecondità delle idee di Schmitt è confermata dalla loro applicabilità all’evoluzione avvenuta: non è solo la sensibilità e l’interesse degli studiosi a sancirla, ma il contesto politico globale.
- ...
- Faccio quale esempio:
- 1) Si legge spesso che l’antitesi tra destra e sinistra sia tramontata: è sicuramente vero, anche se, ad esser più precisi, l’antitesi andrebbe precisata in quella borghese-proletario, che ha dominato nel “secolo breve”, anzi da qualche decennio prima. Schmitt ritiene che (nell’occidente moderno) il campo centrale dello scontro politico (amico-nemico) sia quello decisivo per l’epoca. Così dai primi del ‘500 agli ultimi decenni del ‘600, questo era la teologia, con relativo diffondersi delle guerre di religione; neutralizzato questo Zentralgebiet, poi subentrò quello “etico” per approdare, circa due secoli dopo, a quello economico. Ogni progredire è dovuto alla neutralizzazione dell’opposizione precedente e nella politicizzazione della successiva. Quindi essendosi ormai neutralizzato – o meglio depotenziato – il conflitto borghese/proletario, subentra un nuovo “campo di battaglia”. All’inizio sembrava quello religioso (v. 11 settembre), ma poi più che altro la nuova antitesi globalisti/sovranisti la quale ha come campo di conflitto centrale l’identità dei popoli e la relativa decisione sul loro destino.
- 2) Allo scoppio della guerra russo-ucraina è stato indicato come nuovo satanasso (e non solo) Putin, il quale oltre a personificare il male, era un po’ tonto, gravemente malato, ecc. ecc. Invece Putin non faceva (e fa) che rivendicare parte del Grossraum russo, conquistato in quattro secoli dai suoi predecessori. E il Grossraum, lo spazio vitale degli imperi è idea di Schmitt esposta in molti scritti, e soprattutto nel Nomos della terra.
- 3) Al tempo del COVID, (quasi) l’intera Italia cascò dal pero, notando che il governo, coi decreti del Presidente del Consiglio, limitava i diritti garantiti dalla Costituzione “più bella del mondo”. In questo caso, qualcuno si ricordò del pensiero di Schmitt sullo stato d’eccezione, il quale nello Stato moderno si realizza con la sospensione, la modifica o la deroga della legislazione normale, sostituita da normativa (e non solo, anche con organi straordinari) d’emergenza. La quale arriva (anche nel caso COVID) a limitare o sospendere diritti garantiti dalla Costituzione. La parte politica più zelante nella difesa della normativa eccezionale fu proprio quella che dell’oblio dello stato d’eccezione e – ma a un tempo - della limitazione dei diritti aveva fatto una “dottrina”.
- ...
- Questi sono solo alcuni dei punti in cui le idee di Schmitt mostrano un’attualità sorprendente, ma solo per coloro che le valutano sotto il profilo ideologico; mentre connotato di Schmitt è che le sue idee seguono sempre la massima di Machiavelli di considerare la realtà delle cose e non la loro immaginazione; e meno ancora di valutarle in base alle convinzioni ideologiche.
- ...
- Il saggio di Gnerre considera altri aspetti vitali ed attuali delle concezioni di Schmitt: dal pensiero di Ernst Kapp sulla civiltà talassica del mediterraneo al colonialismo europeo in Africa; dalle migrazioni umane alla teologia economica. Proprio su quest’ultimo argomento, basantesi sul confronto del pensiero di Max Weber e Carl Schmitt, Gnerre parte dalla considerazione che “esiste un rapporto tra religione ed economia, e ciò è tanto più evidente in quanto l’economia, secondo l’insegnamento di Weber, non può essere separata dalle sue risultanti nell’organizzazione sociale”. Il capitalismo è stato favorito dalla teologia protestante, calvinista soprattutto. Diverso è con la teologia (e soprattutto la Chiesa) cattolica perché “il cattolicesimo saprà adattarsi a ogni ordine sociale e politico, anche in quello in cui dominano gli imprenditori capitalistici […]. Ma questo adattarsi gli è possibile solo se il potere basato su una situazione economica sarà divenuto politico, cioè se i capitalisti[…] si assumeranno la responsabilità, in tutte le forme della rappresentazione statale”. Ma il capitalismo ha una natura privatistica e non “pubblica”. Quanto al liberalismo, “controparte ideologica dell’economia capitalista” l’autore riprende le considerazioni di Donoso Cortes, molto simili a quelle precedenti di de Bonald, per cui “ogni teologia ha un fondamento radicale, ma solo il liberalismo era riuscito a costruire una teologia politica nella negazione di ogni punto di riferimento essenziale, allontanando Dio dal mondo”. Il deismo che è la teologia sottesa al liberalismo, concepisce un Dio creatore, ma non interveniente nel mondo. Come scriveva Bonald se il teismo era la teologia cattolica e l’ateismo quella delle correnti democratiche (giacobini), il deismo era quello dei costituzionali dell’89, i quali avevano inventato una forma politica con un Re il quale, come il Dio deista, non agisce e non interviene nella politica (regna ma non governa).
- ...
- Gnerre ritiene che se la dottrina della predestinazione e “l’ascesi intramondana” ha favorito il capitalismo e addirittura ha giudicato la miseria segno di colpa, ciò non è avvenuto con la teologia cattolica. Anche se in correnti cristiane, di converso, la ricchezza era considerata elemento negativo “la visione cattolica della religione cristiana concilia invece le dimensioni della materia e dello spirito, cercando di non frustrare il primo, ma sottomettendolo formalmente al secondo”. Scrive l’autore che “E’ lo stesso Carl Schmitt a ribadire come sia nel deismo che vada rintracciata la teologia fondamentale che sostanzia il liberalismo. Tuttavia, ciò crea un paradosso di portata incommensurabile per cui il deismo, che è una teologia senza grande interesse per la religione, produce una teologia politica che non è affatto teologica”.
- ...
- A questo punto il recensore rivolge una domanda all’autore, contando che scriverà una congrua risposta, in tema di teologia politica (di attualità). De Bonald (per i democratici giacobini) e Donoso Cortes (per i socialisti) indicavano il carattere panteista della teologia loro sottesa, ritenendo la società umana come prodotta spontaneamente, senza un’autorità, un ordine, senza che fosse necessario un sovrano. La società comunista (dopo la dittatura del proletariato), la cuoca di Lenin (in grado di “governare” la società) sono esempi (estremi) di un ordine spontaneo, in cui l’autorità è superflua.
- ...
- Ma non è che certe idee tecnocratiche nostre contemporanee, che derivano (deviandola) dalla mano invisibile di Adam Smith, non sono affini a quella socialista nelle radici panteiste, nell’illusione di poter realizzare un ordine senza un principio e un potere ordinatore? Insomma l’amministrazione delle cose, destinate a sostituire il governo degli uomini, ha anch’essa una teologia politica, confermandosi così la concezione di Hauriou che ogni ordine giuridico è l’involucro (couche) di un fondo (fond) teologico? Nel complesso un libro che merita di essere letto per capire il nostro presente, onde se ne consiglia la lettura.
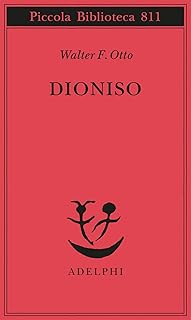
Dioniso. - Mito e culto
- Un’opera fondamentale di
- Walter Friedrich Otto
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Walter F. Otto è stato uno dei maggiori esegeti novecenteschi del mondo antico e, in particolare, della cultura e della religione greca. Ne 1929 dette alle stampe un testo, Gli dèi della Grecia, che rappresentò un momento di svolta negli studi in tema. Nel 1933, inoltre, uscì un testo che, assieme ad altri volumi, l’ultimo dei quali vide la luce nel 1938, gli consentì di definire, in termini compiuti, le proprie tesi relative alla straordinarietà della religione dell’Ellade. Ci riferiamo a, Dioniso. Mito e culto. Questo studio è nuovamente nelle librerie per i tipi di Adelphi, a cura del germanista Giampiero Moretti (pp. 285, euro 15,20). Per entrare nelle vive cose della trattazione dell’insigne storico delle religioni è bene muovere da questa considerazione del curatore, tratta dalla postfazione che accompagna il volume: «(Otto) riteneva che il fenomeno complessivo della grecità non potesse esser affrontato unilateralmente», quasi si trattasse di un evento concluso, da indagarsi esclusivamente con strumentazione storico-filologica né, tantomeno, risultava possibile comprenderlo convenientemente facendo riferimento al cliché estetico, assolutizzato nell’età romantica.
- ...
- Otto, al contrario, individua quale campo centrale e dirimente per la comprensione della kultur ellenica ciò che definisce la “percezione del divino”, carnalmente esperita dagli uomini di quell’età. Una presenza delle potestates divine, chiosa Moretti, che si dava nella forma del mito-racconto e del culto-azione, atti a rendere evidente la loro vigenza nel mondo, nella physis. L’uomo greco veniva “afferrato” in un movimento: «che procede(va) incessantemente da un polo all’altro della relazione uomo-dio». Le forme mitico-cultuali, pertanto, erano lungi dall’essere vissute quali mere “illusioni”. Per tale ragione, le ermeneutiche psicologiste o sociologiche furono ritenute inadeguate dallo studioso tedesco, incapaci di rinviare a ciò che i Greci, nella loro vissutezza, avrebbe chiosato Colli, realmente esperivano della teofania. Il divino era, in Grecia, fatto ontologico. Per quanto attiene alla potestas dionisiaca, Otto rileva che essa, da un lato, era avvertita come opposta ad Apollo ma, allo stesso tempo, induceva, favoriva l’incontro con la polarità divina apparentemente opposta. Per tale ragione, Dioniso, nel suo “darsi” nella vita, alludeva alla “convergente unione”, tra Grecia pre e post-omerica.
- ...
- A dire dello studioso tedesco, nel dio convivevano la dimensione tellurica e quella spirituale. Un teorico della forma, della Gestalt, quale, di certo, fu Otto, in forza di tale assunto guardò con interesse rilevante al dio dell’estasi, dio travalicante limiti, identità e latore della s-determinazione degli enti. Lo fece, ponendosi oltre le stesse lezioni di Bachofen e Creuzer, respingendo, ricorda Moretti: «l’idea che il senso dei misteri […] dionisiaci possa essere ricondotto a una prefigurazione del cristianesimo». Il Dioniso di Otto è dio ellenico. Tale tesi è supportata, in queste pagine, da ampia documentazione archeologica, filologica, storico-religiosa. Dioniso, non casualmente, nasce da madre mortale, con ciò rivelando: «la duplicità dell’essere e il trascorrere da un polo all’altro della duplicità morte-vita in ogni circostanza dionisiaca dell’esistenza», ambiguità testimoniata nel mito e nel culto. Dioniso, per nascita, conosce e vive la dimensione della lacerazione e del dolore, della morte, a differenza delle divinità olimpiche. Pertanto, il divino greco, il divino dionisiaco, ha in sé il tratto dell’eccezionalità, rappresenta un unicum nella storia religiosa dell’uomo europeo, altro, in ciò, dalla religiosità cristiana, di origine asiatica, orientale e, per questo, sostenuta da afflato escatologico e salvifico.
- ...
- Di contro, Dioniso è cuore pulsante, ritmico, della visione tragica greca, come mostra lo sviluppo complesso della tragedia attica. Nell’estasi, nell’entusiasmo, nell’esperire la presenza del principio in sé, i Greci vivevano la contraddizione inscritta nella vita, il rapporto ambiguo uno-molti, zoé e bioi. Il culto donava forma all’informe, trascrivendo il perpetuo gioco della dissolvenza delle esistenze, sempre esposte al confronto con la morte. Sostanzialmente, per Otto il dionisiaco indica un percorso che muove dal divino per coinvolgere l’umano in un iter divinizzante. Sostanzialmente, egli mostra la duplicità divina di Dioniso nel darsi in uno di vita e morte, gioia e dolore, caldo e freddo, simbolizzata, in modalità emblematica, dai suoi attributi vegetali, la vite e l’edera.
- ...
- Ma è il suo darsi attraverso la “maschera” a indicarne l’essenza più profonda, il suo “farsi incontro”, il suo “essere sempre presente” nella physis. In tema, Otto si esprime in questi termini: «Lo si rappresentava con la maschera perché lo si conosceva come il contemplante, è il dio della più immediata presenza […] proprio perché è sua caratteristica apparire improvvisamente e con tanta potenza […] Dioniso è simbolo e manifestazione di ciò che è e allo stesso tempo non è: immediata presenza, in uno con l’assoluta assenza […] ci scuote con una vicinanza che è al tempo stesso un ritrarsi: i misteri ultimi dell’essere e del non-essere fissano l’uomo con occhi smisurati». Affermazione chiarificata dalla complementarità di Apollo e Dioniso, dall’essere il primo “maschera” del secondo: «Il regno olimpico s’innalza al disopra dell’abisso terrestre […] Ma la stirpe dei suoi dèi è scaturita essa stessa da quelle profondità […] essa non sarebbe se non esistesse quel grembo materno, quella fonte sorgiva dell’essere elementare: Apollo con Dioniso, avremmo così la dimensione totale dell’universo […] E con ciò la religione greca, in quanto consacrazione dell’essere com’esso è, avrebbe raggiunto la sua più sublime altezza». Una re-ligio della vita nuda, singolare, esposta al ludico incontro di limite e illimitato, visione del mondo centrata sulla coincidentia oppositorum.
- ...
- Il Dioniso di Otto è libro con il quale si può guardare al senso ultimo della civiltà ellenica. Esso non ha, per questo, solo rilevanza storico-religiosa, ma significativo e attualissimo valore filosofico.
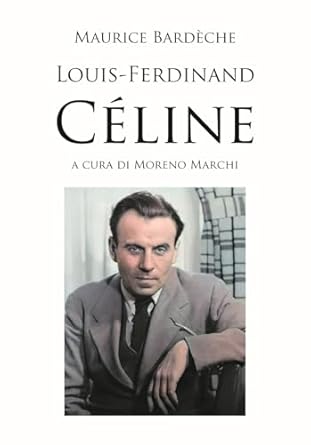
Louis-Ferdinand Céline- Torna in libreria la biografia di
- Maurice Bardèche
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Usciamo dalla lettura di un libro articolato e complesso, appassionato e appassionante, Louis-Ferdinand Céline di Maurice Bardèche, nelle librerie per i tipi di Italia Storica Edizioni (pp. 316, euro 29,00). Il volume, curato dal compianto Moreno Marchi, conserva la sua prefazione alla prima edizione italiana. Si tratta del saggio di un critico letterario di vaglia che si occupò, in modo mirabile, tra gli altri, di Proust. Allo scopo, tra le Appendici rinviamo alla lettura dello scritto di Amerino Griffini, atto a introdurre alla vastissima produzione di Bardèche.
- ...
- Lo scrittore indagato in queste pagine è Céline, uno dei più grandi del Novecento. Lo studio si sviluppa in tre parti, articolate, a loro volta, in numerosi capitoli. In essi, l’enigma Céline è scandagliato in modalità organica e con persuasività d’accenti esegetici. Al centro dell’attenzione, è posto non solo il letterato, di cui l’autore attraversa l’intera opera, ma l’uomo Céline, con l’evidente intenzione di mostrare come i due aspetti, nel collaborazionista, tendano continuamente ad intersecarsi, a sovrapporsi. Marchi, nella prefazione, rileva come Bardèche sia animato, nei confronti dell’autore di Viaggio al termine della morte, da una sorta di “empatia della contraddizione”, connotata dall’ambivalenza di amore-odio. Lo studioso transalpino: «si pone gli abituali problemi di obiettività, ma […] non rifugge dall’immettersi appassionatamente, sanguignamente […] nella vicenda Céline» (p. 5).
- ...
- Quali sono le conclusioni dell’ampio excursus ermeneutico di Bardèche? Prima di ogni altra cosa, egli legge lo scrittore quale abilissimo costruttore di maschere. La sua opera, quindi, non può essere interpretata in chiave autobiografica, quale: «canovaccio [..] di un itinerario» (p. 273) di vita. La deformazione della realtà è stata, volutamente, uno degli obiettivi che hanno mosso la tecnica narrativa céliniana. Céline fu, in uno, artigiano della parola e rock star che disse, il più delle volte in modalità urlata e sincopata, la tragicità della vita nuda. È stato amato, ammirato quale demistificatore, “maestro del sospetto” atto a mettere in guardia dagli idola del tempo in cui visse, ma fu anche odiato. Il suo esercizio parresiastico imbarazzava i benpensanti, li offendeva: «Cos’è uno scrittore che non accetta la responsabilità di quel che ha scritto, quando quel che ha scritto (l’antisemitismo) è stato per altri mortale?», si chiede Bardèche (p. 274). Céline fu, al contempo, irresponsabile ed eroe (eroe lo fu nel secondo dopoguerra durante la tragica peregrinatio da “un castello all’altro” e durante l’esilio danese). Nel corso della vita indossò maschere differenti, lo attesta perfino il nome, mutato da Destouches in Céline per onorare la memoria dell’amata nonna.
- ...
- Mirabile il capitolo dedicato all’infanzia e all’adolescenza, ricco di quadri d’ambiente e atmosfere vivaci, nei quali Bardèche fa muovere familiari e conoscenti dello scrittore e in cui vengono ricordate le diverse attività svolte dal giovane, da commesso a venditore, da funzionario in Africa a “medico dei poveri” in un dispensario. Fu utopista sui generis, non nutriva alcuna fiducia negli uomini. Una lettura attenta della sua opera mostra come i “detti” célianiani”, custodiscano dei “non-detti”, un’ombra ben più importante dell’apparente luce della parola scritta. Nel dopoguerra rispose all’odio con l’odio, non temeva più, eppure: «è (era) ancora prigioniero del suo panico» (p. 275). Assunse una nuova maschera, quella del sacrificato. Lasciò cadere la traccia cinica che, fino ad allora, aveva seguito, si trasformò, in relitto, in proscritto e reietto. Una maschera protettiva fu, in tal caso, la sua. Bardèche, non casualmente, si chiede se Céline fu fascista in senso proprio. Risponde negativamente, precisa che non fu neppure vero “razzista”, fu essenzialmente un medico igienista alieno dall’arianesimo, un “materialista” in senso non-moderno, antico, votato al disincanto della vita nuda: «lo si crede fascista a causa di suoi pamphlet: non lo è più di quanto non fosse comunista quando scrisse il Viaggio» (p. 276). In ultima analisi, egli fu un inclassificabile.
- ...
- La sua opera è costituita: «da due trilogie che non si oppongono che […] corrispondono a due diverse ambientazioni» (p. 276). La prima si spinge dal 1914 al 1930. La seconda è dipintura esistenziale del secondo dopoguerra, a muovere dalla disfatta tedesca. Dalle trilogie si evince che, tratto costitutivo della letteratura céliniana, non è da individuarsi nella politica, in quanto egli: «degli uomini ha un’idea: non una concezione societaria» (p. 277). Espresse, alla luce delle acquisizioni freudiane, il senso profondo delle situazioni in cui visse, lo fece in modalità sentimentale e lirica. Guardò le piaghe dell’esistenza da medico, non nutrendo speranze in una terapia davvero definitiva e risolutiva. Céline visse e scrisse sperimentando, mettendosi alla prova.
- ...
- Negli ultimi anni, suo malgrado, a causa della polemica politica in cui fu coinvolto, assunse la maschera del portabandiera. Letterariamente ripiegò sullo stile, fu stilista d’eccezione, stilista del nulla, al pari di Benn, atto a rendere: «il rappresentato più vero della medesima realtà» (p. 279). Allo scopo si servì, a seconda del periodo produttivo, di diverse declinazioni della comicità, altro volto del tragico: «ad ispirarlo meglio è la miscela tra il grottesco e la tragedia» (p. 280). Si vantava, per questo, di aver compiuto una rivoluzione impressionista in letteratura, di aver sostituito la “luce dello studio” con la “luce all’aria aperta” e aver prodotto una trascrizione della vita così come essa è, coniugando in uno bellezza formale e verità. In realtà, si trasformò in “musicista della parola”: «Quel che conta […] è il ritmo delle sue frasi […] lo stile parlato-emotivo di cui ha preso il brevetto» (p. 282).
- ...
- I Greci ebbero chiara contezza che la musica dice il profondo della vita, il “non” dell’origine che anima ogni esistente. È quanto il lettore può desumere sfogliando il ricco apparto fotografico che accompagna questo volume. Le foto ritraggono Céline assieme a suoi familiari o sodali, in momenti e luoghi diversi. La fotografia, “scrittura di luce”, nell’attimo dello scatto, trascrive quel che il visibile cela e custodisce. L’origine tragica, un principio negativo che anima la physis, che non sta in un altrove ma che vige sempre nel “qui e ora” degli enti.
- ...
- L’iter céliniano, per chi scrive, va esperito in termini filosofici, in quanto teso a dis-velare l’originario. La biografia di Bardèche è di grande pregio, chiarisce i “non-detti” delle maschere sempre all’opera di Céline.
- Antonio Forza, Rino Rumiati,
- "L’errore invisibile. Dalle indagini alla sentenza"
- (Il Mulino 2025, pp. 286, € 20,00)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
E’ noto che il ragionamento giuridico e in particolare quello giudiziario è stato oggetto, oltre che di norme che lo disciplinano, di molti studi. Meno noto è che spesso l’attenzione è stata rivolta a evitare gli errori, le fallacie logiche e argomentative piuttosto che a dettare le regole della corretta decisione. Oltretutto il giudizio è attività umana, e l’argomentare (dei difensori) come la motivazione (dei decisori) è condizionata dalla professione di questi ultimi; onde sono diverse. In particolare se i decisori sono degli esperti (funzionari di carriera od onorari) o dei comuni cittadini (giurie popolari). Il tutto è complicato dal fatto che il linguaggio giuridico non è formalizzato (a differenza di quello scientifico) ma è quello di uso comune.- ...
- Questo libro si pone una domanda, partendo dal dato di fatto che nell’ultimo trentennio in Italia sono stati registrati oltre trentamila casi di ingiusta detenzione: da dove derivano questi errori? Gli autori rilevano che molti conseguono a travisamenti risalenti alla fase iniziale, i quali poi condizionano le fasi successive, decisione compresa. Gli autori prendono in considerazione la psicologia degli inquirenti e così il soggettivismo degli stessi, ossia l’insidia-principe dell’oggettività della decisione (e del diritto). Dai tempi di Bacone e dei suoi idola si sa che sono i pregiudizi a condizionare i giudizi, quel che è nuovo nel saggio è che gli autori si servono dei più moderni strumenti della psicologia.
- ...
- Emerge così un’ampia ricognizione delle “trappole cognitive” che producono effetti nella decisione. E quindi nella vita delle persone. In definitiva un libro da leggere sia per l’argomento sia per il modo di affrontarlo degli autori. Sperando che migliori la qualità delle decisioni e così quella della giustizia di uno Stato di diritto.
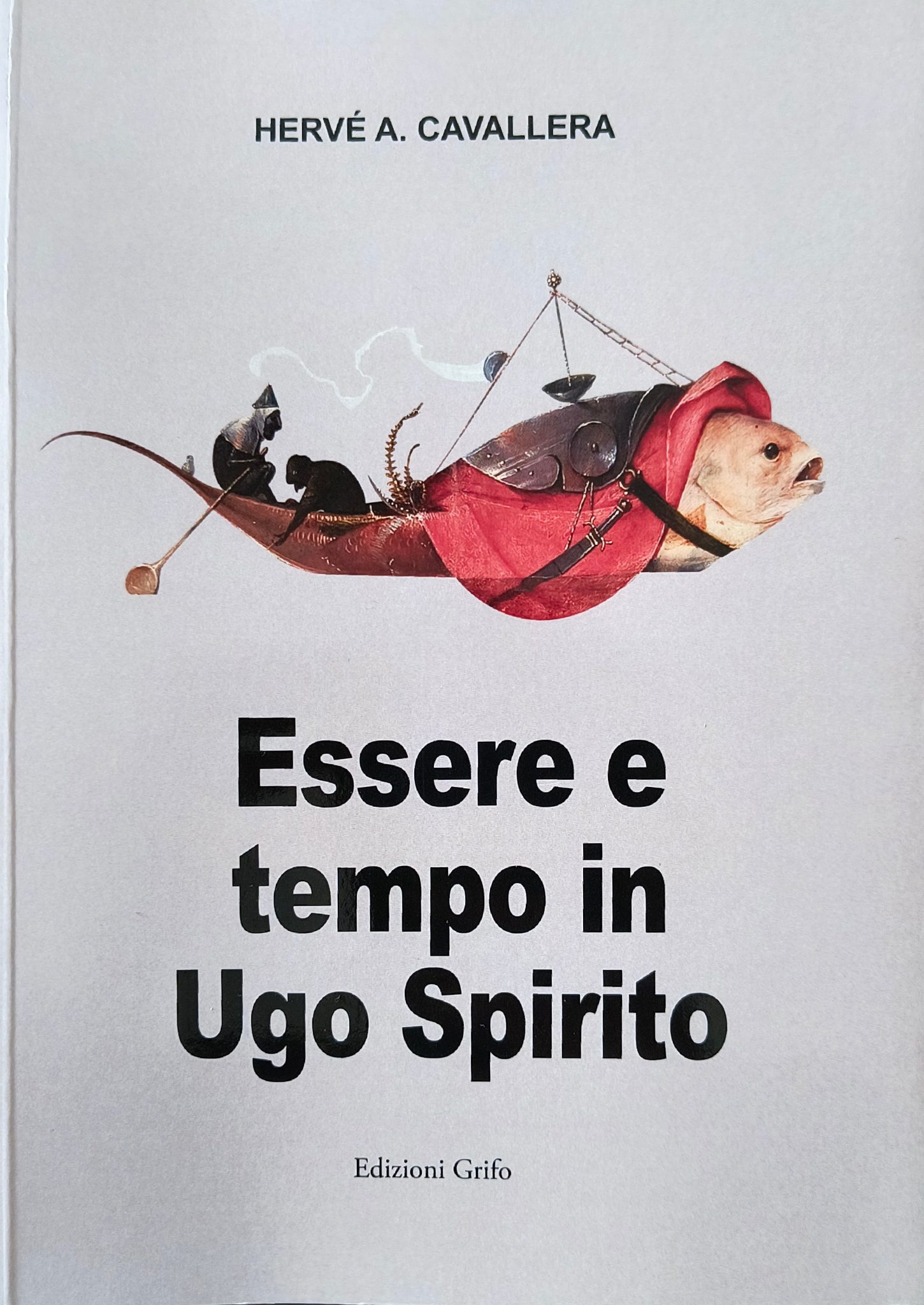
Essere e tempo in Ugo Spirito- Un libro di
- Hervé A. Cavallera
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Hervé A. Cavallera, professore onorario dell’Università del Salento, è curatore dell’opera di Giovanni Gentile e studioso di vaglia del pensiero pedagogico. Nella sua ultima fatica, Essere e tempo in Ugo Spirito, nelle librerie per i tipi delle Edizioni Grifo (pp. 257, euro 20,00), porta la propria attenzione esegetica sulla filosofia dell’allievo di Gentile, interpretato quale pensatore: «che più di altri illustri discepoli del filosofo siciliano ha a suo modo sviluppato l’attualismo» (p. 5). Cavallera accompagna il lettore all’interno dei plessi più rilevanti della speculazione spiritiana, servendosi di una non comune conoscenza dell’opera del filosofo transattualista, attraversata con persuasività di accenti ermeneutici. Non trascura alcun aspetto delle tesi di Spirito, si sofferma sulla dimensione eminentemente etico-politica, e quindi anche pedagogica della proposta del pensatore. ...
- Presenta i tatti dirimenti della sua opzione problematicista, indaga la dimensione religiosa e quella estetica e, soprattutto, si interroga, come esemplificato dal titolo: «sull’esistenza nel suo essere legata al tempo» (p. 6), alla luce di un possibile che, anche nell’età della globalizzazione, potrebbe attualizzarsi, potrebbe farsi storia, nuovo umanesimo.
- ...
- Il volume, articolato in sette capitoli e in un Epilogo, è chiuso da una Appendice che ripropone prefazioni, recensioni e testi utili alla comprensione dell’iter teoretico di Spirito. Alcuni dei saggi sono inediti, altri sono comparsi in studi specialistici e su riviste. In questo senso, è possibile asserire che il libro di Cavallera è un testo conclusivo, imprescindibile per la comprensione della filosofia spiritiana. Il primo capitolo rappresenta, per chi scrive, il momento apicale dell’esegesi dell’autore. In esso, infatti, Cavallera chiarisce la ragioni dell’adesione del pensatore al magistero di Gentile: l’attualismo fu: «l’alternativa al dato del positivismo e alla fede del credente, e per tale motivo deve realizzarsi concretamente. Deve […] divenire azione politica» (p. 14). Per tale ragione, rispetto al fascismo, Gentile tentò di mettere in atto un’azione pedagogica-culturale al fine di ridurlo all’attualismo. Spirito, in sequela del Maestro, fondò con Arnaldo Volpicelli la rivista «Nuovi studi di diritto, economia e politica» con lo scopo di riconnettere: «il pensiero italiano contemporaneo […] alla sua originale e genuina tradizione vichiana» (p. 15), centrata sull’identità di verum e factum. Gli scritti che Spirito dedicò al dibattito sul corporativismo, inteso quale strumento di realizzazione dello Stato etico, analizzati con minuzia di particolari da Cavallera, mostrano l’ inteso impegno politico del pensatore. Tale spendersi nella prassi trovò il suo momento conclusivo nel Convegno di Ferrara del 1932.
- ...
- Il filosofo, prima di presentare al consesso ferrarese la tesi della corporazione proprietaria e il suo corporativismo integrale, si rivolse a Mussolini trovandolo consenziente. Eppure, il corporativismo proprietario, non ottenne il favore che Spirito si sarebbe atteso: a Ferrara fu stroncato sul nascere per intervento diretto, tra gli altri, di Bottai. Da allora, le corporazioni assunsero mero ruolo amministrativo, incapaci di realizzare l’umanesimo del lavoro cui guardavano Gentile e il suo allievo. La proposta di corporazione proprietaria fu definita “comunista”, in realtà si trattava di una tesi “comunitarista” di impianto platonico, centrata sulla valorizzazione della competenza. Del comunismo, Spirito accetta esclusivamente il concetto di programmazione. Nel dopoguerra, infatti, si recò in Urss e in Cina, rimanendo deluso da quanto in quei paesi era stato realizzato. Constatata, di contro, l’impossibilità di realizzare lo Stato etico, la difficoltà di tradurre in atto l’idea, il filosfo inaugurò la fase teorica problematicista. Nel dopoguerra si dedicò ad opere mirate alla trascrizione del presente. Da esse si evince una critica radicale della democrazia liberale, fondata sulla negazione della competenza, così come il rigetto del totalitarismo comunista, incapace di cogliere la vigenza dello Stato in interiore homine.
- ...
- In tale condizione storica ed esistenziale, l’uomo di cultura, cui Spirito guarda, è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. Il suo dire deve farsi esercizio di parresia, libero dai condizionamenti che le parti politiche impongono agli intellettuali, atto a concedere una gioia rasserenante. Precisa Spirito: «Si tratta di una libertà e di una gioia che costano» (p. 30), esito dello svincolarsi del filosofo dagli idola dominati il tempo presente. La filosofia spiritiana anticipa analisi, avanzate decenni dopo, della società neocapitalista. Ha contezza delle trasformazioni che la tecno-scienza stava imponendo al mondo attraverso l’omologazione senza precedenti della realtà: «Si tratta di un passaggio dall’io al noi in ragione della funzionalità» (p. 31), le cui conseguenze cominciavano a farsi sentire perfino nella vita delle chiese. Una situazione, quella imposta dal Ge-stell, inaggirabile: «Ciò non significa che Spirito sia un apologeta del suo tempo […] Si limita a coglierne i caratteri e a illustrali con la lucidità del […] filosofo» (p. 31). Nel mondo contemporaneo si assiste al logoramento, alla liquefazione, di qualsivoglia valore o fede.
- ...
- Nulla si lascia più ricondurre all’unità. Per questo, nonostante la teorizzata morte dell’arte, la creatività stava riaffermando il proprio ruolo ineliminabile (Spirito, ricorda Cavallera, in gioventù fu pittore). L’arte è espressione, infatti, di una soggettività incapace di addivenire epistemicamente all’uno, a cui, per altra via, comunque, essa guarda e allude. Assume, pertanto, ruolo dirimente il “problema” della religione. In tema, Spirito è davvero, nonostante la proclamata “infedeltà” nei confronti del Maestro, allievo di Gentile. I due pensatori sono convinti che il concreto sia: «l’atto spirituale. La cui concezione immanentista […] mentre è l’inveramento del Cristianesimo, può parere perciò anche la liquidazione della religione» (p. 11). La centralità del Cristianesimo è data dall’Incarnazione, con la quale, tale religione, tentò di colmare lo iato distinguente il mondo dal sovramondo. Un Cristianesimo paradossale che non coincide con la fede “ortodossa” e neppure con le chiese positive. Per la sua comprensione è bene tener a mente l’interesse gentiliano per i grandi spiriti religiosi, per i “riformatori” e, tra essi, Bruno.
- ...
- Questi sono solo alcuni dei plessi teorici del volume di Cavallera. La lettura di, Essere e tempo in Ugo Spirito permette di comprendere la grandezza speculativa di questo pensatore. A parere di chi scrive, alcune delle problematiche che egli sollevò, furono anche al centro del dibattito filosofico inaugurato dagli ultrattualisti della linea Emo-Evola-Diano. Spirito, con il suo problematicismo di ascendenza attualista, giunse negli ultimi anni di vita, a una sorta di “sospensione del giudizio” rispetto alle: «diverse possibilità che confluiscono nella ricerca dell’incontrovertibile» (p. 6), lasciò aperta una strada ancora da percorrere. Ragione ulteriore per riflettere sulle pagine di Cavallera…
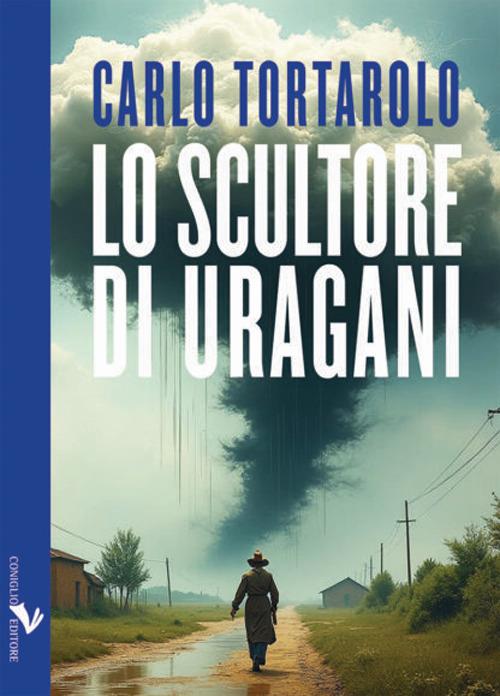
Lo scultore di uragani- Una raccolta di racconti e dialoghi di
- Carlo Tortarolo
- rec. di
- Giovanni Sessa
Carlo Tortarolo è caporedattore di Satisfiction ed editorialista de il Giornale, sulle cui colonne discute temi d’attualità e di politica internazionale. È nelle librerie la sua ultima fatica, Lo scultore di uragani, comparso nel catalogo di Coniglio Editore (per ordini: info@coniglioeditore.com, pp. 188, euro 17,50). Si tratta di una silloge di racconti e dialoghi i cui protagonisti sono frutto della fantasia dell’autore ma, al contempo, rinviano, in modalità del tutto evidente, a protagonisti e tematiche della storia contemporanea, in particolare italiana. - ...
- Gian Paolo Serino, che firma la prefazione, sostiene che Tortarolo è autore raro, dispone, infatti, di un coraggio divenuto, nel nostro tempo, inusuale: il coraggio della Letteratura. La sua prosa è esercizio di parresia, in un tempo che ha girato, apparentemente in modalità definitiva, le spalle alla dimensione assiologia sulla quale, in un passato neppure troppo remoto, gli uomini avevano costruito la propria vita. La scrittura di Tortarolo è agile, lieve nell’incedere dei racconti e ritmica, quanto basta, per trascrivere il rincorrersi dei pensieri nei dialoghi. Una prosa moderna, contemporanea, attenta al parlato, al linguaggio quotidiano degli avventori di bar e locali pubblici.
- ...
- Moderno nella forma, Tortarolo, quanto anti-moderno nei contenuti. Lo scultore di uragani è animato dall’intento di lanciare una sfida al mondo contemporaneo, ai suoi idola, attraversando, con perspicacia argomentativa e persuasività d’accenti, le ragioni della attuale intransitabile crisi. Fin dall’incipit del volume, il nostro autore dichiara di scrivere per: «i postumi del pensiero Unico e per gli antenati» (p. 11). Ha consapevolezza della solitudine esistenziale ed intellettuale nella quale vive, per questo definisce la propria visione delle cose, filosofia immorale, in quanto: «è immorale essere contro il pensiero di tutti» (p. 11). In tale condizione non si può, attraverso lo scrivere, che rivolgersi all’imperitura presenza-colloquiante di chi è stato o, di contro, guardare al futuro, ai “venienti”.
- ...
- Nato alla fine di un decennio tragico, gli anni Settanta, Tortarolo si definisce “nato dalle basi”. Queste: «Sono il frutto del pensiero degli antichi, Della saggezza degli zappatori. Della sapienza di chi sa risparmiare. Di chi non ostenta» (p. 12).
- ...
- Tale attaccamento agli “elementi”, alla dimensione concreta e arcaica della vita, è venuta meno: viviamo in un mondo liquido centrato sulla dismisura, sul “sempre di più” e “sempre più in fretta” in ogni ambito. Solo la parola, l’arte, la creazione, sembrano, nella loro possibilità di scolpire gli uragani che impazzano su di noi e intorno a noi, poter custodire dalla deriva nichilista, dal trionfo dell’astratto e dell’universale, l‘irripetibile singolarità del vivere. L’Occidente è come un treno nella notte la cui corsa va sempre più accelerando in direzione del baratro e: «L’uomo occidentale è come il passeggero del Titanic che […] (aveva) l’illusione di essere a bordo di una nave inaffondabile» (p. 15). Ecco, la scrittura, può svolgere il compito di svegliare gli uomini della nostra epoca da tale sogno che rischia di trasformarsi in incubo. I nostri contemporanei hanno perpetrato un atto di abiura, hanno rinunciato a se stessi, in un iter che, attraverso la denatalità, sta conducendo l’Europa all’estinzione biologica. La tradizione viene meno. Non c’è neppure più la prole a cui poter “trasmettere” ciò che si è ereditato, in termini soprattutto spirituali, da chi ci ha preceduto. Nel racconto, Etica della crisi, viene svelato come la tecnologia informatica, propria del capitalismo computazionale, sia lo strumento dell’etero-direzione della masse, assieme al signoraggio bancario. In, Tutti al voto, dialogo intorno al senso della democrazia liberale, si evince come gruppi di potere transnazionali abbiamo ormai espropriato, di là della false distinzioni tra destra e sinistra sistemiche, la sovranità popolare, riducendo la prassi democratica a “gestione amministrativa”, a governance deprivata di qualsiasi visione realmente progettuale rispetto a un possibile futuro diverso dal presente, in cui trionfa la mercificazione della vita.
- ...
- La categoria di pensiero che meglio qualifica la letteratura di Tortarolo è quella del possibile. Lo si evince dal racconto-dialogo intitolato, Dove c’è il mare. La storia è ambientata in un ipotetico futuro, nel 2062, anno nel quale, si narra, gli italiani avevano ormai perso il ricordo dell’esistenza, al di là dello stretto di Messina, della Sicilia. L‘isola era stata cancellata dalle carte geografiche nel 2032, durante la Terza guerra mondiale. In quell’anno terribile l’isola fu colpita da ordigni nucleari. La memoria storica, giornali, libri, tutto era andato perduto. Uno dei deuteragonisti aveva gelosamente custodito ritagli di quotidiani, usciti in quelle tragiche giornate, oltre a tre volumi di scrittori siciliani che consegnò al suo giovane amico perché questi, al momento opportuno, comunicasse nei suoi scritti la verità su quella fase della storia caduta nell’oblio. Il possibile domina la vita degli uomini. Rispetto agli eventi storici non si può, pertanto, essere fatalisti. La crisi attuale, amplificata dai dogmi del femminismo imperante, spesso stigmatizzati in queste pagine, dalla cultura Woke, tesa a cancellare il passato dell’uomo occidentale, può essere superata in un Nuovo inizio, questo il messaggio di Tortarolo, centrato “sulla cultura della vita”e non su quella della morte e del Nulla. Per pervenire a tanto, gli uomini dovranno far conto sulla loro intelligenza critica e servirsi, all’occorrenza, di pratiche (l’autore fa riferimento agli “Esercizi spirituali” di S. Ignazio) atte a far ri-scoprire in noi, ciò che gli Stoici chiamarono l’Egemonikon, il centro vitale del nostro essere.
- ...
- Quella di Tortarolo, avrebbe chiosato Kierkegaard, è “comunicazione d’esistenza” mirata al risveglio delle coscienze. Dalla Letteratura la possibile nuova vita…
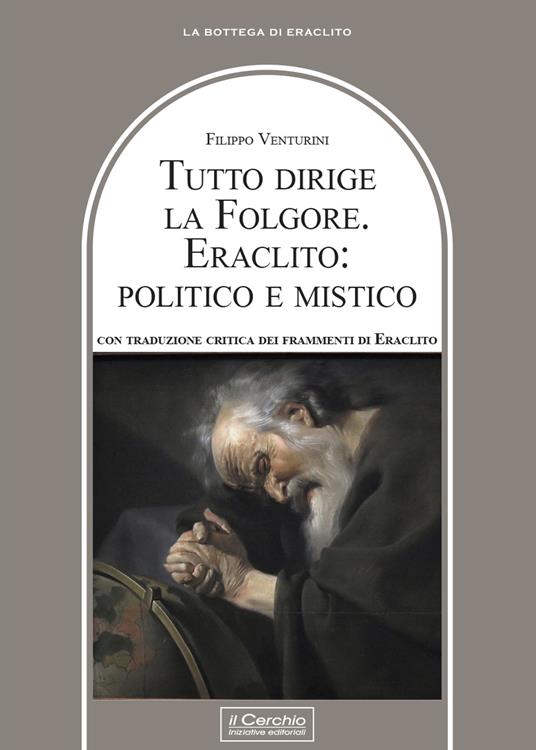
Tutto dirige la folgore- Eraclito:
- politico e mistico
- A proposito di un saggio di
- Filippo Venturini
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Filippo Venturini è noto per alcune significative pubblicazioni di argomento archeologico. Studioso da sempre interessato al pensiero antico, in particolare alla filosofia presocratica, ha da poco dato alle stampe un interessante studio su Eraclito, "Tutto dirige la folgore. Eraclito: politico e mistico", nelle librerie per i tipi de il Cerchio (per ordini: info@ilcerchio.it, pp. 187, euro 24,00). Il saggio è chiuso dalla raccolta dei frammenti del pensatore di Efeso nell’edizione Diels-Kranz dei quali l’autore fornisce, in diversi casi, una traduzione critica e alternativa, accompagnata da commenti ai detti eraclitei assolutamente pertinenti e condivisibili.
- ...
- Il volume, fin dalle prime pagine, chiarisce come Venturini abbia maturato una conoscenza non comune, tanto dei testi del filosofo “oscuro”, quanto della più accreditata letteratura esegetica in tema. Il libro è articolato in tre capitoli: nel primo, il saggista si occupa dell’afflato politico che connota di sé la visione del mondo dell’aristocratico greco; nel secondo affronta i plessi teoretici più significativi della speculazione del filosofo; nel terzo, infine, presenta la tragica fine di Eraclito, interpretandola quale inevitabile conseguenza dell’inattualità politica delle tesi del grande presocratico. Nell’incipit del testo, Venturini, in forza della lezione di Nietzsche, rileva come i Greci, nella propria tradizione, abbiano accolto anche visioni esotiche, provenienti dall’Oriente, rielaborandole in modalità originale, alla luce dell’ethos ellenico. In particolare, sostiene che: «Eraclito è un pensatore […] politico, nel senso più ampio ed esauriente di questo termine […] un pensatore della polis, un pensatore comunitario» (p. 8). La sua filosofia è legata, dato il retaggio nobiliare, allo sfondo mitico della cultura religiosa poliadica. Nella sua vita e nei suoi frammenti è chiarissimo l’emergere delle due tendenze fondamentali, che a dire di Colli, dettero luogo alla kultur ellenica: la propensione mistico-dionisiaca e la tensione apollineo-politica, protesa, quest’ultima, a dar “forma” alla caoticità conflittuale della vita.
- ...
- Fu coinvolto, in prima persona, nella vita di Efeso, appoggiando il tentativo politico di Ermodoro. La sua concezione anti-dualista e relazionale degli opposti, stante la lezione di Teognide, lo indusse a leggere il polemos vigente nella polis in sintomia con quello che si dà nella physis. Venturini, con Gadamer, ritiene che i continui riferimenti a phronesis, “virtù, ragionevolezza dell’azione”, presenti nei frammenti, attestino, in tutta evidenza, il tratto eminentemente pratico del pensiero dell’efesino. Eraclito pensò, al pari degli altri Sapienti ellenici, la physis sintonica a politeia, “costituzione”. La dimensione “democratica”, da intendersi in senso greco, rilevata in Eraclito da Preve, non contrasta con l’animo aristocratico del pensatore: a seguito del fallimento del progetto di Ermodoro, la natura nobile lo indusse a disprezzare le masse, insensibili, orami, a qualsivoglia politica anagogica. L’integrità di cosmo e polis era, in quel frangente storico, minacciata: «dalle forze contrastanti e centrifughe dell’egoismo dei singoli e delle fazioni, generato dalla brama di ricchezza» (p. 10). L’irruzione della moneta nel mondo greco aveva prodotto eris, corrompendo parte significativa della stessa aristocrazia. All’atomismo sociale di cui furono latori i nuovi ceti emergenti plutocratici, Eraclito contrappose, con inusuale potenza teorica, la struttura organica del cosmo, inteso quale spazio ordinato da leggi.
- ...
- Avrebbe voluto con tale richiamo alla visione aurorale ellenica, “svegliare” gli inconsapevoli, i “dormienti” . Gli uomini sono momento dell’armonia cosmica di cui dice il fr. 30: «la cui essenza è il perenne balenare della luce (physis) dall’oscurità che la circonda» (p. 11). La luce evidenzia gli “elementi” che costituiscono il reale, attraverso i metra, spazio e tempo. A tale incedere naturale l’uomo corrisponde con la vista, il “vedere”, che dischiude l’aphanes, l’armonia di "tutte-cose", di cui dice il fr. 54. Heidegger ha rilevato che tale “inappariscente” armonia è: «qualcosa che si ha costantemente sotto gli occhi, ma della quale non si è consci» (p. 11). Chi colga tale consapevolezza, giunge all’origine, al principio, alla coincidentia oppositorum, oltre la logica diairetica dell’identità. Pervenirvi, implica “conoscere se stessi”, controllare le pulsioni katagogiche che pur ci costituiscono. Eraclito e i Greci non conobbero “metafisica”, seppero che l’uno si dà solo nei molti e l’“al di là”, se si vuole utilizzare tale temine, vive nel “qui e ora” dell’eterno presente, nella congiunzione di kairos con aion, nella memoria comunitaria della polis. Colli sostenne che tale istanza conoscitiva è “vissutezza” non comunicabile, in quanto contatto con lo sfondo abissale della vita, meravigliante e tragico in uno.
- ...
- Politica e mistica in Eraclito coincidono: la polis testimonia l’unità di finito e infinito, rende possibile vedere: «l’unità del tutto e la competizione tra gli opposti» ( p. 14), come si evince dal fr. 53. A causa della delusione patita a seguito del fallimento del progetto di Ermodoro, Eraclito si immerse nella natura selvaggia, si dette al “vagabondaggio”. Non fu questa, chiosa Venturini, una scelta anti-politica, ma estrema testimonianza della vocazione mistico-politica autenticamente ellenica. Eraclito, nei boschi, “visse”, come seppe Bruno, il senso ultimo del mito di Atteone, colse l’esser uno di soggetto e oggetto: tutto è dynamis, possibilità-potenza-libertà. Il cliché scolastico che presenta Eraclito “piangente” va, dunque, capovolto nell’Heraclitus ridens. Eraclito è filosofo della soglia che unisce tempo ed eternità, per questo gli Efesini ne venerarono le spoglie mortali. Il filosofo si spese nel tentativo di insegnare ai propri concittadini che la vita nuda può essere amata e vissuta solo nella polis ordinata, trascrizione dei ritmi della physis.

"Nel lento movimento dei ghiacci"- Le prose poetiche e la dipintura del Nulla
- di
- Gian Ruggero Manzoni
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- È nelle librerie, per l’editore Puntoacapo, un volume di Gian Ruggero Manzoni, Nel lento movimento dei ghiacci (per ordini: acquisti@puntoacapo-editrice.com, pp.113, euro 15,00). Manzoni è ben noto ai lettori quale autore di numerose pubblicazioni, traduttore di testi sacri, studioso di miti ma anche di astrofisica, e soprattutto quale autentico poietes, uomo d’arte e di poesia. Recentemente, il critico Stefano Lecchini lo ha definito artista: «tra i più radicali ed eccentrici presenti in Italia, […] porta in sé una scintilla di verità in un mondo dominato e anestetizzato dal falso». Questa asserzione consente di entrare nelle vive cose del libro che qui presentiamo. Il testo raccoglie tre componimenti in prosa poetica i cui temi hanno valore universale. L’autore dice dall’origine dell’umanità, si interroga sia sul senso del nostro viverre e di quello degli enti di natura che sul significato profondo della morte e, soprattutto, si intrattiene sul valore della creazione artistico-poetica. Una confessione esistenziale ad alta voce, quella di Manzoni, sentita, partecipata, vissuta nella nuda carne.
- ...
- Un’opera sacrificale, trascrizione del sacrificio, di quel “fare sacro”, proprio di ogni autentico creatore. Lo seppero i Greci con la Tragedia, produzione comunitaria, nella quale, in forza della presenza della potestas dionisiaca, i ruoli di autore-attori-spettatori si sovrapponevano: l’uomo per conoscere il principio deve entrare in se stesso, in quel luogo-non luogo nel quale alberga l’origine: «sia per superare l’escatologia […] sia per ritrovarsi in un’apertura completa di significati» (p. 5). Di fronte alla provenienza dal nulla-di-ente e al ritorno a esso, nel “lento movimento dei ghiacci” della vita, l’artista non cede alla disperazione ma, guardando al misterium custodito dalla physis, si insinua in esso facendosene custode. Gli enti di natura, gli atti aristotelici, altro non sono se non ciò in cui l’uno, la dynamis, possibilità-potenza-libertà, pare momentaneamente acquietarsi. Allo stesso modo, le opere dell’artista sono mero excrementum che trascrive un’origine mai normabile che, con l’ex-sistere, dà anche, in esso, la morte. In ciò è da ravvisarsi il tratto aporetico della vita e la dimensione iconoclasta propria dell’arte, «tomba scoperta» (p. 5), sepolcro testimoniante l’eterna resurrezione della Fenice dalle sue ceneri, dai suoi lacerti (lo intese perfettamente il filosofo Andrea Emo). Manzoni ci affida, di là da qualsivoglia consolazione, al «lato più netto, più duro […] enunciazione costante di uno stato» (p. 6), del poietico. Gian Ruggero sfiducia il concetto senza servirsi di concetti, lo fa, di contro, in modalità lieve, poetica.
- ...
- Leggere le sue pagine, per chi, come chi scrive, ha dichiarato guerra al logo-centrismo servendosi dei suoi logori strumenti, quelli dell’armamentario filosofico-concettuale, è stata davvero un’ esperienza liberante, ri-velativa. Ci ha fatto comprendere quanto si debba lavorare sulla dura scorza dell’Io per far emergere il Sé, al fine di vivere in sintonia con la “forza” che anima le cose. La mia è confessione di un sentimento ignobile, che pensavo di essermi lasciato alle spalle, quello dell’invidia. Si, invidio Manzoni perché il suo dire custodisce il non-detto della Parola, il Silenzio da cui essa sorge, cui ogni parola, di fatto, prova ad alludere. Il senso ultimo della vita, appesa alla libertà nel movimento gratuito e insensato, tragico, del tutto, è ben espresso dalla musica: «il miglior mezzo per sopportare lo scorrere del tempo, per dirsi nella sincerità, per non barare» (p. 13). La musica dice tempo ed eternità esser il medesimo nell’attimo immenso. Nel verbo“sopportare” sta l’insegnamento più profondo che Manzoni lascia al lettore. Con Leopardi, egli ha contezza che l’arte è experimentum che, riproponendo l’effimero ma meravigliante bagliore del principio, ci consente di “ben sopportare” in modalità “euforica” (euphero) gli inciampi dell’esistenza, non ultime malattie e morte. L’artista sperimenta che, chi si sia posto sulla Via dell’assoluto, dovrà pascersi di solitudine e dolore. L’arte è solo uno dei strumenti atti a “scaldare” tale glaciale solitudine. Un’arte magica e sciamanica, come quella professata, alle più diverse latitudini e in epoche disparate, dagli “uomini di medicina”. Capaci, in sogno e nella trance, di parlare con: «l’anima delle cose» (p. 17), oltre la loro effimera forma-figura. Tutto è in tutto, la natura per l’artista-sciamano, è mixis. Il suo agire s-detrmina le cose dall’ossificazione cadaverica-concettuale, le libera.
- ...
- Lo mostrano, in tutta evidenza gli “Sciamani” ritratti nel secondo capitolo. Figure contratte, stilizzate in pochi tocchi di lapis, dai quali si evince in qual modo l’universale sia custodito solo dal particolare. Figure dinamiche, sempre oltre se stesse, tese, come nell’arte dei nomadi dell’Asia centrale, a porre in forma, in modalità transitoria, quali inflorescenze destinate a svanire, l’origine inarrestabile, sempre in fieri.
- ...
- Le figure sciamaniche di Manzoni ci hanno fatto ri-cordare (riportare al cuore, al Centro) un libro di “medaglioni grafici” di un altro figlio di Romagna, Leo Longanesi. Ci riferiamo allo straordinario volume longanesiano “Una Vita”, che molto ci intrigò nella nostra adolescenza imberbe. I luoghi ci segnano, ci formano. Il dire di Gian Ruggero è umbratile, padano. Paradigma di tale letteratura è da rinvenirsi nelle Bucoliche e nelle Georgiche di Virgilio. La penna di Manzoni fa irrompere tra il filari di pioppi, nelle trasparenze dei cieli hiemali, tra le nebbie della grande pianura, la Quarta Moira, il Nulla di ente, il ni-ente, di cui disse, assieme a un’eletta schiera pensante, Meister Eckhart. La Quarta Moira è il vero protagonista delle pagine di, Nel lento divenire dei ghiacci: un Nulla volitivamente accettato, che non indulge in alcun contemptus mundi!
- ...
- Al contrario, spinge a vivere “intensamente” e, soprattutto, insegna la “rinuncia”. Lo mostra l’ultimo capitolo, appassionato e coinvolgente, dedicato alla recente scomparsa della madre dell’autore. La donna, animata da una fede carnale e sanguigna, retaggio della civiltà contadina, “scelse” il momento di lasciare questo mondo: «in quel totale…ma pur magnifico…disperdersi del certo […] quale esaltante, e di nuovo barbara, sparizione» (p. 96). La Quarta Moira dice vita e morte essere il medesimo: misterium vitae. Per questo, il dire di Manzoni è atto di parresia, parola di verità per quanti oggi abbiamo contezza di “pensare dalla fine”.
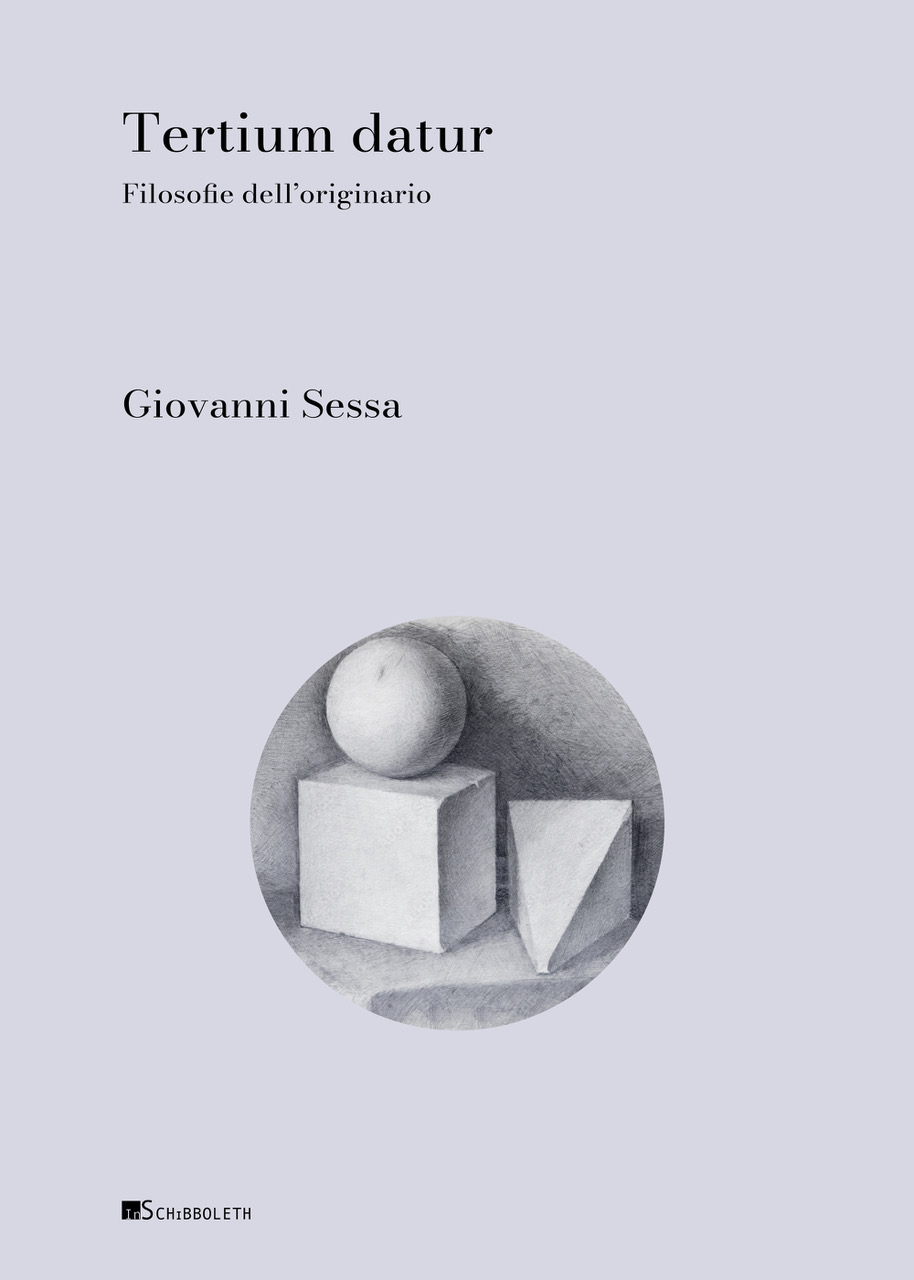
Tertium datur- Filosofie dell’originario
- Un saggio filosofico di
- Giovanni Sessa
- rec. di
- Giacomo Rossi
- Abbiamo letto un libro importante di Giovanni Sessa, Tertium datur. Filosofie dell’originario, comparso nel catalogo di InSchibboleth (per ordini: info@inschibbolethedizioni.com, pp. 389, euro 28,00). Nelle sue pagine, l’autore porta a conclusione un iter intellettuale al centro del quale sta il lógos physikós, la natura dei Greci in cui “tutto è in tutto”. Si tratta di un esperimento teoretico “originale” (rinviante all’“origine”), connotato da estrema radicalità, che si propone quale uscita di sicurezza dalla attuale condizione teorico-pratica. L’autore, come ricorda nella prefazione il filosofo Romano Gasparotti, è cosciente di “pensare dalla fine” (l’espressione è mutuata da Alain Badiou e Giovanbattista Tusa) della filosofia e della civiltà europea e ha contezza che il lógos physikós debba tradursi in prassi di vita, atta a mostrare l’inanità dei dualismi propri della onto-teologia. Sessa è convinto, scrive il prefatore: «che la traboccante vitalità del cogitare, nei caratteri evocati dalla Settima lettera platonica […] non coincide affatto con il raziocinare astrattamente logocentrico». Vi è, comunque, una possibilità di uscita dallo stato presente delle cose, al di là di ogni astratto volontarismo e di qualsivoglia umanesimo di ritorno. Affinché tale possibile si attualizzi, sostiene Gasparotti con Sessa, è necessario: «aggirare gli schemi metafisico-modernisti di negazione, alternativa, superamento, essendo questi i patterns secondo i quali agisce l’acefala, anonima […] macchinazione» del Ge-stell.
- ...
- Sessa fa propria l’esegesi transpolitica della storia che fu propria di Del Noce e Severino, alla luce della quale il moderno è l’esito ultimo della metafisica. Scienza e metafisica, condividendo i medesimi presupposti teoretici, hanno obliato il principio greco di hyle, materia-animata, introducendo le distinzioni di essenza-esistenza, essere-nulla, uno-molti, dando luogo a una visione nella quale la dynamis, libertà-possibilità-potenza sempre all’opera, è stata tacitata. L’autore ripercorre la storia di tale sterilizzazione, condividendo le posizioni che Davide Ragnolini ha presentato in, Hyle. Breve storia della materia increata (Rubbettino, 2023). Analizza, inoltre, alla luce delle bibliografia critica più accreditata, il saggio di Del Noce, Il problema dell’ateismo, ritenendo che, al di là delle due “vie” individuate dal pensatore cattolico (quella immanentista che con Hegel, Marx e Nietzsche, avrebbe inaugurato l’epoca della secolarizzazione, e quella giobertiano-rosminiana del recupero della metafisica), ne esista una terza, tertium datur, centrata sul primato della potenza e del possibile, sulla coincidentia oppositorum (mai da intendersi quale nuova sintesi positiva!) e sulla piena accettazione della singolarità.
- ...
- Una via carsica della filosofia europea, emersa in piena Rinascenza, testimoniata dal pensiero e dalla vita di Niccolò Cusano, di Giordano Bruno, dalla mistica di Jakob Böhme e Franz von Baader, le cui tesi risuonarono in alcuni assunti dell’idealismo tedesco.
- ...
- In Tertium datur viene rintracciato dall’autore un canone minore del pensiero europeo, diverso, ma altrettanto prezioso di quello rinvenuto da Rocco Ronchi. A proposito di Cusano, Sessa nota: «il (suo) mondo si configura come realtà, che, partecipando della potenza, anzi, essendone sola espressione, è sempre all’opera […] non staticizzabile dal lavoro del concetto». Al filosofo di Kues, guardò, nel suo coerente panteismo, Bruno. Nelle opere del Nolano, la cui esegesi è condotta in modalità organica e con pertinenza di accenti, tornò a mostrarsi nella “vicissitudine” della physis, la hyle ellenica che fece sentire la propria voce anche nella teosofia di Jacob Böhme. Il tedesco pensò la hyle quale seme, germe cosmico, vivo nella coincidenza dei contrari. Le opere del teosofo, in primis Aurora: «realizzano il tentativo di sospensione ed effrazione delle valenze locutoriamente semantico-simbolico-discorsive del linguaggio», in quanto esse: «non possono affatto restituire la sorgività e l’immediatezza assoluta» del principio e: «finiscono per estraniare il lettore da un’intima e interattiva compartecipazione con il pragma cogitante […] L’experimentum del ciabattino-teosofo […] è quello dell’esercizio di un linguaggio eminentemente metaforico-immaginale». Baader, in sequela di tale tesi: «Alla fondazione del soggetto moderno, contrappone la distillazione alchemica del Sé». Tra gli idealisti, Fichte portò alla luce la negazione originaria, la dynamis-principio e a tale acquisizione teorica si mantenne fedele Schelling nella Filosofia della libertà oltre che nel momento teosofico del suo sistema. Hegel, al contrario, tradurrà dialetticamente tale negazione in un nuovo positivo. Quello hegeliano è, di fatto, un ermetismo imperfetto, deviato, in quanto ancora impigliato nel soggettivismo razionalistico di ascendenza cartesiana. Fu, al contrario, il pensiero-poetante di Friedrich Hölderlin, a salvare, in quel frangente storico, la visione tragica ellenica.
- ...
- La dynamis, rileva Sessa, ha acquisito ruolo dirimente nelle filosofie ultrattualiste del Novecento italiano, nella linea speculativa Evola-Emo-Diano. Di Evola, l’autore riprende i motivi dell’idealismo magico e dell’individuo assoluto; di Emo quelli del ciclo del continuo rigenerarsi e sacrificarsi dell’iconoclastia e dell’autonegatività di Dio, individuando nell’irresistibilità dell’irrompere dell’Impossibile l’elemento cruciale di collegamento tra loro. Per quanto concerne il pensiero di Carlo Diano – nel quale si intrecciano la lunga meditazione su Leopardi poeta e la lezione filosofica di Gentile – nota Gasparotti, l’autore: «indugia sul nesso originario tra evento e forma, nell’articolarsi del quale […] l’Evento non si lascia mai catturare interamente dalla forma, nella misura in cui esso […] rende possibile il relazionarsi stesso […] di forma eventica e forma eidetica».
- ...
- Il ritorno del “pensare greco” è, inoltre, espresso dall’esperienza sapienziale di Giorgio Colli, cui Sessa dedica un capitolo denso e ricco di suggestioni teoriche. Nel grande antichista, nella sua esegesi di Empedocle, la visione dell’Uno-Tutto ha trovato testimonianza d’eccezione.
- ...
- Nel libro viene colta la crucialità del “pensiero italiano”. Lo mostra il capitolo imperniato sulla filosofia ritmica e singolare di Massimo Donà, le cui opere sono attraversate e discusse con evidente empatia dall’autore. Donà ha sostenuto la necessità di tornare a coniugare theorein e poiein ed ha insegnato come l’aporia implicita nella vita, possa essere “sopportata” serenamente, in una prassi inconclusa aperta all’incipit vita nova.
- ...
- Libro articolato, complesso, Tertium datur di Sessa. Il dato teorico che lega i diversi plessi è il seguente: per il lógos physikós uno e molti dicono il medesimo, Geist e Leib si danno in uno, senza rinviare ad alcun altrove. La nostra lettura è parziale, abbiamo presentato solo alcuni aspetti del volume. Non possiamo che concludere con questa considerazione del prefatore: «È veramente una gioia per il pensare poter leggere e potersi confrontare con libri come questo, i quali sono preziosamente rari».
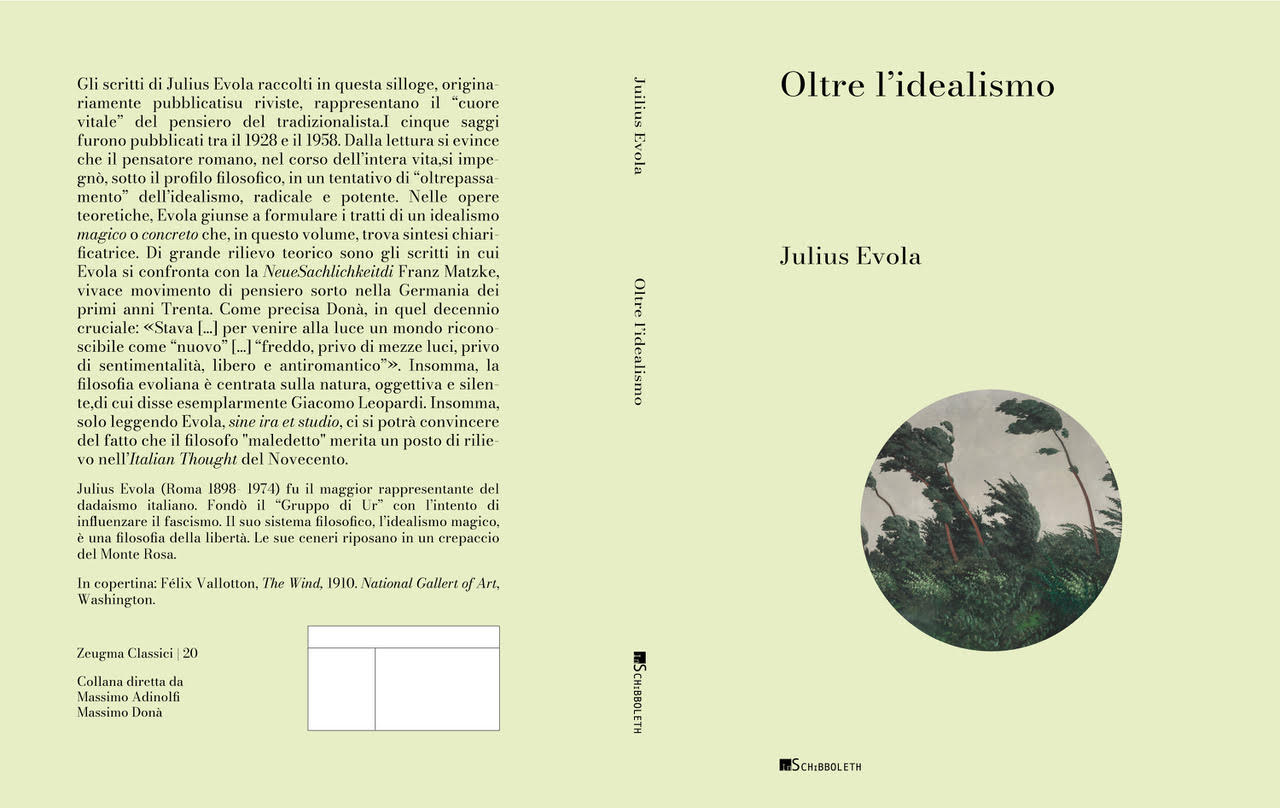
Oltre l’Idealismo- Una silloge di scritti evoliani
- curati da Massimo Donà e Giovanni Sessa
- rec. di
- Giacomo Rossi
- È nelle librerie per i tipi di InSchibboleth Edizioni una raccolta di cinque saggi di Julius Evola intitolata, Oltre l’Idealismo. Il volume è impreziosito dalla prefazione del filosofo Massimo Donà e dalla postfazione di Giovanni Sessa, curatori del testo (per ordini: info@inschibbolethedizioni.com, pp. 140, euro….). Gli scritti di Evola raccolti in queste pagine sono: 1) Superamento del Romanticismo; 2) Neue Sachlichkeit. Una confessione delle nuove generazioni tedesche; 3) Sorpassamento dell’Idealismo; 4) Superamento dell’Idealismo; 5) Nuova Essenzialità, neorealismo e realismo socialista. Il primo scritto fu pubblicato nel 1928, mentre il secondo, il terzo e il quarto uscirono tra il 1933 e il febbraio del 1935, solo l’ultimo fu pubblicato nel dopoguerra, più precisamente nel 1958. Tutti i testi, comparsi in origine su riviste, sono di contenuto filosofico e, per comprenderli appieno è bene ricordare quanto, in relazione all’iter intellettuale di Evola negli anni Trenta del secolo scorso, ebbe a scrivere Marco Iacona, accorto studioso di cose evoliane: «Evola negli anni Trenta (i defeliciani anni del “consenso”) desidera cambiare passo, desidera che il “mondo” cambi passo, vuole quel di più che la cultura fascista non gli offre, quel quid goethiano, che consenta alle sue idee […] di affermarsi».
- ...
- Per comprendere senso e significato dell’idealismo magico è necessario, come seppe Gian Franco Lami, attento esegeta della filosofia evoliana, far riferimento alla “Nuova Oggettività”. Nei due scritti della silloge dedicati alla discussione del volume scritto in tema dal ventisettenne Franz Matzke all’inizio del terzo decennio del Novecento, Evola dichiara guerra aperta a qualsivoglia umanesimo, all’antropocentrismo, ritenuti responsabili della catastrofe cui la civiltà europea era andata incontro al termine del Primo conflitto mondiale. Bisognava, di contro, riscoprire il tratto “indifferente” della natura che non è affatto natura “per noi”, a disposizione dell’uomo e dell’Impianto della tecno-scienza. Il movimento tedesco della “Nuova Oggettivà”, in un ritorno “alle cose” ben più radicale di quello pensato dalla fenomenologia husserliana, stava rivelando: «un mondo algido; illuminato da un sole meridiano» (p. 10), chiosa Donà. Prosegue, in tema, il filosofo veneziano: «Ormai si era compreso che bisognava andare incontro alle cose, in tutta la loro freddezza e durezza facendo tacere l’anima» (p. 12). Il pensiero di Evola è qui attraversato da una chiara ripresa di motivi leopardiani. Il grande recanatese, fu latore (si pensi al, Dialogo della Natura e di un islandese) di un pensiero-poetante recuperante il tragico emerso nell’esperienza speculativa della Grecia aurorale e che, in quel frangente storico, faceva mostra di sé, lo ricorda lo stesso Donà, nella pittura “metafisica” di De Chirico.
- ...
- In questa nuova visione della natura e delle cose, nella quale l’Io è implicato, al di là della dicotomia soggetto-oggetto indotta dal momento della rappresentazione, sarà possibile anche agli uomini conoscere e vivere in modalità assoluta, posti in faccia a un reale: «costitutivamente inviolabile e del tutto indifferente ai nostri miseri e insignificanti bisogni» (p. 15). In tale natura indifferente, nella quale si può davvero sapere ermeticamente, oltre il pathos soggettivo romantico, che “Tutto è in Tutto”, l’uomo ri-scopre il proprio essere assoluto, sciolto, svincolato, s-determinato, nient’affatto mero “atto” aristotelico. Si ha, così, la possibilità di comprendere che, ab initio, nei molti e solo in essi, si dice l’uno. Questi non vive in un altrove, ma in tutto ciò che è. La natura è animata dalla dynamis, libertà-potenza, di cui i singoli “atti”, gli enti, non sono che momentanea, flebile, meravigliante e tragica espressione. Quella cui Evola guarda è la lingua muta delle cose, della quale disse von Hofmannsthal. Lo si evince nei saggi di Evola dedicati, in questo volume, al superamento dell’idealismo.
- ...
- In queste pagine, sintetiche e illuminanti, il pensatore rileva, lo nota Sessa, che: «La forma ultima ed estrema dell’idealismo, l’attualismo gentiliano, aveva – con la teoria dell’Atto puro – finito per riproporre i dualismi connotanti di sé le filosofie precedenti: soggetto-oggetto, essenza ed esistenza, essere e nulla. Gentile, con l’Io trascendentale, statuiva, al pari dei suoi predecessori, l’impotenza dell’io empirico nei confronti del reale» (p. 114). Si trattava, pertanto, di trasformare la tesi idealista da meramente gnoseologica, in verità affermativa, di potenza. Insomma, l’individuo per vivere e non semplicemente pensare la propria assolutezza avrebbe dovuto sintonizzarsi sul principio-dynamis, aprirsi al suo perpetuo incipit vita nova, farsi sempre nuovo, ogni volta da capo, in un percorso aporetico, iperbolico e inconcluso. L’individuo assoluto è per Evola il poietes, produttore di: «Un tipo di arte anti-medianica, anti-universalista, incentrata nel valore secco e volitivo dell’Io» (p. 44). Tale arte, a dire del filosofo, ha trovato chiara espressione, lo rilevano sia Sessa che Donà, nel Jazz: «Il ritmo jazzistico ha tratto menadico, elementare: “diremmo quasi di minerale, qualcosa che, come la Dance de la Terre […] di Strawinsky, sa di terra, di forze elementari, sa di una pura intensività scatenata e pur trattenuta ad ogni tempo dai sincopati, per una esasperazione che impone il liberarsi, il muoversi, l’agire”. Il Jazz mette in scena la forza pura» (p. 119).
- ...
- Insomma, la realtà aperta dall’ idealismo magico e dalla “Nuova Oggettività” non era da considerarsi aumana in quanto “non ancora umana”, ma in quanto “non più umana”, svincolata, come detto, dalle proiezioni culturali con le quali il soggetto, umanisticamente e romanticamente inteso, aveva segnato di sé la vita e le cose del mondo. Oltre l’Idealismo è, quindi, testimonianza di rilievo della grandezza della filosofia evoliana, ma anche della produzione artistica del pensatore, connessa, in modalità evidente, alla prima. I saggi di Evola sono stati letti dai curatori in modalità oggettiva, oltre il pregiudizio politico che grava ancora sul filosofo e la mera volontà di esaltazione agiografica propria degli “evolomani”. Una ragione ulteriore per leggere questo significativo volume.
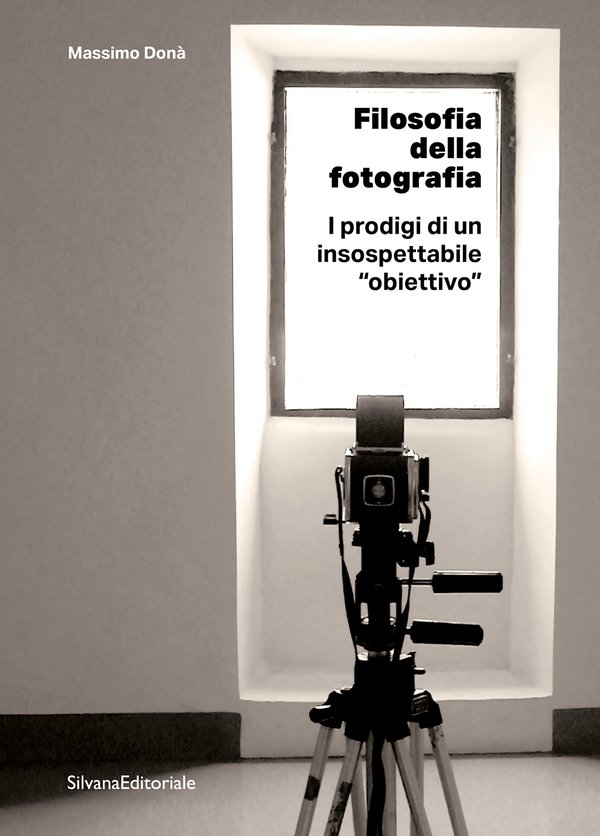
Filosofia della fotografia- Un saggio di
- Massimo Donà
- rec. di
- Giovanni Sessa
- È nelle librerie, per i tipi di Silvana Editoriale, un volume di Massimo Donà, Filosofia della fotografia. I prodigi di un insospettabile “obiettivo” (pp. 93, euro 18,00). Il libro è arricchito dalla prefazione di Italo Zannier, fotografo di vaglia e storico della fotografia. Le pagine di Donà, mirate a disvelare senso e significato del fotografare, muovono da questa definizione di Zannier: «la fotografia può essere intesa come una tecnica che consente di ottenere immagini figurative di porzioni della realtà, ma […] non necessariamente percepibili dal nostro occhio, mediante gli effetti provocati dalla luce […] su alcune sostanze sensibili» (p. 48). L’argomentare del pensatore veneziano è sostenuto da una non comune conoscenza della letteratura critica in argomento. Egli attraversa e discute, con pertinenza argomentativa e persuasività di accenti, non solo gli aspetti teoretici implicati nell’arte fotografica ma anche, con minuzia di particolari, la sua storia, discussa in relazione ai momenti salienti della rivoluzione tecnico-scientifica e intellettuale della congerie storica nella quale la “scrittura di luce” fece la sua prima, timida, comparsa (in particolare nel capitolo, Verso l’invisibile).
- ...
- Se la fotografia è arte che ha avuto nel Novecento il proprio momento saliente, rileva Donà, essa ha a che fare, come le altre arti del “secolo breve”, con una storia millenaria e, in particolare, con il problema rappresentato dall’irruzione del cristianesimo nella cultura europea. La nostra civiltà è stata l’esito dell’incontro tra il rigido monoteismo ebraico con: «il variegato e popolatissimo Olimpo della cultura greca» (p. 30). Mentre il giudaismo negava la rappresentabilità del divino, la grecità, di contro, è stata attraversata da una polifonia del sacro sostanziata di immagini divine. In tale iter, il dogma trinitario cristiano avrebbe rappresentato una paradossale novità, atta a dire in uno la semplicità: «dell’unico principio quanto la variegata polimorficità di una realtà dai mille volti» (p. 33). Il trinitarismo induceva a pensare tanto la non-raffigurabilità del divino, quanto il suo essere raffigurabile. L’immagine divenne, pertanto, “soglia” che conduceva a un’ulteriorità insondabile, come attestato dalla teologia dell’icona di Florenskij: «l’immagine sarebbe stata ritenuta vera solo nella misura in cui si fosse dimostrata capace di custodire la perfetta invisibilità di quel che essa medesima mai si sarebbe azzardata a mostrare» (p. 34). Il cristianesimo è stato, nel medesimo tempo, iconoclasta e iconofilo.
- ...
- “Immaginare” significa ritagliare una “parte”, istituire la sua determinatezza ma, al contempo, tale “immaginare” rinvia a un’azione di custodia, al suo evocare il “tutto” come, a sua volta, “determinato”. Ciò vuol dire che, immaginando, istituiamo l’indeterminatezza della parte nel suo essere relata al “tutto” in quanto, oltre la parte: «vi è sempre e solamente un’altra parte […] diversa da quella caratterizzante la parte che dovessimo aver preso in considerazione» (p. 37). Insomma, nota Donà, la parte non è mai altra né dal tutto assoluto, né dal tutto parziale, essa non: «si “determinerà” mai […] come distinta dal tutto» (p. 38). Tale situazione è paradigmaticamente testimoniata dalla fotografia. I fotogrammi non saranno mai vita in toto, ma la vita in essi: «sarà comunque venuta ad immaginarsi» (p. 39). Il fotografo fissa una “permanenza” di fatto in-esistente, nell’unica immagine possibile che il divenire della vita si concede. La foto, nella sua immobilità, è “parte” della vita non rinviante a un altrove, a un “fuori” dalla vita stessa, a un’idea quale universale capace di spiegare le singolarità del mondo. Il fotogramma espone a un’altra dimensione della vita che si agita, invisibile, in tutto ciò che è, non rinviando né al passato né al futuro, ma alla vita nuda, tragica e ammaliante. Il fotogramma nella sua positività, nella sua incontestabile datità empirica, dice ciò che in ogni positum palpita, dice il non, la negatività dell’origine alla quale siamo appesi.
- ...
- La fotografia fa comprendere che le cose non sono mai quel che “dicono” di essere: «riuscendo a far emergere quello che le persone e le cose in ogni tempo possono essere state, di là da quello che avrebbero voluto essere» (p. 43). La fotografia è latrice di una visione antiuniversalista, non legata ai desiderata del soggetto, registra la voce muta degli uomini, delle cose, della natura. Con Barthes, rileva Donà, è possibile asserire che essa metta in atto: «un’astuta dissociazione della coscienza» (p. 45), disvelante l’istante, nel quale l’immobile non sta al di là del mobile. La “scrittura di luce” fissa l’attimo per mostrare ciò che, ogni reale, pare non voler far trasparire da sé: il medesimo, il “permanente” che lo anima, il “non”: «che nel presente, è sempre o già passato o ancora futuro, il “non” che non c’è mai» (p. 54). Un attimo inafferrabile tanto per il nous quanto per i sensi. L’arte fotografica, come qualsivoglia arte autentica, s-determina gli enti dalla cosalità che pur li costituisce e coglie: «il distinguersi del non-distinto» (p. 59).
- ...
- Il mistero della fotografia è strettamente connesso al misterium vitae, ha a che fare con il sogno di una possibile eternità (aion) che non è altra dal tempo, ma che si dà nel kairos. La macchina fotografica è strumento magico che sottrae, fotografo e fruitore, alle logiche della significazione concettuale e distinguente: le immagini che essa produce sono foto-fanìe (l’espressione è di Zannier), che alludono e accompagnano verso l’invisibile fantasma della vita. Ciò che realmente desideriamo, ben lo seppe Leopardi, non è una “determinatezza”, aneliamo l’infinito. Ci disperiamo, come Narciso che non riuscì, secondo il mito, a possedere la sua immagine riflessa nello specchio d’acqua, perché non sappiamo che quell’infinito non è un altro, è in noi. Siamo divini ab origine. La fotografia insegna a non sperare e a non disperare, a uscire dagli steccati logici e finalistici istituiti dal soggetto. I fotogrammi, nel loro significato profondo, alludono all’aporia della vita: inducono, pertanto, a vivere in dimensione “euforica”, consentono, quantomeno, come le altre produzioni artistiche, di “ben sopportare” il gioco caleidoscopico nel quale siamo avviluppati. Non è poca cosa…
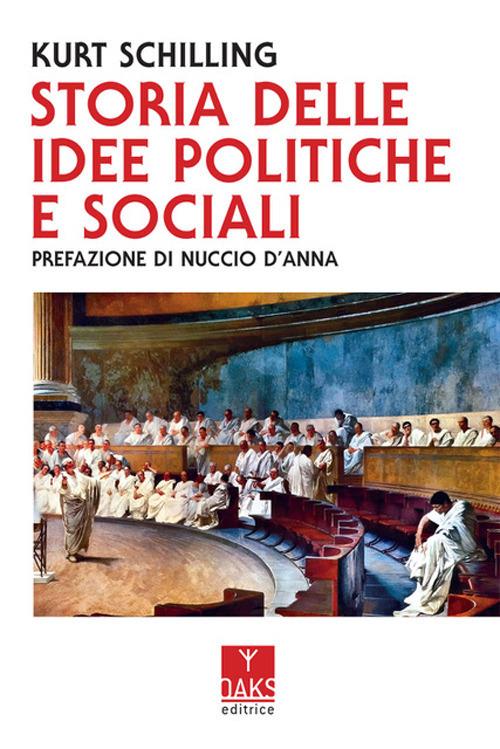
Storia delle idee politiche e sociali- Un saggio di
- Kurt Schilling
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Kurt Schilling è stato, a muovere dalla fine degli anni Venti del secolo scorso, studioso e accademico tedesco che godette di notorietà internazionale. I suoi interessi, vastissimi e pluridisciplinari, spaziavano dalla filosofia aristotelica a quella hegeliana ed ebbero il loro nucleo vitale nella discussone critica dell’idea di Stato. Tra il 1939 e il 1941 fu docente all’Università di Praga. Assunse, nel 1939, la Direzione dell’Ufficio per l’insegnamento e la ricerca dell’Ahnenerbe. Nonostante ciò, al termine del Secondo conflitto, in forza degli indubbi meriti scientifici del suo lavoro, tornò ad insegnare a Monaco di Baviera, sua città natale (1899). Si spense in un paesino delle Alpi bavaresi, dove si era recato in cerca di silenzio e pace, nel 1977. È nelle librerie, per i tipi di Oaks editrice, la sua opera capitale, Storia delle idee politiche e sociali, ottimamente prefata da Nuccio D’Anna (per ordini: info@oakseditrice.it, pp. 396, euro 25,00).
- ...
- L’impianto teorico del volume mostra l’adesione dello studioso alla sociologia di Tönnies, secondo la quale l’aggregazione sociale comunitaria sarebbe altro da quella societaria. La prima si fonda su un corpo sociale ordinato sulla base di vincoli originari e solidi, che danno luogo a una configurazione unitaria, organica e gerarchia. La “società”, di contro, è corpo sociale strutturato sulla fluidità e i vincoli che, in essa, legano tra loro gli uomini hanno tratto utilitaristico e instabile. La “società” è regno dell’atomismo sociale. Muovendo da tale premessa generale, Schilling, nell’incipit delle proprie analisi, si intrattiene sui gruppi umani del paleolitico, primo esempio di “comunità”: «Attorno al capo-sciamano si ordinava tutto un organismo che […] trovava nelle caverne riccamente pitturate […] il luogo ideale per i complessi rituali che intendevano trasfigurare l’esistenza in un riflesso dell’ordine divino», rileva D’Anna.
- ...
- Momento dirimente dell’esegesi dello studioso tedesco è da individuarsi nel paragrafo dedicato alla discussione delle idee politiche dell’antica Cina. Se la storia arcaica cinese era stata dominata dal sacerdote-sciamano, a muovere dalla dinastia Shang l’Imperatore divenne il centro della vita del popolo. L’idea di Stato che, in tal modo, si afferma: «per la sua essenza è cosmica [...] nata dal legame con la natura […] che ha le proprie radici nell’agricoltura, nella venerazione degli antenati e nell’osservazione del cielo».
- ...
- In India, il riferimento alla tradizione sacrale delle origini rappresentò il vero legame che seppe unificare una realtà linguistica ed etnica assai composita. L’indagine di Schilling, attenta al lascito socio-politico di tale civiltà, perde di vista il ruolo essenziale che in essa svolse l’afflato al divino, animante tanto gli appartenenti alle caste “alte”, quanto i rappresentanti delle ultime. Di maggior rilievo teorico, oltre che filologicamente più corretta, è la lettura della pólis ellenica. In essa, la libertà fu non semplicemente modus essendi dei singoli cittadini, ma portato della stessa vita politica. Il nostro Autore individua nell’irruzione della sofistica l’inizio della decadenza greca. A essa rispose, in modalità forte Platone che, sostiene il tedesco, fece dell’ordine politico della Politéia il risultato del “cambio di cuore” dei cittadini. Questi, in forza di un’opportuna paideia, avrebbero potuto far fronte al nósos, malattia esistenziale-spirituale dell’epoca, recuperando il perduto ordine interiore. L’esegesi del cristianesimo, ci permettiamo di rilevare, assume in Schilling, valenza tradizionale. Agostino nel De civitate Dei avvertì l’urgenza, in quel frangente storico di passaggio, di: «instaurare una nuova “forma” politica che doveva sostituire le vestigia svuotate del vecchio Impero».
- ...
- In tale processo di cristianizzazione della romanità, altro momento dirimente è rappresentato dall’incoronazione di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero armonizzò l’ordinamento giuridico romano, germanico e cristiano, dando vita a un corpo statuale fortemente impregnato di riferimenti religiosi e sacrali: «Con l’idea del Cristo-Re si colma l’abisso tra l’aldiqua e l’aldilà», l’Impero fu vera e propria “religione regale”, della quale Melkitsedek è simbolo. Con il luteranesimo ma, soprattutto, con il calvinismo, tale ordine si dissolse. Schilling, in sequela di un numero considerevole di autori, considera il protestantesimo calvinista, che fece del successo terreno segno tangibile d’elezione divina, anima del capitalismo. Sulla sua scorta, tra i secoli XVI e XVIII, molti filosofi pensarono in termini utopistici, costruirono a tavolino società immaginarie improbabili, mentre Bodin e Machiavelli elaborarono una “quasi-dottrina” dell’assolutismo, nel tentativo di dare stabilità all’ordine politico-sociale. Inoltre, il liberalismo “riformatore” di Locke e Montesquieu, presto sarebbero stato travolto dal radicalismo rivoluzionario del 1789.
- ...
- L’anima giacobina di quest’ultimo fu incubatrice dei tentativi di correzione del capitalismo perpetrati dapprima dal “socialismo utopistico” e poi da quello “scientifico-marxista”, tentativi che, in realtà, condividevano con il capitalismo il medesimo orizzonte di pensiero immanentista e materialista. Nietzsche, sostiene Schilling, fu profeta dell’età del nichilismo dispiegato, pur ritenendo ancora possibile una correzione dei processi storici in corso nella seconda metà del secolo XIX. Le tesi espresse in, Storia delle idee politiche e sociali, sono certamente interessanti. Almeno su alcune di esse è però possibile dissentire. La sofistica, ad esempio, non fu semplicemente latrice di una visione sovversiva dei valori tradizionali: al contrario, molte sue posizioni rinviano, al di là delle esegesi scolastiche, alla chiara volontà di preservare il misterium vitae. Ancora, le posizioni degli “utopisti” rinascimentali sono molto diverse tra loro, Moro e Bacone non dicono affatto il medesimo. L’ “ironia” del primo ha a che fare con l’"utopia" classica, non con l’"utopismo" modernamente inteso. Siamo, da ultimo, così certi che il Sacro Romano Impero sia stato davvero, per così dire, “custode del Graal”? Non sopravvivevano forse altrettante eredità tradizionali a Bisanzio? I nostri dubbi non fanno che confermare l’importanza del volume. Un libro è valido quando fa pensare e discutere.
- DEMOCRAZIE APERTE O CHIUSE?
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Occorre dedicare attenzione, a seguito del noto rapporto dei servizi segreti tedeschi sull’affidabilità democratica e ai principi dello Stato di diritto dell’AFD; partito il quale, a leggere i sondaggi, sarebbe ormai quello primo nel consenso degli elettori tedeschi.
- ...
- La Costituzione tedesca (Grundgesetz) all’art. 21, II comma, dispone che sull’incostituzionalità dei partiti decide la Corte Costituzionale, La norma è assai ampia e suscettibile di applicazioni altrettanto late; a tale riguardo è stato sostenuto che quella tedesca sia una democrazia protetta, mentre altri testi costituzionali – come quello italiano – segnatamente con l’art. 49 e la XII disposizione transitoria siano democrazie aperte. In effetti in quella italiana, manca l’indicazione di chi giudica sulla costituzionalità, e il dettato normativo è assai più ristretto. La ragione storica di ciò è spesso ricondotta alla fine della costituzione della Repubblica di Weimar – e al dibattito sviluppatosi anche tra i più eminenti giuristi, in particolare Carl Schmitt e Hans Kelsen – sul più ampio problema di chi dovesse essere il “custode della Costituzione”.
- ...
- La costituzione di Weimar fu “abolita” di fatto, approvando la legge “sui pieni poteri” del marzo 1933 con un voto del Reichstag che rispettava la norma (costituzionale) della maggioranza qualificata, indipendentemente da ogni valutazione del contrasto tra i principi e la forma della repubblica e quelli della “modifica” costituzionale approvata che ne erano la negazione. E’ palese che la costituzionalità dei partiti e di chi li debba giudicare è un aspetto particolare di una tematica che interessa i principali istituti (e concetti) dello Stato moderno: dalla sovranità al potere costituente, dalla democrazia al principio dell’art. 28 della dichiarazione dei diritti dal 1793 (detta giacobina) per cui ogni generazione ha il diritto di modificare e cambiare la propria costituzione. A tal fine occorre che non si frappongano ostacoli, tenuto conto del pensiero di Pareto, alla circolazione delle élite. E considerando anche, come scriveva Hauriou, che l’ordinamento giuridico è sempre in movimento, vuoi per il cambiare delle situazioni come per quello delle opinioni e, anche per questo, il giurista francese riteneva il sistema di Kelsen “statico” (e di conseguenza poco realistico).
- ...
- E’ tutt’altro che semplice risolvere le opposizioni concettuali e, quel che più conta, reali (e le loro conseguenze) che si pongono. La sovranità e non meno il potere costituente sono degli assoluti rispetto alla normativa: e farne dei poteri relativi (cioè limitati) li si nega. La democrazia implica opinioni diverse e per tutti i cittadini uguaglianza di chances nell’accesso al potere; ma se è la Corte costituzionale a decidere cosa bisogna pensare e credere per accedervi, la democrazia se non abolita, ne risulta gravemente azzoppata. Se una comunità vitale è connotata dalla circolazione delle élite, decidere chi possa aspirare (e ottenere) il comando e chi no significa un ordinamento a ZTL, che è poi quello più connaturale al modo di pensare delle élite decadenti, soprattutto in Italia.
- ...
- D’altra parte occorre riconoscre che ammettere élite incostituzionali nello spazio pubblico, con la conseguente possibile abolizione totale della costituzione è una contraddizione. Tuttavia è un fatto costantemente ripetutosi nella storia, anzi sotto tale angolo visuale, del tutto normale: la teoria ciclica delle forme politiche lo presupponeva, anzi era la la puntuale rappresentazione di come le opere umane siano transeunti. E le transizioni, come scriveva Spinoza, non sono mai pacifiche e legali. Cercare di renderle tali è opera meritoria, ma l’esperienza prova che è assai difficile. Anche perché norme del genere, animate da buone intenzioni, possono essere utilizzate dalle élite decadenti per impedire l’accesso alle nuove. Specie all’ombra della legalità. Non aveva torto Machiavelli che, nel chiedersi se in una repubblica facessero più danno quelli che vogliono acquistare il potere o quelli che cercano di non perderlo, riteneva che provocassero più tumulti i secondi “il più delle volte sono causati da chi possiede, perché la paura del perdere genera in loro le medesime voglie che sono in quelli che desiderano acquistare” (D, I, V) e, come sempre, non aveva torto.
- IL LUPO E IL CHIODO
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Quanto è accaduto la scorsa settimana tra Germania e Romania, mi ha ricordato un manifesto dei repubblicani francesi dopo la caduta del Secondo impero, quando la Francia doveva ri-decidere se essere una Repubblica o una monarchia. Nel manifesto si vedeva un chiodo con la testa di Marianna (simbolo della Repubblica) piantata nella Francia con sopra un martello che la batteva.
- ...
- La relativa didascalia di Alexandre Dumas figlio diceva “Le opinioni sono come i chiodi: più li si colpisce, più li si pianta”. Intendendo così l’effetto contrario alle intenzioni della propaganda monarchica, la quale, demonizzando la repubblica, rafforzava i sentimenti repubblicani.
- ...
- Ho l’impressione che tale manifesto sia ignoto alla comunicazione mainstream e in genere ai globalizzatori (aiutantato compreso) perché ogni volta ricadono nel medesimo errore. Da ultimo proprio in Romania e Germania.
- In Romania l’eliminazione per via giudiziaria del candidato, di estrema (??) destra ha solo prodotto che nelle rinnovate consultazioni l’estrema destra (cosiddetta dagli esorcisti mainstream) è passata da circa il 23% a oltre il 40% dei voti espressi. In Germania la “ghettizzazione” post-elettorale dell’AFD pare (perché risultante dai sondaggi, sempre opinabili) abbia provocato l’aumento del gradimento di detto partito fino a promuoverlo a primo partito tedesco. Non è dato sapere quanto lucrerà l’AFD dal rapporto negativo dei servizi segreti della Repubblica federale, di cui si discute in questi giorni. Né se tutto abbia influito sul primo scrutinio (negativo con 18 “franchi tiratori”) per l’elezione di Merz.
- ...
- Ma appare chiaro da questo e dalle analoghe vicende in altri paesi che il richiamo dei “poteri costituiti” alla legalità è affetto da costante e persistente “eterogenesi dei fini”, onde, di solito, ottiene l’effetto contrario. Si ha l’impressione che, per ottenere quello voluto, sarebbe opportuno sostenere che AFD è un partito di democrazia ineccepibile, o che Georgescu è nemico giurato di Putin. In fondo aveva ragione Giorgia Meloni quando, mesi fa, parlando al Convegno di Atreju disse di aver stappato una bottiglia del vino migliore ascoltando le critiche mossele da Prodi; le quali, alle orecchie della maggioranza degli italiani suonavano come (meritati) complimenti. Gridare “al lupo, al lupo” in assenza dello stesso è controproducente.
- ...
- Si possono enumerare varie ragioni per spiegare la credibilità inversa della propaganda delle élite decadenti. La prima – e la più ovvia – specie in Italia è che i modesti risultati di quelle ne rendono poco appetibile le soluzioni proposte. Sempre da noi, si aggiunge il fatto che spesso (come per il jobs act) il PD (e non solo) quando sta all’opposizione propone rumorosamente di abrogare qualche riforma o provvedimento fatti stando al governo (e perché li hanno posti in essere o almeno modificati prima?). La seconda, che ho sottolineato da mesi, è che il tutto può ricondursi a una contrapposizione tra legalità (la quale va dall’alto in basso) e legittimità (che segue il percorso inverso). La prima è perciò (anche) strumento del comando; l’altra produce obbedienza. La terza è che, proprio per esercitare ed aver esercitato il potere, la legalità è comune alle élite decadenti, come la legittimità (di solito) alle emergenti.
- ...
- E si potrebbe continuare ad enumerare, in particolare, per la Germania dalla normativa sui partiti e su chi decida, di cui all’art. 21 della Grungesetz tedesca e sulle sue implicazioni. Ma questo un’altra volta.
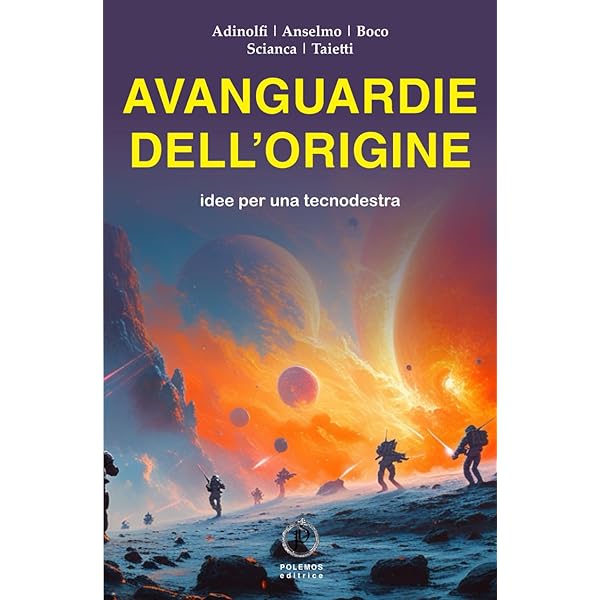
"Avanguardie dell’origine"- di
- Autori Vari
- Potenza e Tecnica
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
Usciamo dalla lettura di un volume collettaneo che ci ha fatto pensare. Ci riferiamo a, Avanguardie dell’origine. Idee per una tecnodestra, nelle librerie per i tipi di Polemos editrice (pp. 90, euro 12,00). La silloge raccoglie sette saggi di cui sono autori Adriano Scianca, Carlomanno Adinolfi, Andrea Anselmo, Guido Taietti e Francesco Boco (questi ultimi hanno contribuito alla pubblicazione con due scritti) ed è aperta dalla prefazione di Alberto Brandi. Gli autori condividono delle premesse di fondo. Innanzitutto sono convinti, e noi con loro, che viviamo in un frangente storico nel quale è in gioco il senso profondo della civiltà europea. Chi oggi si dedica al pensiero, deve muovere da una certezza: nell’età iper-industriale si pensa, per dirla con Alain Badiou, “dalla fine” non solo della filosofia, ma di qualsivoglia posizionamento identitario, comunitario dato. L’altra premessa condivisa riguarda l’“inaggirabilità” della Tecnica (l’espressione è del filosofo francese Bernard Stiegler). Dal Gestell è necessario muovere per pensare e agire. Rispetto allo stato presente delle cose, qualsivoglia risposta meramente “conservatrice”, qualsiasi atteggiamento politico animato da nostalgia per il “bel tempo andato”, neo-luddista, risulta inefficace, passivo, in quanto condivide il medesimo orizzonte politico-ideologico della “religione dei diritti”, ennesima variabile degli universalismi progressisti.- ...
- Di contro, se abbiamo ben inteso, i saggi di Avanguardie dell’origine, tendono a una messa in discussione radicale dei presupposti teorici prevalsi nel pensiero europeo attraverso la metafisica a muovere dalla filosofia classica. Essi stanno a monte della visione monocratica, discesa dai monoteismi, fattasi storia in un lungo processo temporale. L’ultimo momento di tale iter è rappresentato dalla governance che pienamente risponde, sotto il profilo politico, ai bisogni del capitalismo cognitivo e computazionale.
- ...
- Viviamo ormai virtualmente; l’infosfera creata dal Gestell contemporaneo (di cui si occupano Guido Taietti e Francesco Boco) sta annullando la realtà, le relazioni vere, corporali, che legano gli uomini. L’uscita di sicurezza da tale impasse è individuata dagli autori nel recupero dello spirito europeo: «uno spirito in cui gli opposti si incontrano, in cui la visione di antiche fortezze si sovrappone ad astronavi che si librano nel vuoto interstellare verso nuovi mondi» (p. 8), sostiene Brandi. Tutti i saggi sono animati da tensione archeofuturista che, muovendo dagli assunti del Futurismo italiano, sposa le tesi di Guillaume Faye. Al tema, Andrea Anselmo dedica il suo scritto, incentrato sull’analisi della profondità iniziatica delle pagine di Ernst Jünger, non casualmente autore di Der Arbeiter, per giungere alla proposta trasvalutatrice della Tecnica propria del pensatore francese.
- ...
- La medesima direzione ideale la si evince dal contributo di Carlomanno Adinolfi. Questi propone la conciliazione di realtà divergenti, barbarie e civiltà, che sarebbe resa possibile, a suo dire, dal recupero della Tecnica quale archetipo puramente indoeuropeo. E’ l’Eroe, figura negletta dalla cultura dominante, a divenire, in questa prospettiva il nuovo soggetto della storia. Gli Eroi, ben lo seppe Carlyle sono tali quando, nell’agire antiutilitaristico che li induce al sacrificio della vita, non si limitano a rivendicare un passato dato, ma: «la fonte metastorica della nostra identità» (p. 9).
- ...
- Il fondamento filosofico di tali tesi va rintracciato nel saggio di Adriano Scianca, Dynamis. Una filosofia delle forze, che apre il volume e ne rappresenta il momento più rilevante. L’autore discute l’asserzione platonica del Sofista, nella quale il filosofo ateniese sostenne l’ente altro non essere che dynamis: «Essere è produrre o patire un effetto, agire o patire […] il reale è una potenza che si esercita producendo effetti» (p. 11). Scianca ha ragione nel sostenere che la dynamis in quanto en-ergheia precede la distinzione di atto e potenza. A sua dire, la traduzione del termine dynamis con “possibilità” e la stessa ontologia aristotelica, nella quale la potenza sarebbe legata, in rapporto costitutivo, con la potenza-di-non, come chiarito da Agamben, avrebbe sterilizzato il senso della dynamis, intesa da Scianca quale forza puramente affermativa. In realtà, la nostra posizione in tema è differente: per uscire dagli esiti della metafisica è esattamente al “possibile” che bisogna guardare. L’origine, per chi scrive, è il sempre possibile: essa si dà, come seppe la filosofia greca inaugurale, solo nella physis.
- ...
- Nel suo spazio, gli atti non sono che periechein, “ciò che momentaneamente avvolge” la dynamis mai normabile, come sostennero Andrea Emo e Julius Evola nella loro critica alla linea ermeneutica che, in relazione all’Atto, si è sviluppata con continuità da Aristotele fino a Gentile. Pensare, sic et simpliciter, la dynamis quale “forza affermativa” rischia, a nostro parere, di ricondurre la “filosofia delle forze” nelle braccia del soggettivismo, esito chiarissimo della metafisica. Non è casuale che l’esegesi di Scianca si richiami esplicitamente a Nietzsche, al prospettivismo, sia pure letto in termini nominalistici che, come mostrato da Giampiero Moretti, in Heidelberg romantica, indica, con tutta evidenza, come il grande pensatore tedesco, con la teorizzazione della volontà di potenza, sia stato l’ultimo metafisico. Lo stesso Heidegger era di questo avviso. Per uscire dalla metafisica, e recuperare, stante la lezione in tema di Löwith, la physis-mixis quale unica trascendenza cui guardare, è necessario salvare quel “non-potere” della dynamis che vige sempre negli atti. Essi altro non sono che il momentaneo positivizzarsi di una negazione originaria.
- La Tecnica moderna è altro dalla technè ellenica. Se l’ambito della prima è inaggirabile e, con essa, è giusto fare politicamente i conti, è necessario riconciliare Orfeo e Prometeo, non assolutizzare uno dei due termini. Il prometeismo, lasciato a se stesso, non tiene in alcun conto il limite greco segnato dalla physis, che impedisce qualsivoglia possibile ibridazione trans-umanista. Detto questo, sia pure nei termini rapsodici che una recensione impone, condividiamo con Scianca la necessità di uscire dai dualismi di mondo e sovramondo, di essenza e di esistenza, di corpo e anima in quanto: «La filosofia delle forze è […] un pensiero dell’immanenza, dell’immediatezza, della pienezza» (p. 15) e non può per questo essere pensata in termini assiologici. Per noi resta centrale il superamento della dicotomia essere-nulla. Quest’ultimo, il principio, il nulla-di-ente, la libertà-potenza, si dà solo come essere nell’eterna metamorfosi della physis.
- ...
- Di là dalle divergenze interpretative siamo grati agli autori di, Avanguardie dell’origine, per aver presentato tematiche cruciali, sotto il profilo teorico e pratico, che dovrebbero essere, per questo, discusse in spazi diversi da quelli di una semplice recensione.
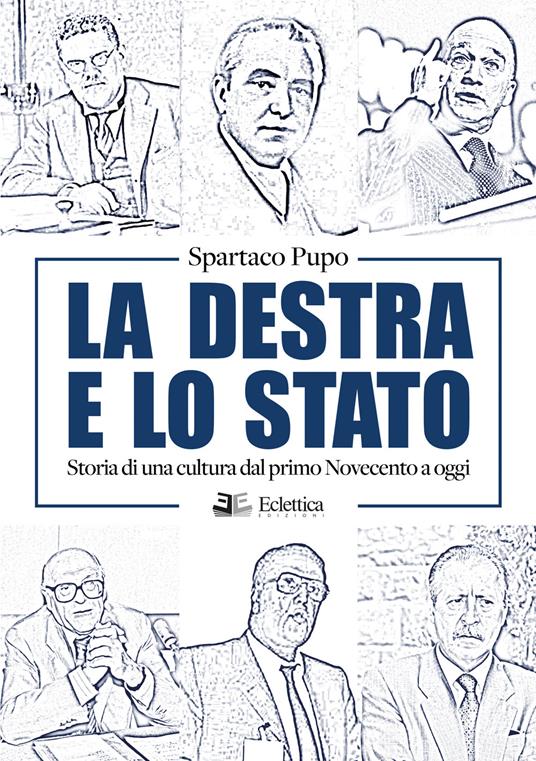
La destra e lo Stato- Un saggio di
- Spartaco Pupo
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
Spartaco Pupo è studioso davvero prolifico. È nelle librerie la sua ultima fatica, La destra e lo Stato. Storia di una cultura dal primo Novecento a oggi, comparsa nel catalogo di Eclettica Edizioni (per ordini: 0585/1817914, info@ecletticaedizioni.com, pp. 293, euro 16,00). Si tratta di un saggio di grande rilievo nel quale l’autore conferma di essere uno degli intellettuali più rappresentativi del conservatorismo italiano. Nelle sue pagine mostra, con persuasività d’accenti, con ampia conoscenza delle fonti e acribia esegetica, che il vituperato (dalla vigente cultura mainstream) stato nazionale: «sintesi insuperata tra la dimensione burocratico-amministrativa e quella spirituale-culturale» (p. 5), non è affatto un riferimento politico superato, fuori dalla storia dell’età della globalizzazione ma, al contrario, risulta essenziale per uscire dallo stato presente delle cose. La fiducia in tale istituzione, ricorda Pupo, ha fortemente segnato di sé il patrimonio ideale della destra italiana a muovere dal post-fascismo del MSI ed, per tal via, giunto a Fratelli d’Italia.- ...
- L’approccio metodologico seguito dallo studioso, se abbiamo ben inteso, è quello proprio della “Storia delle idee”, mirato a registrare non solo l’elaborazione dottrinaria di filosofi e politologi, ma attento all’interazione di quest’ultima con la concreta azione politica esercitata, nelle diverse fasi della sua storia, dalla destra italiana. L’incipit del volume rappresenta la pars destruens delle intenzioni teoriche di Pupo. L’autore chiarisce l’inanità delle tesi universaliste marxiste e liberali, in un confronto serrato con le divergenti posizioni sovraniste. Le stesse tesi cattoliche, in particolare quelle di Sturzo, che parlò di Stato sussidiario, nel quale si realizzerebbe il primato della persona, sono ricondotte da Pupo, con pertinenza argomentativa, alla loro matrice liberale, all’idea di Stato minimo. Infine, l’istanza federalista è esperita quale esempio di “decentrismo”, di effettiva perdita della sovranità da parte dell’istituto statuale. Oggi, il grande nemico dello Stato nazionale, ricorda il Nostro autore, è rappresentato dal cosmopolitismo dei diritti, dalla cultura Woke, neganti qualsivoglia appartenenza identitaria.
- ...
- Nella parte successiva del testo, Pupo presenta, in termini organici, il tema della difesa dello Stato nazionale in pensatori e giuristi che furono vicini al fascismo. Tra gli altri, Rocco, Costamagna, Evola, Maraviglia. La Statologia di Rocco diede: «impulso alla difesa morale dello Stato […] in grado di guidare la società italiana nella lotta contro ogni nemico» (p. 50), interno ed esterno. Posizione, quella del giurista, che guardava alla “solidarietà nazionale” che, al di là degli egoismi di classe, avrebbe dovuto esser perseguita dallo Stato corporativo. In quel particolare frangente storico, il Codice Rocco rappresentò: «lo strumento principe della civilizzazione statuale della società italiana» (p. 52). Costamagna, a sua volta, si fece latore di una scienza della politica atta a mettere in scacco la visione meramente giuridica dello Stato e, per questo, capace di porsi quale: «disciplina regolatrice di tutte le materie che avevano a cuore lo studio dell’uomo nella sua attività teoretica e pratica e rivendicavano quella “funzione direttiva” da sempre esercitata dalla teologia» (p. 59). Sulla scorta di tali acquisizioni teoriche, lo stesso Evola, aristotelicamente, riconobbe allo Stato la funzione di “forma” rispetto alla materia-nazione, oltre qualsivoglia nazionalismo etnico. Lo Stato di Evola si configura quale “organismo spiritualizzato” mirante all’Imperium, sintesi di potere regale e sacerdotale: «Evola ripone tutte le sue speranze in uno Stato che non dovrà procedere da alcun elemento “inferiore” per trovare la sua ragion d’essere esclusivamente in principi superiori, spirituali, metafisici» (p. 63). Del resto, anche per Maraviglia: «Solo lo Stato era (sarebbe stato) in grado di esprimere la volontà piena e complessiva della Nazione» (p. 79).
- ...
- Capitolo dirimete, attraversato da evidente empatia dell’autore per le tesi espresse dal filosofo, è quello dedicato al pensiero politico di Gentile. Questi era fermamente convinto di una cosa: ciò che realmente stava a cuore al fascismo era l’idea di una “grande Italia”. Per il teorico dell’attualismo lo Stato: «ha un valore assoluto […] fa “uomo l’ uomo” […] è vita di uomini, vita spirituale: e questa vita non è dato concepirla se non come devozione assoluta a un’idea» (p. 98). Lo Stato vive nel nostro foro interiore, in interiore homine. Qui rinveniamo il “Noi”, la nostra appartenenza comunitaria, il nostro esser parte di una storia, di una tradizione, di un destino comune. Per questo, la libertà vive in simbiosi con l’autorità statuale in quanto: «non esiste uno Stato esterno all’individuo, né un individuo esterno allo Stato» (p. 100) e ancora: «la res publica “prima di tutto” è per l’individuo sua propria res» (p. 105). Non dissimile, ricorda Pupo, la posizione di Pound. Il poeta sostenne che Mussolini sarebbe stato l’artifex di una nuova fase della civiltà, oltre l’individualismo finanziario-usuraio, nella quale, ruolo di primo piano, avrebbero avuto i produttori, gli artisti e i creatori di idee.
- ...
- Tale patrimonio ideale si irradiò dalla RSI ai protagonisti della vita politica del MSI, il cui dibattito interno l’autore analizza minutamente, e di lì giunse alle formazioni partitiche successive della destra italiana. Particolarmente significative, oltre che eticamente edificanti, sono le pagine dedicate al giudice Borsellino e alla sua nobile difesa dello Stato. Questi: «ebbe a rimarcare la necessità di “un profondo rinnovamento delle istituzioni e della politica” […] accompagnato da un impegno culturale diretto alla valorizzazione del ruolo delle istituzioni pubbliche» (p. 180). Il magistrato siciliano pagò questo suo impegno, proprio come Gentile, con il sacrificio della vita. Nel 1994, con la vittoria elettorale del centro-destra, si riaccesero le speranze in una ripresa della tradizione politica statualista. Esse andarono presto deluse: «Berlusconi […] contribuì in prima persona alla frantumazione del progetto da lui stesso creato» (p. 223). Nella attuale congerie storica, ci si attende che la destra di governo sappia far valere la nostra sovranità nazionale.
- ...
- Pupo, in tema, è probabilmente più ottimista di chi scrive. A noi pare che la politica estera, ma non solo, del governo in carica, smentisca tale aspettativa. Nonostante ciò, La destra e lo Stato è libro importante per la sua puntuale ricostruzione storico-teorica e per la proposta politica in essa implicita. Ci auguriamo, pertanto, che la sua lettura riapra, finalmente, il dibattito politico a destra…
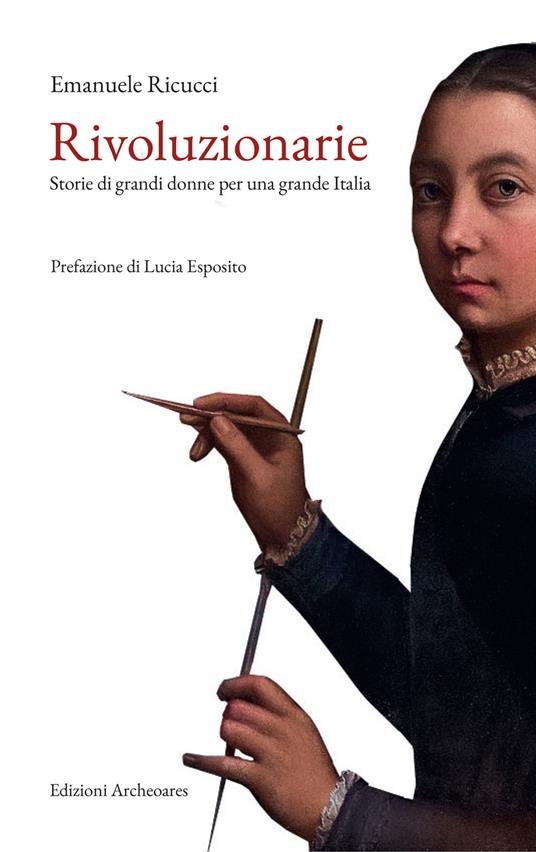
"Rivoluzionarie"- Storie di grandi italiane
- di
- Emanuele Ricucci
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Emanuele Ricucci è giornalista e saggista. Non ancora quarantenne, ha già firmato un numero considerevole di volumi. È nelle librerie, per i tipi delle Edizioni Archeoares, la sua ultima fatica, Rivoluzionarie. Storie di grandi donne per una grande Italia. Il volume è arricchito dalla prefazione di Lucia Esposito (pp. 121, euro 13,00). Si tratta di un testo controcorrente, al centro del quale stanno sette figure femminili, meglio, sette straordinarie italiane. Di alcune di esse, la vulgata storiografica vigente ha sottaciuto il valore del contributo fornito in momenti dirimenti della storia d’Italia, di altre, invece, non sempre ha riconosciuto il tratto innovatore e rivoluzionario. Badi il lettore, il testo di Ricucci non è un lavoro meramente storiografico. Le pagine di Rivoluzionarie, infatti, attraverso la ricostruzione cronachistica delle vicende nelle quali queste donne furono implicate, entrano nelle vive cose del loro vissuto quotidiano, interrogando in profondità l’animo femminile connotato da naturale capacità euforizzante. Utilizziamo questo aggettivo nel senso greco: esso rinvia al “ben sopportare” i dolori e i drammi dell’esistenza, a vivere “serenamente”, anche in contingenze avverse, la tragicità della vita, tratto connotante ontologicamente il “femminile”.
- ...
- Dalla lettura del volume si evince la non comune qualità affabulatoria della prosa di Ricucci. Essa è risultato dell’empatia con la quale l’autore presenta la grandezza, tutta italiana, delle sette protagoniste del narrato. Lo fa in modalità, in un certo qual modo, diaristica, intima, ma tenendo in debito conto la bibliografia storico-critica prodotta in tema, presentando bervi spaccati della storia d’Italia dell’età nella quale le protagoniste vissero. Il primo “medaglione” è dedicato a Marzia degli Ubaldini che, nel 1300, combatté per difendere Cesana dall’assedio delle truppe pontificie. Lo fece a tutela dello Stato retto dal marito, Francesco degli Oderlaffi, signore di Forlì e Cesena. Marzia fu sollecitata all’azione da questa pressante domanda: «Patria, casa della vita che non può essere ceduta. Come si può concedere l’albergo naturale, come si può permettere l’abuso del ventre materno?» (p. 19). Il suo coraggio risulta simile alla potenza dello zefiro primaverile, atto a rinnovare ciclicamente la vita. Del resto, la donna era sostenuta, come si evince dal nome Marzia, dal dio della guerra e, allo stesso tempo, dall’Amore che discese su di Lei della divina Venere. Quella di Marzia degli Ubaldini fu femminilità votata alla grandezza.
- ...
- Non dissimile fu l’azione realizzata a Firenze da Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima discendente della dinastia che a Careggi permise il costituirsi dell’Accademia neo-platonica. Questa donna firmò la “Convenzione del 1737” sottoscritta anche dai nuovi Signori di Toscana, i Lorena, con i quali: «dispose che tutte le collezioni dei Medici restassero a Firenze» (p.10), realizzando un: «atto di materna cura per la futura memoria d’Italia» (p. 31). Mise in salvo, in tal modo, il Genius loci della città di Dante, Firenze, la “sempre fiorente”, per determinare un Nuovo inizio della sua storia e di quella d’Italia. Ricucci, inoltre, nelle pagine del libro, ridà vita alla nobile figura di Elena Lucrezia Cornero Piscopia e alle travagliate vicende che la condussero a diventare prima donna laureata al mondo. Ai dinieghi iniziali delle autorità accademiche e della cultura del tempo, rispose con affermazione volitiva, riuscendo nel proprio intento. Chiosa l’autore: «Siamo di fronte a un confine mai valicato prima» (p. 49), da una donna. Properzia de’ Rossi, in piena Rinascenza fu, invece, latrice di un primato diverso, fu prima scultrice italiana a essere ammessa a partecipare ai lavori della cattedrale di San Petronio a Bologna, tanto da venir ricordata da Giorgio Vasari ne, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti.
- ...
- Francesca Caccini, fu, fin da afnciulla, di eccellente e polivalente ingegno, poetessa che versificava in latino, virtuosa del liuto, del clarinetto e del clavicembalo, si adoperò, perfino, per l’apertura di una scuola di canto: «Per questo concepire e realizzar profondamente il processo che conduce, […] a una coltivazione interiore, che si esprime anche attraverso l’arte» conseguì: «il più potente antidoto alla finitezza, all’(in)utilità d’aver vissuto» (pp. 75-76). Al suo fianco, per meriti artistici, va posta Sofonisba Anguissola. Pittrice attenta ai dettagli, nei suoi ritratti mise un luce un’attenzione psicologica non comune per gli stati d’animo dei personaggi rappresentati su tela e, per tale ragione, fu ammirata nelle corti d’Europa. La donna fu: «Di sicuro […] un raggio di luce dell’arte che trova traduzione in ogni tempo […] il cui frutto non si decompone con l’artista» (p. 108).
- ...
- Infine, ma non ultima, Matilde Serao. Nacque alla fine dell’Ottocento ma, per sensibilità, è, di fatto, nostra contemporanea. Fondò e diresse un quotidiano. Figlia di un italiano e di una greca, nutrì profonda ammirazione per la civiltà mediterranea. Chiosa l’autore: «È figlia del contrasto e del lungo orizzonte del mare nostrum, che offre sempre la speranza di un nuovo viaggio, di un rinnovato inizio» (p. 94). Si convertì al cattolicesimo nel 1872, fu candidata, in più occasioni, al Premio Nobel, ed ebbe in spregio, da donna realizzata qual’era, le prime avvisaglie del montante femminismo. I sette “medaglioni” raccolti da Ricucci in, Rivoluzionarie, mostrano, nell’analisi del femminile, un incontestabile primato italiano, che fa mostra di sé anche oggi oltre gli steccati eretti della cultura mainstream dominante.

Gli Anni dell’Aquila- Cronache dell’UR-Fascismo 1922-2422
- di
- Errico Passaro
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
È nelle librerie, per i tipi delle Edizioni Tabula Fati, un volume di Errico Passaro, Gli Anni dell’Aquila. Cronache dell’UR-Fascismo 1922-2422, che vivamente consigliamo a chi ci legge (per ordini: edizionitabulafati@yahoo.it, 335/6499393, pp. 188, euro 14,00). L’autore è stato uno dei più rilevanti narratori italiani degli ultimi decenni, con riferimento al genere letterario del fantastico, del fantascientifico e poliziesco. - ...
- Gianfranco de Turris, che in questo ambito, è autorità riconosciuta oltre che generoso promotore di scrittori ai loro esordi, nella Presentazione ricorda di aver compreso immediatamente, al momento della prima lettura di un testo di Passaro, le sue qualità creative e scrittorie. Errico, prematuramente scomparso nel 2023, viene definito da de Turris, in forza della professione delle Armi da questi svolta, scelta per vocazione dopo gli studi in Giurisprudenza, “il Colonnello della fantascienza”. Ne ricorda, con evidente commozione, il tratto signorile e discreto cui si mantenne fedele fino agli ultimi giorni di vita, nonostante patisse il dramma della malattia. La conoscenza e frequentazione tra i due ebbe inizio durante un’edizione del Premio Tolkien, evento culturale attraverso il quale venne finalmente sdoganato dalla marginalizzazione il genere Fantasy.
- ...
- Inizialmente, il libro avrebbe dovuto intitolarsi, Cronache del Quinto Stato, ma a seguito della pubblicazione, nel 1995, del noto saggio di Umberto Eco, Totalitarsimo “fuzzy” e Ur-fascismo, assunse fin dalla prima edizione del 1996 (Settimo Sigillo), il titolo attuale. Intenzione dichiarata di Passaro è quella di ribaltare le quattordici caratteristiche tipiche e negative che il semiologo piemontese attribuiva al fascismo, in altrettanti aspetti positivi. In particolare, l’autore afferma che: «L’Utopia non è patrimonio inalienabile della Sinistra, che la Destra ha da dire la sua in merito» (p. 18). La storia, infatti, non è riducibile, se di essa si vuol fare strumento per la comprensione profonda della vita, a mera accumulazione di dati, come nell’accezione positivista e critico-accademica di tale disciplina. In essa palpita il regno del possibile, connotato dalla possibilità dell’impossibile, come ebbe a riconoscere il filosofo Adriano Tilgher. Il passato, custodisce, come seppe Walter Benjamin, qualcosa di non-espresso pienamente che il pensatore tedesco definì l’immemoriale, scintilla che può sempre essere accesa nel presente esposto sul futuro, in una connessione estatica delle tre dimensioni della temporalità.
- ...
- Con Gli Anni dell’Aquila, Passaro destruttura il feticismo del “fatto compiuto”. Lo fa servendosi, come ricorda de Turris, delle tesi di Toynbee della “sfida e risposta”. Nello specifico, poiché il tema trattato è quello del fascismo visto in uno sviluppo di cinquecento anni, dal 1922 giunge al 2422, l’autore sostiene tale movimento politico essere aperto, di fronte a ogni crisi indotta dal cadere preda del burocratismo e della routine partitocratica, a continui cambiamenti e metamorfosi. Esse sono, in qualche modo, il risultato dell’adesione piena all’idea di Tradizione. Nel suo etimo, tale espressione rinvia a “trasmissione” e, al contempo, a “tradimento”. Trasmissione dell’originario e dell’essenziale, tradimento di ciò che in esso è accessorio e transeunte. Si tratta dell’applicazione alla storia del fascismo, se abbiamo ben inteso, dell’idea evoliana di individuo assoluto, uomo sciolto, svincolato perfino da sé, sempre aperto all’incipit vita nova. La vicenda narrata si sviluppa in cinque episodi. Nel primo, ambientato nel 1922, il fascismo giunge al potere guidato da Gabriele D’Annunzio e non da Mussolini. Un movimento, quindi, animato da volontà realmente rivoluzionaria, nel quale l’aristocrazia creatrice degli artisti, poundianamente, avrebbe realizzato una gerarchia dello spirito mirata alla giustizia sociale.
- ...
- Nel secondo episodio viene presentata la ribellione rinnovatrice dei seguaci del Duce, mentre, nel terzo capitolo, viene narrata la rivolta simbolica dei tradizionalisti e di Evola. Nel quarto, di contro, si dice del confronto del regime con il conflitto nucleare potenzialmente catastrofico mentre, nell’ultimo episodio, si racconta, addirittura, del confronto con gli alieni e della loro critica alle ideologie terrestri. In tali fantastiche contingenze storico-politiche, il fascismo di Passaro seppe rinnovarsi, seppe sempre porsi oltre le ossificazioni sistemiche che avevano paralizzato la sua “artecrazia”. Simbolo di tale volontà metamorfica è l’Aquila coronata dannunziana, che fa la comparsa nella chiusa del volume, stringendo: «tra gli artigli la spada fiammeggiante di Evola e il fascio» (pp. 13-14).
- ...
- Soffermiamoci sul terzo capitolo, dedicato alla rivolta simbolica dei tradizionalisti. Il tentativo di rivolta è narrato attraverso il diario degli eventi steso da Evola stesso a partire dal 1 febbraio 1982 (è noto che il tradizionalista morì nel 1974). Il filosofo, si dice, beneficiava, nel suo eremo alpino, pur essendo anziano, di piena Salus, fisica e spirituale. Gli emissari di un fantomatico Ordine, organizzato in cellule nelle città italiane, lo arruolarono tra le proprie file al fine di rettificare in “senso tradizionale”, con un’azione politica, il regime in fase di decadenza. Pur nutrendo dei dubbi, Evola accettò la sfida e si impegnò nella lotta. Il diario è una sorta di analisi psicologica di questa scelta del pensatore che incorse in un attentato, dovuto al frazionamento interno dell’Ordine. I cospiratori, alla fine, nel tentativo di prendere Roma, furono sconfitti ed Evola venne condotto in carcere: «La propaganda del fascismo regime è entrata in azione e ha seppellito la verità sotto un mucchio di veline» (p. 115). Nonostante ciò, l’azione ebbe comunque un senso, almeno simbolico: «In un futuro nemmeno troppo lontano, qualcuno riprenderà la nostra battaglia […] vincendola» (p. 116).
- ...
- In queste pagine, Passaro mostra di essere scrittore di vaglia, la sua prosa è connotata dalla: «vividezza del romanziere» (p. 14), supportata da passione ideale. Il volume, inoltre, non è frutto solo di ipotetica ricostruzione fantastica: l’autore mostra di conoscere la bibliografia critica più accreditata in merito alla storia del fascismo, non casualmente posta alla fine di ogni capitolo. Passaro, nonostante la prematura scomparsa, come mostrano le pagine de, Gli Anni dell’Aquila, è scrittore vero, per alcuni ancora da scoprire, per altri da ri-scoprire.
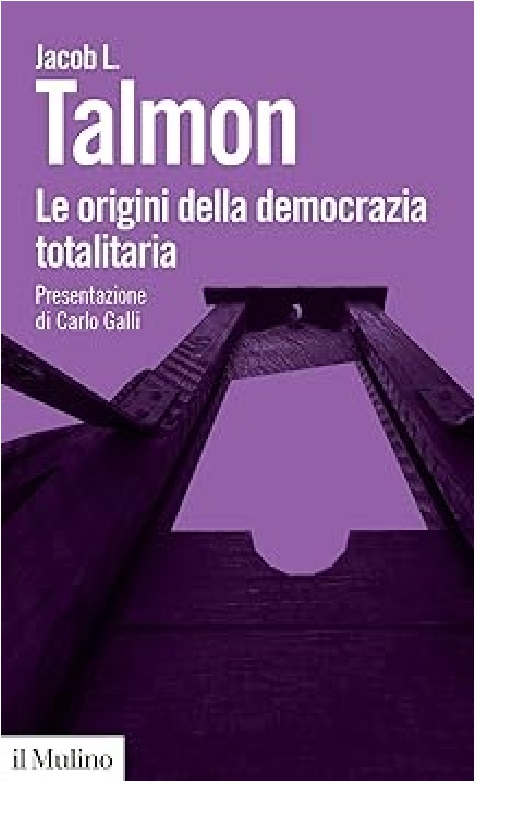
- Jacob L. Talmon
- Le origini della democrazia totalitaria,
- (Il Mulino 2024, pp. 448, € 18,00, Presentazione di C. Galli)
- rec. di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Una nuova edizione del saggio di Talmon è proposta dal Mulino con la presentazione (aggiornata) di Carlo Galli. Scrive il presentatore “Quando, nel 1951, Jacob Talmon concludeva la stesura del suo libro su Le origini della democrazia totalitaria la cultura occidentale – in quasi tutte le sue accezioni e declinazioni – si stava interrogando su che cosa avesse determinato il totalitarismo fascista e comunista”. Molti intellettuali si chiedevano come il razionalismo, connotato peculiare della modernità “si fosse rovesciato nelle tenebre di Hitler e di Stalin”. La tragedia era imputata alle ragioni più varie.
- ...
- A tale temperie appartiene anche l’opera di Talmon, secondo il quale “Il libro è dedicato alla formazione della religione, e del mito, del messianismo politico rivoluzionario e del millenarismo nella filosofia illuministica del Settecento”. Dopo essersi manifestato nella rivoluzione francese il messianismo, ispiratore anche della Comune di Parigi, emigrava ad oriente nella Russia e nella rivoluzione bolscevica. Talmon ritiene che tratto principale ne sia “il postulato di un sistema sociale unico basato sulla soddisfazione uguale e completa dei bisogni umani come programma di azione politica immediata. La giustificazione economica o la definizione di questo postulato è una questione di secondaria importanza”.
- ...
- Babeuf l’aveva immaginato oltre un secolo prima, nel sostenere che così si sarebbe razionalizzata al massimo produzione e distribuzione. Il che implica anche l’abolizione della proprietà privata (e altro). Scrive Galli che “Questo libro è dunque costruito su di un disegno unitario: secondo Talmon c’è un’obiettiva evoluzione della fede politica negli ultimi due secoli, dal postulato dell’armonia etica all’obiettivo dell’uguaglianza economica e della felicità universale”, e i fondamenti hanno più a che fare con l’armamentario dell’illuminismo, in particolare con la virtù, principio politico secondo Montesquieu della democrazia, onde dev’essere, se insufficiente, imposta.
- ...
- Nella nota aggiunta a questa edizione, Galli ritiene che “il rovesciarsi della democrazia in dominio, è nel frattempo emerso come rischio immanente non solo allo Stato sociale ma anche alle cosiddette «società aperte» che lo hanno (parzialmente) sostituito e che all’individuo, ai suoi diritti e al suo libero agire economico, affidano il compito di evitare gli effetti totalitari della politica”; infatti anche tale ordine “pretende apertamente di costituire una totalità omogenea, priva di alternative – peraltro non certo immune dalle logiche più dure della politica”.
- ...
- In conclusione il messianismo politico e la di esso compagna inseparabile, cioè l’eterogenesi dei fini può trovare la principale spiegazione nel rapporto tra immaginazione e realtà. Il messianismo si nutre della prima, ma finisce per essere succube della seconda. La quale recupera, trasformandone i risultati, che confermano le regolarità e i presupposti del politico. Questo a meno che, come scriveva Gaetano Mosca, certe costruzioni siano non “sogni di uno sciocco”, ma furberie da ipocriti. Come spesso succede.
-
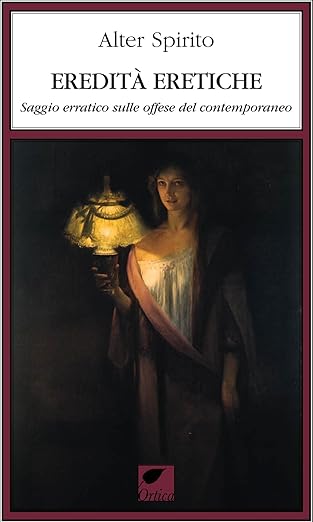
"Eredità eretiche"- Una raccolta di pensieri di
- Alter Spirito
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Alter Spirito è autore noto per avere dato alle stampe, negli ultimi vent’anni, diverse sillogi poetiche. Badi il lettore, la sua formazione e la stessa ispirazione di fondo che muove i suoi scritti sono di natura filosofica. Lo si evince, in tutta evidenza, dalla sua ultima fatica, Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo, nelle librerie per i tipi di Ortica Editrice (pp. 119, euro 11,00). Un testo che si presenta, a una prima lettura, quale raccolta di pensieri sparsi.
- ...
- In realtà, il lettore attento comprende facilmente che, in esso, Spirito enuncia la propria visione del mondo, ruotante attorno a due cardini. Il primo è ben esemplificato dal sottotitolo polemico che rinvia a un antimodernismo, non semplicemente concettuale o teorico, ma esperito e patito in termini esistenziali, nella nuda carne, dallo scrittore. Spirito, attraverso l’espressione scrittoria, mette in atto una disperato, ma potente j’accuse, nei confronti della mestizia spirituale del tempo presente, della post-modernità liquida. Il secondo cardine ideale, quint’essenza della visione dell’autore, è il tragico, grecamente inteso.
- ...
- Ricorriamo, al fine di cogliere quello che ci pare, se abbiamo ben inteso, il cuore vitale del libro, all’espressione coniata da Roberto Esposito a proposito di uno dei caratteri dell’Italian Thought, “filosofia della resistenza”. Spirito è, per noi, rappresentante di rilievo di tale “filosofia della resistenza”. Resiste al pensiero dominate e agli idola, oggi virtualmente pervasivi che hanno colonizzato l’immaginario individuale e comunitario. Per questo, come recita il titolo, si pone in sequela di Eredità eretiche, le cui molteplici voci (non solo italiane) animano empaticamente il suo dire: «Ho vissuto e vivo di eredità eretiche. La devianza esistenziale mi appartiene sempre di più» (p. 5). Lo scrittore-filosofo muove dalla constatazione che la tarda modernità, si mostra, innanzitutto, nella fuga dalla Parola, dal Dire originario, indotta dall’oblio dell’Altrove. La “morte di Dio” pare aver insterilito la spinta esistenziale e teoretica a una possibile Persuasione, per questo il dire tragico diviene, nel tempo della post-verità, per chi pensi, come rilevato da Alain Badiou “dalla fine”, esercizio di parresia. Il lettore non è blandito da alcun atteggiamento consolatorio, ma posto, ad occhi aperti e sbarrati, di fronte alla nuda vita, all’ineluttabilità della morte. La morte, la grande esclusa dal banchetto caleidoscopico e abbagliante della modernità volta all’utile, come si evince dal ricordo del dolore indotto nell’autore dalla perdita della madre, cela in sé la possibilità dell’autentico: «Ogni vera autenticità ha sempre il sapore di un fallimento» (p. 8).
- ...
- Queste pagine sono scritte da un solitario, da un uomo che si è auto-escluso dal perverso gioco di società che tutto lega e sono attraversate dall’idea umanistica di Malinconia, con tutti i suoi correlati, in particolare la fantasia e l’immaginazione. Esse spingono a contemplare il silenzio del non-detto, custode dell’origine. Tale ascolto, a cui l’udito di Spirito è avvezzo, propizia l’otium, il non-agire: «Limitarsi a contemplare l’essente, anziché, come accade da più di tre secoli, a manipolarlo sottoponendolo alle leggi brutali dello sfruttamento utilitaristico» (p. 11). Per tale esercizio è necessario riscoprire il “foro interiore”, luogo di tutela del “cuore avventuroso” jüngeriano.
- ...
- Portare l’attenzione in interiore homine consente il passaggio al “regno dell’inazione” di cui ha detto Musil, baluardo di libertà e di misura nell’età della dismisura imposta dal capitalismo computazionale. Una tesi impolitica, in senso manniano, ma proprio per questo, connotata in termini civili, essendo volta a beneficio del singolo e della polis. Il non-agire fa cadere le barriere dicotomiche e dualiste imposte dal logo-centrismo. Spirito, avendo contezza del proprio cammino esistenziale sostiene: «l’ho solo sfiorata la vita» (p. 14), egli ha vissuto la tentazione di esistere di Cioran. La scrittura che corrisponde a tale visione delle cose non può che essere: «lacerata, eretica ed urticante, frantumata e discontinua» (p.16). Si tratta della “comunicazione d’esistenza” praticata da Kierkegaard nei Diari, mirata a “prender per il collo” il lettore, a svegliarlo dalla letargia epistemica nella quale vive. Un dire del disinganno che s-determina, come accade nell’arte autentica, mirato a s-mascherare l’io, al fine di far sorgere in noi, limpido e cristallino, il principio che ci anima.
- ...
- È il serrato e coraggioso confronto con la lacerazione della vita, con il dolore, a liberarci. Lo seppe Andrea Emo, ricordato dall’autore: per il filosofo veneto il principio è un non orginario che, momentaneamente, si positivizza negli atti aristotelici, negli enti di natura e che tutto pervade.
- ...
- Per chi scrive, quindi, l’origine non vive in un Altrove, ma è sempre e solo, qui. Lo intese Giordano Bruno che finì, per questo, sul rogo: vive in noi e nella physis. il problema sul quale Spirito porta l’attenzione è di: «tentare di dire quel (questo) nulla» (p. 109). Solo tale experimentum linguae, stante la lezione di Derrida, può consentire di comprendere che l’aporia non sta nella morte, l’aporia è nella vita, nella sua caotica manifestazione, nel suo darsi. Tale aporia non atterrisce, lo seppe Leopardi, ma euforizza, consente, etimologicamente, di sopportare serenamente la lacerazione, l’assurdo di cui disse Rensi, della nostra ex-sistenza, del nostro esser-gettati nel mondo.
- ...
- Pur non conoscendo l’autore, ci sia consentito sostenere che nel suo libro abbiamo riconosciuto la testimonianza, partecipata anche emotivamente, di un “fratello”, di un comes in spirito. Non è poca cosa, nell’in-solitudine nella quale viviamo. Eredità eretiche ci ha permesso di compiere, nell’erranza del vero, come ebbe a scrivere il filosofo politico Gian Franco Lami: «Un passo per la vita, un passo per il pensiero».
- LA PRASSI DELLA LEGALITÀ CONTRO LA LEGITTIMITÀ
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Non meraviglia che un Tribunale francese abbia condannato Marine Le Pen e, quel che più conta, l’abbia interdetta dal candidarsi alle prossime elezioni. Non sorprende perché il tutto segue un copione ben noto (la cui prova generale fu fatta, in questo secolo, proprio in Italia con la defenestrazione di Berlusconi nel 2011) di estromettere dal potere attraverso decisioni giudiziarie, coloro che con quelle elettorali, cioè democratiche, non lo perderebbero.
- ...
- Le prospettive da cui giudicare ciò sono molteplici e sempre concorrenti: dalle regolarità (Miglio) della competizione per il potere alla necessità di una situazione eccezionale, dalla conformità (asserita) a regole inviolabili (la cui origine va dalla divina a scendere) al clamore assorbente della propaganda ad ampio spettro.
- ...
- Mi preme evidenziarne due, forse le meno (o punto) ricordate sui media: il conflitto tra legittimità e legalità e il comportamento (ricorrente) delle élite decadenti.
- ...
- Quanto al primo problema la distinzione tra legalità e legittimità, a leggere in rete, è normalmente così espressa “La legalità innanzitutto viene definita come la condizione di conformità alla legge e a quanto essa prescrive o vieta. Il termine legalità quindi non può essere riferito ad ogni atto, azione, provvedimento che rispetti la legge in vigore… Lì dove per legalità s’intende la conformità di un atto con l’insieme delle leggi dello Stato, la legittimità sta ad indicare il fondamento stesso del diritto dello Stato, ovvero il criterio a cui si rifà chi detiene il potere di legiferare – cioè il potere di dare forma alla legalità – o eventualmente chi lo contesta”; ovvero “Legalità può sinteticamente significare soggezione alla legge, o anche rispetto della legge. In questa accezione si è parlato, almeno sin dall’Ottocento, di principio di legalità… Legittimità invece significa, piuttosto, conformità ad una legge, cioè corrispondenza di un atto o di un comportamento specifici al modello astratto configurato da una norma di legge”.
- ...
- Hasso Hofmann scrive che “Schmitt pone il problema della legittimazione dell’autorità da legittimare con una svolta antitetica rispetto al presunto funzionalismo privo di contenuto della legalità dello Stato di diritto e spinge il concetto di legittimità in una inusuale e provocatoria contrapposizione con il concetto di legalità”. E in effetti il problema del legittimo fondamento del potere si pone dalla constatazione che questo è oggetto di conquista, cioè di un fatto storico, prima che modificazione, anche profonda di norme giuridiche. Per lo più questa è conseguente a quello, e talvolta (poche) non è una reale fine e rinascita dell’ordinamento, ma solo una di esso revisione, ancorché profonda.
- ...
- Lassalle descriveva bene questo rapporto tra situazione reale (i “rapporti di forza”) e redazione documentale “Questi effettivi rapporti di forza li si butta su un foglio di carta, si dà loro un’espressione scritta, e, se ora sono stati buttati giu, essi non solo sono rapporti di forza effettivi, ma sono anche diventati, ora, diritto, istituzioni giuridiche, e chi vi oppone resistenza viene punito”. Ne consegue che giudicare legittimo un ordinamento è confrontare la corrispondenza tra fatti generatori e successivi comportamenti, in primo luogo, quello dei governati, se considerano che chi ha afferrato (e consegnato) il potere abbia il “diritto” di esercitarlo. Come scriveva Santi Romano, un ordinamento così acquista vitalità e durata. Il che non ha nulla a che fare con la legalità, come sopra intesa. Se la storia, come diceva Pareto, è un cimitero di aristocrazie, data la successione di élite, regimi e sintesi politiche, è la legittimità a determinare l’ordine concretamente esistente, e non il legale - raro – avvicendamento tra quelli. Ciò stante la legalità può essere legalmente utilizzata anche per realizzare fini contrapposti a quelli dell’ordinamento legittimo. Lo teorizzava da rivoluzionario Lenin. Ma il caso più frequente è che se ne serva chi esercita il potere per conservarlo a scapito delle élite emergenti.
- ...
- E’ questa la via che vogliono far percorrere le élite europee (ma non solo) in “lista di sbarco”, forse anche nell’inconsapevolezza dei legali estensori delle decisioni relative. I quali possono sempre sostenere di aver osservato la legalità (norme, Stufenbau) cioè di avere il potere di decidere se il candidato rumeno escluso o Marine Le Pen fossero colpevoli dei reati loro ascritti e di averlo legalmente esercitato. Ma la conclusione, con l’interdizione ad esercitare o aspirare al potere politico, grava sull’esito elettorale e sulla legittimità dello stesso. In particolare in una democrazia governa chi è scelto (ha il consenso) dal popolo. Se si impedisce al capo dell’opposizione di presentarsi alle elezioni si annulla la prerogativa del popolo di designare chi governa. Cioè il contenuto essenziale e principale della democrazia politica.
- ...
- D’altro canto, soggetti dell’ordinamento internazionale sono coloro che esercitano il potere effettivo e non quelli che hanno diritto ad esercitarlo. Tant’è che persino i movimenti rivoluzionari conquistano una loro soggettività in conseguenza del potere esercitato, anche se in situazioni incerte (e precarie) su popolazione e zone di territorio. Vale sempre il principio generale di Spinoza che tantum juris quantum potentiae; costruire e garantire un ordine senza il potere è impossibile. Una delle conseguenze ne è, per l’appunto che il soggetto in diritto internazionale è colui che, di fatto esercita il potere e non chi ha il titolo legale a detenerlo. Ciò stante, nella specie, il far confliggere legalità e legittimità è semplice, anche laddove l’uso della legalità non fosse strumentale. Se una corretta decisione giudiziaria consiste in una logica e motivata sussunzione di una fattispecie a una norma, non significa che sia politicamente opportuna e conveniente. Diversamente una decisione politica opportuna e conveniente non significa che sia lecita e conforme a norme (anzi spesso non lo è).
- ...
- Quel che però conta di più – ed è un bene in sé – è che questa sia legittima: abbia con ciò il quantum di consenso dei governati necessario a non interrompere il rapporto tra vertice e base, capi e seguito. Proprio quello che manca alle élite decadenti (e alla burocrazia) che perdono consenso e potere. Lo stesso uso strumentale della legalità è un sintomo di decadenza.
- ...
- E con ciò passiamo al secondo tema. Pareto, che considerava regolare il movimento ondulatorio delle comunità, che alternavano periodi di crescita e di decadenza, considerava manifestazioni di declino delle classi dirigenti il richiamarsi a derivazioni (ossia a giustificazioni del potere) miti (umanitarie, buoniste), all’uso prevalente dell’astuzia piuttosto che alla forza, alla chiusura della circolazione delle élite. In diversa misura e in modi analoghi le élite euroccidentali in decadenza li manifestano tutti: dagli invocati diritti umani, alla “fine della storia”, dalla lotta climatica, ai vaccini, ecc. ecc.
- ...
- All’uso strumentale e indiretto delle varie emergenze (virus, clima, guerra) si accompagna la propaganda che talvolta attinge a livelli grotteschi: non ho prove che i Tribunali, da Berlusconi in poi, abbiano fatto un uso strumentale della giustizia, ma è evidente che l’abbiano fatta le élite decadenti (e i loro corifei) ed è altrettanto sicuro che il copione sia stato ripetuto più volte fino alla Le Pen. Onde pensare che sia voluto e programmato non è da respingere. Da evitare è l’adeguarvisi.

Contributi alla filosofia - (Dall’evento)
- di
- Heidegger
- Il
- commentario
- di F. W. von Herrmann
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- I Contributi alla filosofia (Dall’evento), per disposizione testamentaria di Heidegger, furono pubblicati in Germania nel 1989, nell’anniversario dei cento anni della sua nascita. Un’opera cruciale, non solo per l’iter teoretico heideggeriano e la comprensione del suo reale ubi consistam, ma, altresì, per la filosofia europea del XX secolo. È nelle librerie, per l’Editrice Scholé (Morcelliana) un volume di Friedrich-Wilhelm von Herrmann, assistente privato di Heidegger tra il 1971 e il 1976, che fornisce al lettore gli strumenti esegetici per entrare accortamente nelle complesse pagine dei Contributi. Va ricordato che l’autore intrattenne un’assidua frequentazione sia con il filosofo quanto con la sua famiglia, a muovere dal 1961. Il libro cui ci riferiamo si intitola, Contributi alla filosofia (Dall’evento). Un commentario (pp. 270, euro 25,00). Il testo, curato e ottimamente tradotto da Giampiero Arciero, psichiatra e valente studioso del pensatore dell’Essere, è aperto dalla Premessa del prof. Francesco Alfieri, assistente privato di von Herrmann fino alla scomparsa dello studioso e da poco nominato garante scientifico della pubblicazione delle opere di Heidegger presso il gruppo Morcelliana.
- ...
- Alfieri ricorda, contestualizzandole, le polemiche intercorse tra gli eredi del filosofo tedesco e Franco Volpi, al momento dell’uscita della sua traduzione italiana dei Contributi. Volpi non avrebbe rispettato, a dire degli eredi, le direttive contrattuali stipulate da Heidegger con l’editore Klostermann, alla luce delle quali i curatori e/o traduttori, nelle postfazioni, non avrebbero dovuto esprimere giudizi sui contenti delle opere del pensatore di Meßkirch, né far riferimento alla sua vita privata. Volpi, al contrario, nella chiusa dello scritto che accompagnava l’edizione italiana dei Contributi, rilevò come, di fatto, in queste pagine, il pensiero del tedesco fosse imploso su se stesso. Fece, inoltre, riferimento a carteggi dai quali emergeva la crisi personale che investì Heidegger negli anni 1936-38. Al di là delle polemiche, ci pare debba essere riconosciuto a Volpi un ruolo di primo piano nella diffusione della filosofia heideggeriana nel nostro paese. Ma veniamo al Commentario di von Herrmann: si tratta di un libro importante, frutto della lettura, lungamente ponderata, del manoscritto dei Contributi. Sintesi, inoltre, dei numerosi colloqui intrattenuti in tema dall’autore con il filosofo stesso, regolarmente trascritti da von Herrmann e divenuti oggetto dei corsi che questi tenne presso l’Università di Friburgo.
- ...
- I Beiträge furono redatti tra il 1936 e il 1937: «dopo un lungo lavoro di preparazione iniziato nell’autunno del 1932» (p. 17), e il loro contenuto aleggia su tutte le opere successive del pensatore. Von Herrmann si decise a riordinare il materiale in suo possesso nel 2014, a seguito delle polemiche divampate attorno ai taccuini di Heidegger. Obiettivo perseguito dalle pagine del Commentario, è quello di sottrarre la filosofia del pensatore dell’Essere a fraintendimenti indotti dalla complessità del suo linguaggio. I Contributi hanno, quale incipit, lo scritto “Sguardo preliminare” e sono costituiti da sei “combinazioni”: “La risonanza”; “Il gioco di passaggio”; “Il salto”; “La fondazione”; “I venturi”; “L’ultimo dio”. In quest’ultima “combinazione”: «si completa tematicamente il cammino di configurazione della fuga delle verità dell’Essere» (pp. 17-18). Von Herrmann precisa che il titolo del testo heideggeriano è connotato, nella sua prima parte, da “tratto pubblico”, in quanto nella dimensione pubblica contemporanea, caratterizzata dalla ratio calcolante: «tutte le “parole fondamentali” sono state logorate e il “genuino riferimento” dell’uomo […] “alla parola” è andato distrutto» (p. 22). L’espressione Dall’evento del titolo ha, al contrario, a che fare con la “cosa” del pensiero, con l’epoca: «del passaggio dalla metafisica al pensiero conforme alla storia dell’Essere» (p. 22).
- ...
- Si badi, metafisica, in tale contesto, indica il tratto essenziale, a dire di Heidegger, della filosofia europea da Platone a Nietzsche (viva, ancora oggi, nella falsa contrapposizione di analitici e continentali, condividenti il medesimo impianto teoretico). La “domanda guida” della metafisica è stata ed è quella aristotelica: «che cos’è l’ente?». Di contro, la “domanda fondamentale” heideggeriana apre il domandare filosofico non solo all’ente, ma all’essere stesso: «nella sua sveltezza, radura, apertura» (p. 23). Heidegger e von Herrmann, rispettivamente nei Contributi e nel Commentario, si intrattengono sul momento del “passaggio” da una domanda all’altra. In tal modo: «si indica una differenza: è la differenza nel passaggio, tra il pensiero incipiente conforme alla storia dell’Essere e il pensiero venturo conforme alla storia dell’Essere che ha compiuto questo passaggio» (p. 23). Si tratta di un “itinerario” speculativo, di un “tentativo” che guarda ai “venturi”, a un “Altro inizio” della storia e del pensiero europei, intesi: «come ambiti dell’essenziale presentarsi dell’evento» (p. 25).
- ...
- La verità dell’Essere-evento richiede la trasformazione dell’uomo da “animale razionale” ad “esser-ci”. In esso il “-ci” è la verità gettata: «radura dell’Essere che progetta» (p. 26). Per tale ragione, in particolare nel secondo e nel terzo capitolo, von Herrmann rileva un’evidente continuità tra Essere e tempo del 1927 ed i Beiträge: «È in Essere e Tempo […] che si articola la prospettiva della trascendenza» (p. 27). L’analitica-ontologico esistenziale dell’esser-ci, elaborata nelle sue pagine, per Heidegger non era erronea, ma insufficiente. Nei Contributi, rileva von Herrmann, Heidegger ha messo in atto un mutamento immanente rispetto alla prospettiva del 1927. Pertanto, I Beiträge vengono considerati, dal nostro autore, la seconda grande opera, al pari di Essere e Tempo, del filosofo dell’Essere. Va segnalato, inoltre, che l’impianto esegetico di von Herrmann mira a “cristianizzare” la filosofia di Heidegger, come si evince dal capitolo dedicato all’“Ultimo dio”. Questo tema in Heidegger, e l’autore del Commentario ne ha contezza, non rinviava affatto al dio del cristianesimo, per la qualcosa la tesi di von Herrmann, pur risultando plausibile, possibile, è filologicamente non attendibile.
- ...
- L’interna unità della filosofia di Heidegger che emerge dal Commentario, a parere di chi scrive, conferma il giudizio complessivo che Karl Löwith formulò sulla filosofia del Maestro: tanto nel primo Heidegger, quanto in quello successivo alla Svolta, permane un residuo storicista. Nei Contributi si evince uno spostamento invertente rispetto al volume del 1927: nella prima fase speculativa l’essere veniva inteso come storico, legato al tempo, nella seconda, quella evenienziale, l’essere si manifesta nella sua processuale epocalità, che è, a sua volta, di natura storica. Il libro di von Herrmann, comunque lo si legga, è un capitolo rilevante della bibliografia critica heideggeriana contemporanea.
-
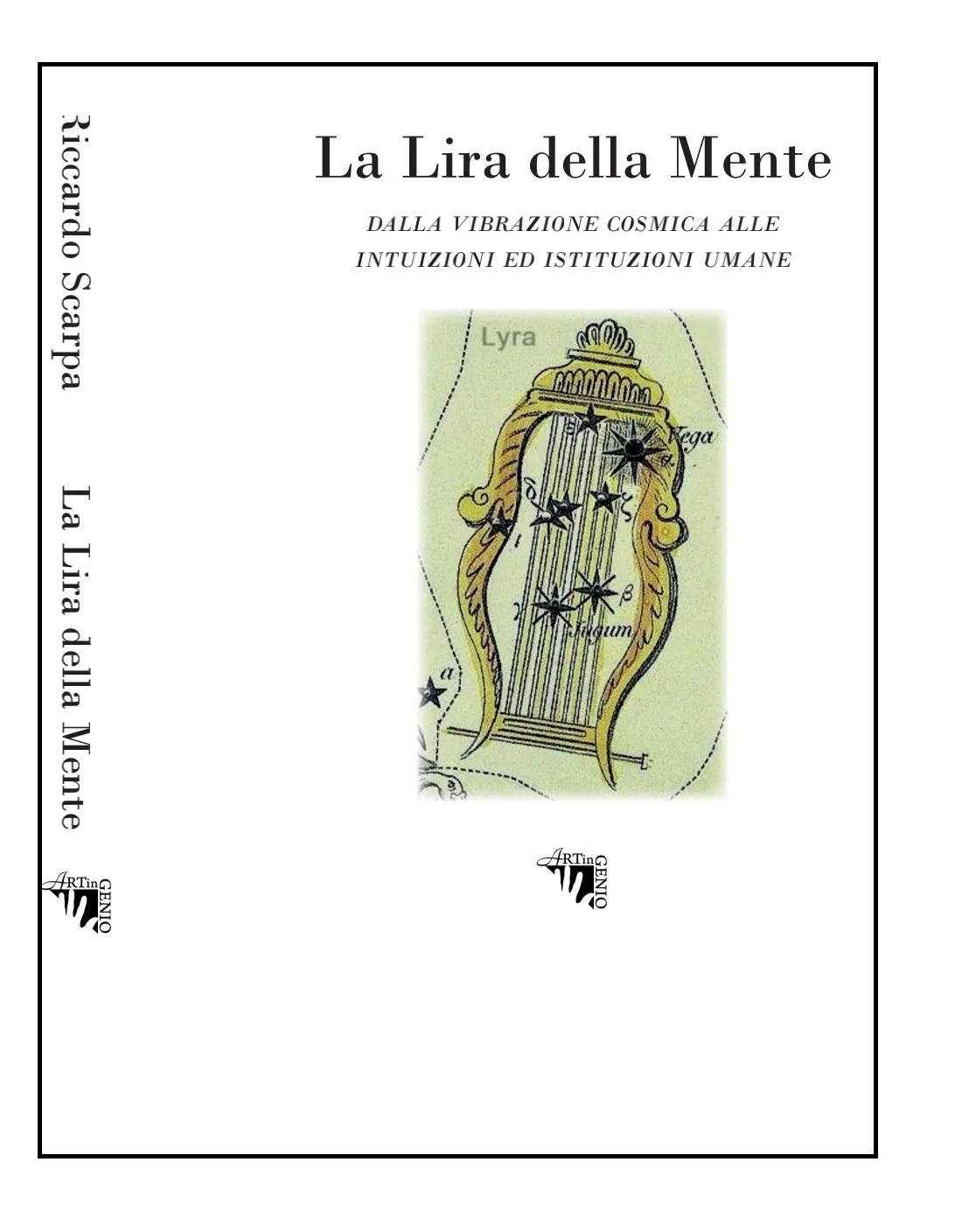
"La Lira della Mente"- Un saggio monumentale di
- Riccardo Scarpa
- rec. di
- Giovanni Sessa
Riccardo Scarpa è studioso di vaglia del mondo della Tradizione. È autore di profonda cultura. In lui il sapere è testimonianza di vita: possiamo affermalo per l’amicizia che ci lega, quanto per il confronto che intratteniamo da tempo con le sue opere. Il suo sapere dice una ricerca inesausta, partecipata nelle vive carni, “patita” sotto il profilo esistenziale e spirituale. Nel suo ultimo libro, testo monumentale, mette in campo le vaste conoscenze dell’Antico di cui è in possesso, oltre a una non comune padronanza della bibliografia critica in tema. Ci riferiamo a, La Lira della Mente. Dalla vibrazione cosmica alle intuizioni ed istituzioni umane, nelle librerie per i tipi di ArtinGenio editrice (per ordini: 335/7789135, artingenio.museum@gmail.com, pp. 475, euro 35,00). Il volume è impreziosito dall’Introduzione di Antonio Girardi, Presidente della Società Teosofica Italiana e Direttore della Rivista Italiana di Teosofia. Nelle sue pagine, Scarpa inscena la ricerca intorno all’origine del cosmo, della vita, in un excursus che non conosce confini spazio-temporali. Si avvale di una documentazione assai vasta, di cui compie l’esegesi in termini critici e puntuali. Intendiamo dire che, in queste pagine, l’autore va alla ricerca dei germi della filo-sofia, prima della nascita della filo-sofia stessa.- ...
- È possibile asserire, quindi, che il nostro studioso porta a conclusione l’esperimento teoretico di Giorgio Colli, pensatore che rintracciò nel lógos aurorale ellenico un’evidente continuità con il mythos. Al fine di portarsi oltre la storia, quella statuita dagli “storiografi” moderni, Scarpa tiene in conto l’indicazione di Bachofen: l’Antico deve essere lasciato parlare con la “voce” che gli è propria, quella del Sacro e del divino. Gli “occhiali moderni”, positivisti e storicisti in particolare, ne hanno tacitato l’ubi consistam. Si badi, la lettura di Scarpa è empatica, ma attenta alle fonti, la sua è un’ermeneutica, pertanto, “oggettiva”. Ogni civiltà, ci dice, è il risultato di disparate realizzazioni di modelli e archetipi universali. L’incipit del reale cosmico-storico è individuato nel punto vibrazionale dell’origine. In ciò, lo studioso è memore della lezione, se abbiamo ben inteso, di Schneider, in particolare è attento al tema del suono originario, ma anche ai collegamenti che legano tale vibrazione allo sviluppo filo-sofico e delle istituzioni umane. Per coglierli, è necessario guardare alla physis. In essa: «tutti i regni sono interconnessi tra loro. Lo Spirito è la vita». Al centro di queste pagine è l’Unità della vita prodotta da un principio ineffabile, inconoscibile, aporetico, che dà mostra di sé in cicli di espansione-manifestazione e di decadenza-distruzione.
- ...
- L’obiettivo dell’uomo di conoscenza è conseguire l’identità con il principio, oltre qualsivoglia dualismo indotto dal logo-centrismo, mirato a staticizzare la dynamis, la possibilità-potenza dell’origine. In tale contesto teorico, risulta dirimente la trattazione della tradizione sciamanica, messa a tema da Eliade. Lo sciamano, presso molte tradizioni, è uomo iniziato da dèi e spiriti, soggetto dotato di capacità innate che gli consentono di fare esperienza di stati dell’essere preclusi al senso comune. Egli conosce l’invisibile nel visibile che lo custodisce. Le due dimensioni, pur nella diversità, risultano intimamente connesse, si tratta di trascendenza immanente. Rilevante, nelle pagine del volume, risulta essere l’analisi delle principali Scuole filo-sofiche dell’Oriente. Scarpa si intrattiene sull’ancestralità dei Veda e delle Upanishad, posta ben oltre l’età assiale del VI secolo a. C.
- ...
- La riposta Sapienza Vedica fu trasmessa oralmente, per generazioni, da Maestro a discepolo. Inoltre, la predicazione del Buddha ha evidenti parallelismi con la Sapienza greca, in particolare con Pitagora. Le analisi dello studioso investono la cultura della Persia antica, della tradizione mediterranea, dall’Egitto alla Caldea, dalla civiltà ebraica all’Ellade dei primordi. Il Pitagorismo è interrogato, a differenza di quanto accade nella moderna storiografia filosofica, a muovere da Diogene Laerzio. I critici moderni: «non sanno quanto il mito veli intuizioni della verità, ben più, di quanto non contenga la mera storiografia». La Scuola Italica mirò, praticando la ricerca dell’armonia con le potestates animanti la physis, a realizzare una “repubblica cosmica”, tesi, per certi tratti, prsente anche in Reghini. Tale tentativo era ancora in essere nella filosofia classica socratico-platonica-aristotelica, come era solito ricordare, memore della lezione di Voegelin, Gian Franco Lami, fondatore della Scuola Romana di Filosofia politica, di cui il nostro autore fu ottimo comes. Scarpa, indaga, nei medesimi termini, la tradizione romana, imperniata su: «intuizione spirituale e fatto storico». L’esegesi della romanità è sviluppata attraverso opere prodotte tra XX e XXI secolo, ma anche sulla lettura “mitizzante” di Virgilio e Tito Livio.
- ...
- Particolare rilevanza riveste, per Scarpa, l’opera che Giovanni Antonio Colonna di Cesarò dedicò alle origini di Roma nel 1938, fondata sulla volontà di interpretare il dato “occulto” tralignante dai dati meramente “materiali”, propri della storiografia critico-accumulativa.Viene richiamato, nel testo, anche il lavoro dell’archeologo Andrea Carandini. Questi legò la storia di Roma al suo passato mitico, sacro, nel quale operavano Re e Sacerdoti: «Uomini di religione oltre che di ragione». Inoltre, con Aldo Ferrabino, l’autore vede nell’idea di Nazione fatta propria dai Romani: «Il superamento di quella concezione etnica, di razza, limite delle città greche». Altro tema di interesse è la “discontinuità di delega” dei Cesari, stante la lezione di Paul Veyne. Il grandioso e ricchissimo excursus messo in scena da Scarpa trova conclusione nel capitolo, Misteri cristiani ed Impero dei Romani. Gli originari Misteri, a dire di Scarpa, ereditati dal Cristianesimo, ebbero tratto Teosofico, dicevano di un Theós facente riferimento non già a un Dio Padre, ma al “divino” (che fu proprio dello stesso Giuliano Augusto) che tutto metamorfizza e che è in noi. In origine, quindi, la traslazione dei Misteri nel Cristianesimo non scisse la dimensione sacra da quella profana. La scissione si manifestò, più tardi, con l’imporsi del solo lato esterioristico dei Misteri stessi.
- ...
- Il libro di Scarpa, ricorda Girardi, è antidoto alla visione gnoseologica e teologica dualista oggi imperante, è espressione del sapere Teosofico. Per coglierne appieno il senso, il lettore deve attivare in sé la dimensione intuitiva, atta a svelare la Storia e la Natura quali topoi dell’intrecciarsi di simboli rinvianti all’Uno.
-
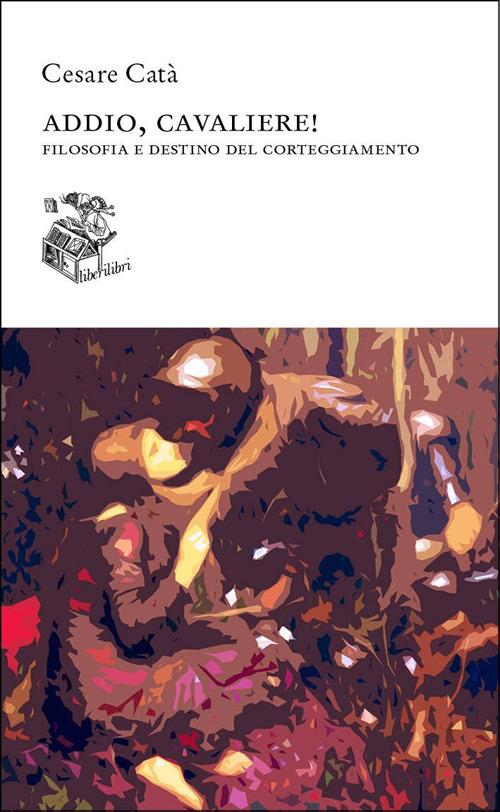
Filosofia e destino del corteggiamento- Un saggio di
- Cesare Catà
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Cesare Catà, filosofo e performer teatrale, è autore di diversi scritti teoretici e letterari. Studioso, tra le altre cose, di mito e fiabe ha, di recente, dato alle stampe la sua ultima fatica, Addio, Cavaliere! Filosofia e destino del corteggiamento, comparsa nel catalogo dell’editore Liberilibri (pp. 204, euro 16,00). Un volume originale, singolare, nel quale l’autore, interrogandosi sul senso profondo del corteggiamento e nel tentativo di rispondere a tale quesito, perviene a un’esegesi di Eros, dell’Amore, inteso quale quint’essenza delle nostre vite.
- ...
- Il volume, come è dichiarato esplicitamente fin dall’incipit del sue pagine è, al contempo, saggio e racconto intimo. Catà, per comprendere ogni tratto, senso, significato e i rituali propri del corteggiare, muove dal proprio vissuto, dall’analisi dell’emozione che, sempre, accompagna l’inizio di un amore. Egli parte dalla sconsolata considerazione che l’arte del corteggiare sia venuta meno, o si sia stata degradata nella società liquida, nella quale tutti viviamo. Le intenzioni dello scrittore, si badi, non sono mosse da mera nostalgia reazionaria per un passato che non è più. Al contrario, egli sostiene che, ancora oggi: «il corteggiamento […] possa (può) darci un orizzonte unico e luminoso per condividere parte del nostro passaggio terrestre con una persona che ci attrae» (p. 13) e, per questo, può rivestire un ruolo risolutore per le nostre esistenze.
- ...
- L’attrazione per un'altra persona è qualcosa di misterioso, espressione tangibile del misterium vitae che condividiamo con gli altri enti di natura. A differenza degli animali e delle piante, condizionati in termini biologico-istintuali alla mera riproduzione fisica, gli uomini possono rispondere al magnetismo erotico, all’attrazione per l’altro, in modalità non condizionata, aperta e problematica. Siamo, in fondo, enti capaci di modificazione, sempre esposti al possibile: «La molla psicologica e metafisica che ci spinge eroticamente verso un altro soggetto è composta di un materiale invisibile e non analizzabile»(p. 19), che si sottrae alla significazione concettuale. L’analisi del corteggiamento umano rivela, nota Catà, il tentativo di: «piacere per piacere. Si corteggia qualcuno perché essere amato […] è per la creatura umana, fonte di una profondissima soddisfazione psicologica e fisica» (p. 25). Il corteggiamento innalza il linguaggio convenzionale a livello poetico e, in tale circostanza straordinaria, mutiamo perfino la postura, il linguaggio del corpo. Nel corteggiamento entra in scena il dio Eros, figlio di Afrodite dea della pienezza gioiosa e non semplicemente di Penia, dea della mancanza, come avrebbe voluto Platone nel suo riproporre nel Simposio il mito dell’Androgine. La mancanza, infatti, sollecita a soddisfare, sic et simpliciter, un bisogno, l’Eros afroditico, di contro, consiste nel: «godere di qualcosa per se stessa» (p. 28).
- ...
- Tale Amore non è soteriologico, non salva, può addirittura dannare, come nelle corde dell’Amor Cortese, fiorito tra l’XI e il XII secolo: «secondo il quale amare significa adorare un altro essere umano sentito come qualcosa di divino e miracoloso» (p. 29). Un Amore questo che non può essere compreso dal riduzionismo interpretativo biologico (riproducibilità/compatibilità) o psicanalitico freudiano (ipotesi anaclitica e narcisistica), in quanto si tratta di una potestas che non appartiene al Regno dell’Io e delle certezze epistemiche. Il bosco, la selva, Regni di Artemide sottratti al confine segnato dalla vita cittadina e politica, sono i luoghi del corteggiamento e dell’incontro con la potenza cosmica, la dynamis sempre all’opera e mai normabile nella physis. Ne ebbero contezza tanto Shakespeare che Ariosto. Questi compresero che il momento dell’attrazione erotica ammutolisce il nostro Io, ci fa piombare nel silenzio, vera musica del cosmo. Si tratta di un’esperienza non dissimile da quella che viviamo passeggiando nei giardini, in particolare quelli all’inglese. In essi, ha sostenuto Merleau-Ponty, viviamo un’“atmosfera”, siamo attratti da quel “non so che” che lì costituisce, ben al di là dei processi di “fattorizzazione” concettuale, e che è impossibile definire. Ecco, la persona che ci attrae e che tentiamo, con gentilezza e cortesia, di corteggiare è latrice di tale occulta proporzione, di tale indefinibile “non so che”. L’emozione suscitata in noi, induce: «il desiderio misterioso di mescolare la (nostra) esistenza con quella di un altro» (p. 44), del quale, in quel momento, non sappiamo nulla.
- ...
- Amare e corteggiare quell’Unico, s-determina, come avviene nell’arte autentica, la nostra individualità, la pone in congiunzione con l’altro, rendendoci sempre aperti al novum rappresentato, oltre l’Io, dal Sé. In tale circostanza ci liberiamo della maschera, dei ruoli sociali, in un processo identificativo con il dio che ci investe, Eros-Dioniso. Nell’Amore, come sosteneva Simone Weil, scopriamo la consistenza, la realtà, la carnalità dell’altro, ci sottraiamo al sogno notturno dell’irrealtà delle cose ed incontriamo, come il cosmo al termine dell’inverno, l’incipit vita nova. Il verbo greco manomai, “corteggiare” è un derivato di mimnesco che fa cenno: «a una specifica cognizione che la psiche ha acquisito […] avendola “a cuore” (ri-cordo)» (p. 61). In tal senso il corteggiare preserva la consistenza del cosmo e può rappresentare una risposta alla liquefazione della realtà attualmente in atto.
- ...
- Nel mondo contemporaneo è svanito l’“enigma dell’alterità”, trasformata in “semplice presenza” virtualmente riproducibile e, ormai, priva di “aura”: «L’altro ha cessato di essere Unicus» (p. 177) e, al contempo, il “femminile” ha smarrito la propria statura divina. In tale contesto storico-esistenziale, tornare a corteggiarsi può diventare: «la forma attraverso la quale ci svincoliamo da un destino inautentico» (p 191).
- ...
- Per chi scrive, sarebbe forse necessario tener conto della lettura della potenza d’amore di Julius Evola e della sua Metafisica del sesso, opera dalla quale si evince come Eros sia energeia della physis, atta a condurci oltre le mortifere regioni segnate dall’Io e dagli idola della contemporaneità.
-
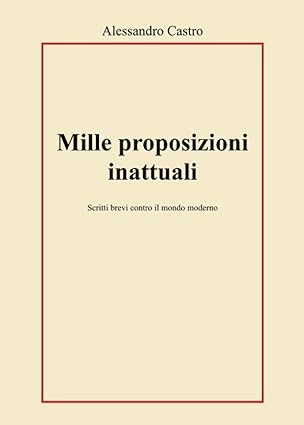
Le mille proposizioni inattuali - di
- Alessandro Castro
- "Scritti brevi contro il mondo moderno"
- rec. di
- Giovanni Sessa
Negli ultimi anni, nella società liquida, si è avuta una vastissima produzione letteraria e filosofica antimoderna. In tale congerie intellettuale, è inscritto il libro di un giovane e coraggioso studioso siciliano, Alessandro Castro. Si tratta di una silloge di aforismi, Mille proposizioni inattuali. Scritti brevi contro il mondo moderno, pubblicato dall’autore tramite la piattaforma Youcanprint (per ordini: info@youcanprint.it, pp. 149, euro 15,00). - ...
- Fin dall’incipit di queste pagine, Castro esplicita l’obiettivo che si è prefisso nel pubblicare questo testo: «organizzare una dura e decisa risposta alla confusione che pervade i tempi presenti» (p. 9). Gli aforismi sono raccolti in tredici capitoli e in una Conclusione. Il giovane studioso mostra di aver fatto propri gli assunti del “tradizionalismo integrale” del Novecento, corrente di pensiero che ha prodotto una critica radicale del moderno. Muove, infatti, dal presupposto che esistano due forze sovrastoriche e sovraindividuali, la prima, anagogica e spirituale, la seconda katagogica e materiale: «L’edificio da abbattere è la modernità; da edificare è quello della speranza uranica e perenne, incarnato dalla Tradizione» (p. 11). L’intero libro è, di fatto, una chiosa, una chiarificazione di tale affermazione assiomatica.
- ...
- Preliminarmente, il giovane siciliano afferma che: «Come fondamento ontologico e veritativo della Tradizione vi è l’Uno» (pp. 12-13) e che l’epoca post-moderna: «non è altro che una fase avanzata di quella moderna; la dicotomia Tradizione/modernità, di fronte a essa, rimane quindi inalterata» (p. 13). La Tradizione può, in tale prospettiva, venire momentaneamente obliata, ma non può essere definitivamente tacitata. La modernità, del resto, è surrogato parodistico ed invertito della Tradizione. Nell’attuale contingenza storica, essa ha trovato compiuta espressione negli pseudo valori della Nuova Cartagine, incarnata dalla civilizzazione angloamericana, utilitaristica e globalizzante. Sua quint’essenza è da rilevarsi non nel caos che la costituisce e che esprime, sic et simpliciter mancanza d’ordine: «ma in un ordine che è totalmente rovesciato», (p. 20) incapace di riconoscere ciò che davvero distingue gli uomini, insensibile ai valori dell’areté e della noesis. In tale contesto, risulta dominante una razionalità priva di Lógos, statistica, quantitativa ed algoritmica: «Denaro, società dello spettacolo, feticismo delle merci: i tre virtuosissimi capisaldi della modernità» (pp. 24-25). Essi rendono la modernità simile a una bolla di sapone che potrebbe dissolversi con incredibile facilità.
- ...
- L’intero libro è un appello accorato alla: «Rivolta metafisica contro il mondo moderno» (p. 37), atta a mettere in scacco l’egemonia dell’Io centrata su orgoglio, superbia prometeica e invidia: «Nel momento […] in cui si riesce a distaccarsi dall’Io caduco e manchevole si crea quel vuoto che non può che essere colmato dalla spiritualità primordiale» (p. 43). Essa è fondata sul mètron, la giusta misura. Molto interessante e prossimo alla nostra sensibilità è la ripresa, da parte di Castro, dell’elogio della giovinezza di Leopardi: «Non è spento nei giovani l’ardore che li porta a procacciarsi una vita e a sdegnare la nullità e la monotonia» (p. 47). Tale ardore ha permesso, di generazione in generazione, il perpetuarsi della Tradizione. La giovinezza spirituale è connotato interiore dei “clandestini”, dei “resistenti” al potere pervasivo e subdolo della modernità liquida. Leggiamo, poco dopo: «L’oppositore più radicale si identifica nella figura di un anti-Prometeo come il restauratore dell’unico ordine naturale possibile, quello in cui la natura fisica rimane sottomessa» (p. 55). L’aspetto per cui dissentiamo dalle posizioni di Castro sta tutto qui. Se la Tradizione è l’Uno, qualsivoglia posizione dualista gli è estranea. A parere di chi scrive, tra i “tradizionalisti” del Novecento, solo Evola, nelle sue opere teoretiche scritte prima dell’incontro con Guénon, comprese che nel mondo tradizionale essenza ed esistenza, corpo e spirito, essere e nulla si dicevano in uno, in un rapporto tragico, in quanto come intese Hölderlin, mai chiuso in un terzo dialettico ma sempre in fieri. L’Evola idealista magico ebbe chiara contezza che parlare di sovranatura o sovrastoria, implicava abbracciare categorie statuite dal moderno. La visione tradizionale della storia non può essere ciclica, ma sferica (stante la lezione in tema di Nietzsche, Heidegger, Locchi) in quanto il principio, l’origine è dynamis, libertà-potenza, mai normabile negli enti di natura e negli eventi della storia. La visione ciclica altro non è che una versione invertita di quella lineare, nella quale il tempo ha un inizio e una conclusione. Si tratta di una concezione chiusa, non aperta della storia.
- ...
- Castro ci pare aderire a un’impostazione rigidamente “tradizionalista”, tutta giocata sulla contrapposizione di Tradizione e modernità. Tale visione, finisce per sposare il male che vorrebbe combattere, vale a dire l’atteggiamento neo-gnostico, centrato sulla volontà di emendare, correggere il mondo, in un pathos salvifico ed escatologico: «Il sistema mondo angloamericano, col suo seguito di falsi idoli, non è altro che il Regno del Male Assoluto» (p. 93). Non casualmente, nei pensieri di questo giovane autore, aleggia (non citato) il pensiero di Dugin. È, forse, per la stessa ragione, che Castro, dopo aver criticato aspramente Bergoglio, pare cogliere nel cattolicesimo tradizionalista una possibile via di uscita dallo stato presente delle cose. Chi scrive è lontano da qualsivoglia posizione di teologia della storia o di filosofia della storia e guarda con interesse, con Karl Löwith, al recupero della physis ellenica e del tragico. Ciò implica il rigetto del determinismo consolatorio, sia di segno progressivo che reazionario.
- ...
- Nonostante queste differenze di prospettiva, riteniamo che il volume di Castro possa svolgere il ruolo di sasso lanciato nello stagno. L’autore padroneggia abilmente la lingua: il suo testo è di godibilissima lettura. Il giovane studioso, per le idee che diffonde e difende, non avrà accoglienza nel mondo culturale contemporaneo. È solo, come molti della sua generazione, in un mondo ostile che non conosce più, non dico Maestri, ma neppure guide.
- ...
- Probabilmente mi considererà, come scrive nella Premessa, “uno degli idioti” che si sono fatti avanti per criticare il suo libro. Non è così, non sono scandalizzato dalle sue idee, né mi scandalizza l’epiteto “idiota”. Solo gli “idioti”, i “folli” i “ribelli” e gli “eretici”, coloro che mettono in discussione il “senso comune”, perfino quello “tradizionalista”, potranno difenderci dal domino del Medesimo nel quale viviamo.
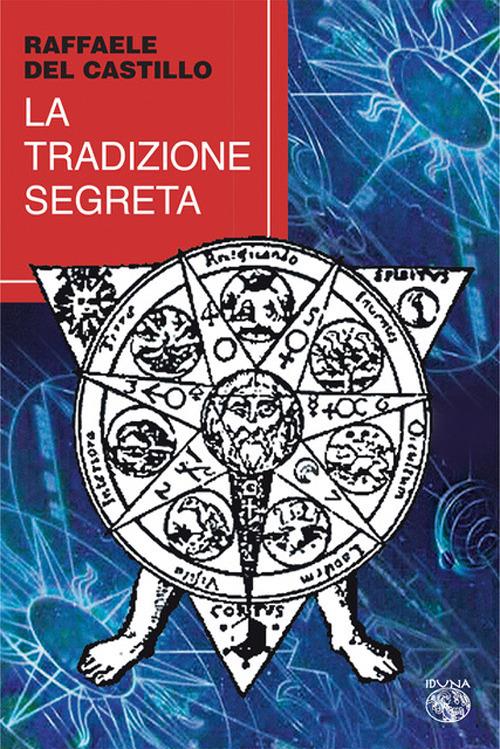
Massoneria e Tradizione segreta- Un saggio di
- Raffaele Del Castillo
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Raffaele Del Castillo è stato autore assai attivo nella prima metà del secolo XX. Tra i suoi lavori, vanno segnalati la biografie di Carlo Alberto e un saggio storico dedicato a Napoleone III e alla sua epoca. Nella vasta produzione di questo studioso un posto a sé occupa il volume, La Tradizione segreta, uscito in prima edizione nel 1940, ora riproposto nel catalogo Iduna (per ordini: associazione.iduna@gmail.com, pp. 226, euro 20,00).
- ...
- Nelle sue pagine l’autore si confronta con quella che definisce una: «curiosa leggenda […] che è servita di base a tutto un sistema mistico, tra il religioso e il filosofico, offerto alla venerazione del mondo attraverso una delle più originali montature che conosca la storia» (p. 5). Del Castillo si riferisce, di fatto, alla “Tradizione segreta” a cui si sarebbe ispirata, nel corso dei secoli, la Massoneria. Il libro vorrebbe rappresentare una disamina oggettiva, scientifica e storica di tale tradizione. L’affermazione appena ricordata, di contro, testimonia l’atteggiamento pregiudiziale nei confronti dell’oggetto indagato da parte dello studioso. Badi il lettore, ciò non implica che questo saggio non abbia alcun valore.
- ...
- Pregevole è, innanzitutto, l’elegante e raffinata prosa dello scrittore, atta a coinvolgere, chi abbia la ventura di incontrare queste pagine, nel narrato. Inoltre, risulta decisamente interessante e condivisibile la prima parte del volume. In essa, vengono ricostruite le tappe storiche attraverso le quali è sorta la “leggenda” della “Tradizione segreta”. Le vicende muovono dalla costruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme da parte dell’architetto Hiram. Questi eresse due colonne nel vestibolo del Tempio, Jachim e Booz, sormontate da fregi a forma di giglio. Hiram, a parere di quanti diffusero la “leggenda”, sarebbe stato in possesso di due forme di sapere: il primo inerente la dottrina delle tecniche costruttive, il secondo riguardante una dottrina mistica ineffabile, dai tratti religiosi. I suoi discepoli furono divisi in tre gruppi: gli apprendisti, i compagni e i maestri. A ognuno di essi corrispondeva un grado diverso di conoscenze. Tale “Ordine” diffuse segretamente questa sapienza: «la dottrina hiramica, denominata modernamente “Tradizione segreta”, sopravvivendo miracolosamente al crollo della civiltà ebraica […] si sarebbe trasmessa di iniziato in iniziato, fino al decimo settimo secolo dopo Cristo» (p. 12).
- ...
- Essa sarebbe riemersa, dapprima, in Pitagora e nella sua Scuola, all’interno della quale, il filosofo-taumaturgo, mantenne vivi i tre gradi di iniziazione. Attraverso Numa Pompilio si sarebbe affermata a Roma. Questo Re, a dire di Del Castillo, avrebbe, attraverso i colloqui con la ninfa Egeria e alla luce delle rivelazioni ricevute, fondato le corporazioni degli artefici, Collegia artificum. In essi, alle attività di ordine costruttivo, si affiancavano rituali sacri. Con l’estendersi dell’Impero, tali sodalizi assunsero sempre maggiore importanza, fino a eclissarsi, apparentemente, dalla storia, con la fine della stessa compagine statuale romana. Dei loro rituali sarebbe testimonianza un mosaico rinvenuto a Pompei nel 1878, in un locale ubicato nei pressi del tempio di Iside. I simboli in esso presenti sono gli stessi utilizzati dalla Massoneria moderna. Il problema, rileva Del Castillo, è che a seguito della persecuzione cui i Collegia furono sottoposti da Diocleziano, dopo che questi divennero ricettacolo di cristiani, non consente di documentare storicamente la continuità iniziatica. Il vuoto documentale sarebbe stato riempito da una nuova “leggenda”, quella dei “Maestri comacini”. Nel Medioevo gli appartenenti a tale sodalizio avrebbero indossato: «un grande grembiule di cuoio e guanti bianchi» (p. 27). Dalle Compagnie dei Franchi Muratori sarebbe sorto il nuovo stile gotico. I Maestri godevano, per i loro spostamenti, finalizzati all’erezione delle cattedrali, di grande libertà, da cui l’appellativo di “liberi muratori”. Tra essi si distinsero Erwin e Giovanni von Steinbach, che realizzarono il Duomo di Strasburgo: «Determinate formule presiedevamo all’iniziazione e al giuramento delle tre gerarchie degli apprendisti, dei compagni e dei maestri» (p. 35).
- ...
- Del Castillo analizza la penetrazione dei “franchi muratori” In Inghilterra, discute la fondazione della Massoneria inglese e si intrattiene sul suo disegno utopistico e anti-cristiano, a suo dire chiaramente espresso nella Nuova Atlantide di Francesco Bacone. Affronta, inoltre, il sorgere del mito dei Templari e del Rosa+Croce e procede alla critica della “leggenda” rilevandone, sostanzialmente, l’a-storicità. In particolare, sostiene, che la tradizione ebraica mal tollerava il fiorire di sette e che non esisterebbe prova documentale di una sua ibridazione con la dottrina pitagorica. Il simbolismo del mosaico di Pompei si riferirebbe esclusivamente alle tecniche costruttive e non ad un sapere riposto, “segreto”. Viene meno, pertanto, in questa esegesi, il tema della continuità iniziatica che legherebbe la “Tradizione originaria” con i “liberi muratori”. La ripresa di tale tema in età moderna, si inserirebbe, pertanto, nel progetto anti trascendente, inaugurato dalla Riforma e portato a termine dalla Rivoluzione francese: «Il connubio, inventato dalle logge inglesi […] non può produrre se non un ibrido mostro. E tale appare veramente nell’evo moderno: la Tradizione segreta è divenuta patrimonio e dottrina programmatica della Massoneria» (p. 221).
- ...
- Il limite dell’esegesi dell’autore è dato dal suo pregiudizio anti-iniziatico, teso alla difesa esclusiva della visione cristiano-cattolica della vita. La “Tradizione segreta”, certamente tradita dalla Massoneria moderna, come rilevò Evola, ha dato i propri frutti migliori nel “pensiero di Tradizione”, in particolare nel Novecento filosofico. Ma di tali esiti, Del Castillo, non si occupa. Il suo è uno studio parziale, condivisibile nelle premesse, ma non nelle conclusioni.
- VESPAIOTENE
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- L’ultimo vespaio suscitato dal discorso della Meloni alla Camera per le citazioni del “Manifesto” di Ventotene, si presta ad una serie di considerazioni, che vado ad enumerare:
- ...
- 1) Come succede spesso il “Manifesto” è assai più citato che letto, e i di esso estimatori (di professione) non hanno l’accortezza di citare i passi interpretati (magari corredandoli con l’indicazione relativa come i versetti della Bibbia o i frammenti del Digesto). Per cui complicano il lavoro del lettore curioso che voglia approfondire e controllare. A pensar male la prassi sarebbe volontaria, con l’effetto (voluto) di ascrivere a Rossi o a Spinelli le idee dell’interprete.
- 2) Le affermazioni del “Manifesto” citate dalla Meloni – e comunque oggetto della discussione, concernono idee che, all’epoca della redazione del “manifesto” (1941) erano diffuse e dibattute, in particolare tra intellettuali e politici.
- Le ricordiamo: “La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria” e “Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente” (sulla democrazia).
- ...
- E sul carattere dell’auspicata rivoluzione “La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista”.
- ...
- Sulla proprietà: “la proprietà privata dei mezzi materiali di produzione deve essere in linea di principio abolita e tollerata solo in linea provvisoria quando non se ne possa proprio fare a meno… La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio”.
- ...
- Sul rapporto tra popolo e partito dirigente: “Durante la crisi rivoluzionaria […] (il movimento, ndr) attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto non da una preventiva consacrazione da parte dell’ancora inesistente volontà popolare, ma dalla coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società… Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo Stato, e intorno a esso la nuova vera democrazia”.
- ...
- Tutte tali affermazioni, inequivocabili, corrispondono a convinzioni allora diffuse, ma che le vicende successive – e la stessa evoluzione di Rossi e Spinelli – hanno cambiato spesso radicalmente. Ernesto Rossi fu un benemerito sostenitore del liberismo contro i monopoli; Spinelli fu a favore del Piano Marshall e nel corso della sua carriera politica, pur sempre di sinistra, non risulta che avesse posizioni o prassi simili a quelle esposte nel Manifesto prima sintetizzate.
- ...
- Fa in particolare impressione il rapporto tra rivoluzionari e masse (sia movimenti politici che cittadini comuni). Quanto ai primi nel manifesto si criticano i partiti (e loro dirigenti) democratici: che questi «Credono nella “generazione spontanea” degli avvenimenti e delle istituzioni, nella bontà assoluta degli impulsi che vengono dal basso. Non vogliono forzare la mano alla “storia” al “popolo” al “proletariato” o come altro chiamano il loro dio… Sono perciò dirigenti adatti solo nelle epoche di ordinaria amministrazione, in cui un popolo è nel suo complesso convinto della bontà delle istituzioni fondamentali, che debbono essere ritoccate solo in aspetti relativamente secondari. Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente».
- ...
- Il popolo, nelle situazioni rivoluzionarie è disorientato «Mille campane suonano alle sue orecchie, con i suoi milioni di teste non riesce a raccapezzarsi, e si disgrega in una quantità di tendenze in lotta tra loro» e conseguentemente «i democratici si sentono smarrirti non avendo dietro uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultuare di passioni; pensano che loro dovere sia di formare quel consenso, e si presentano come predicatori esortanti, laddove occorrono capi che guidino sapendo dove arrivare… Man mano che i democratici logorassero nelle loro logomachie la loro prima popolarità di assertori della libertà, mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immancabilmente ricostituendo le istituzioni politiche pretotalitarie, e la lotta tornerebbe a svilupparsi secondo i vecchi schemi della contrapposizione delle classi».
- ...
- Anche i comunisti, col loro classismo «costituiscono nei momenti decisivi un elemento settario che indebolisce il tutto» per cui «Una situazione dove i comunisti contassero come forza politica dominante significherebbe non uno sviluppo in senso rivoluzionario, ma già il fallimento del rinnovamento europeo». Invece il «partito rivoluzionario non può essere dilettantescamente improvvisato nel momento decisivo, ma deve sin da ora cominciare a formarsi almeno nel suo atteggiamento politico centrale, nei suoi quadri generali e nelle prime direttive d'azione… dalla schiera sempre crescente dei suoi simpatizzanti deve attingere e reclutare nell'organizzazione del partito solo coloro che abbiano fatto della rivoluzione europea lo scopo principale della loro vita… e costituiscano così la solida rete che dia consistenza alla più labile sfera dei simpatizzanti… Durante la crisi rivoluzionaria spetta a questo partito organizzare e dirigere le forze progressiste, utilizzando tutti quegli organi popolari che si formano spontaneamente come crogioli ardenti in cui vanno a mischiarsi le forze rivoluzionarie, non per emettere plebisciti, ma in attesa di essere guidate»[1].
- ...
- È evidente l’influenza del modello del partito rivoluzionario-totalitario e, soprattutto, l’insegnamento di Lenin. Il quale nel “Che fare?” scriveva: "...il “nostro compito pratico più urgente: creare un’organizzazione di rivoluzionari capace di garantire alla lotta politica l’energia, la fermezza e la continuità” e affermava “che non potrà esservi un movimento rivoluzionario solido senza un’organizzazione stabile di dirigenti che ne assicuri la continuità… che tale organizzazione deve essere composta principalmente di uomini i quali abbiano come professione l’attività rivoluzionaria”. È inutile poi ricordare il ruolo guida che, nel pensiero di Gramsci ha il partito rivoluzionario o la sua organizzazione tattico-insurrezionale (Malaparte). Giudizi in cui il consenso, la democrazia, la legittimità sono quasi sempre un impaccio, e comunque non costituiscono né una condizione né una preoccupazione. Secondo Malaparte alla tattica insurrezionale dei bolscevichi non servivano le masse, ma nuclei ristretti, esperti e organizzati. Tutto il resto delle citazioni della Meloni (estratte dalle più numerose conferme esposte nel Manifesto) concernenti socialismo, proprietà (dei mezzi di produzione) più che proprietà in genere, sono state superate dall’attuale EU, che sicuramente non è socialista, è contraria a ogni nazionalizzazione dei mezzi di produzione (e così via).
- ...
- Cos’è ancora vivo nel Manifesto di Ventotene, esaminandolo con un occhio realista? A mio avviso principalmente due cose: il giudizio che in un’epoca di potenze continentali, gli Stati nazionali sono superati non avendo una massa critica per competere con le superpotenze in essere o in fieri (oggi USA, Cina, India, Russia e forse Brasile). È un buon argomento per costruire uno Stato federale europeo come quello auspicato dal Manifesto. La seconda: che Rossi e Spinelli non credevano ad una “unione” che prescindesse dall’elemento decisivo perché unione ci sia: un potere sovraordinato ai singoli Stati, come scriveva il giovane Hegel sul Sacro Romano Impero (allora in via di estinzione), al quale mancava proprio quello. L’insistenza sul partito rivoluzionario e l’indifferenza verso il consenso e le procedure democratiche non è altro che la riproduzione nella prima metà del XX secolo della essenzialità per una sintesi politica di avere un centro unificatore supremo (Hegel). all’epoca del filosofo era il monarca assoluto, ai tempi di Rossi e Spinelli, era diventato il partito rivoluzionario che, esercitando la dittatura, costruiva un nuovo ordine. Al contrario dell’UE attuale, la quale ha unificato molte cose, ma non il potere (decisivo e superiore) ai singoli Stati, ma si è limitata ad alcuni “rami bassi”. Anzi in Italia è stato teorizzato il “vincolo esterno” che si presta a questa unificazione delle mezze misure. Dai tappi delle bottiglie in su. Cioè di ciò che non è (o è poco) politico.
- E, anche per ciò, il Manifesto, liberato da utopismo e condizionamenti d’epoca, può dirci ancora qualcosa.
- [1]
- I corsivi sono miei.
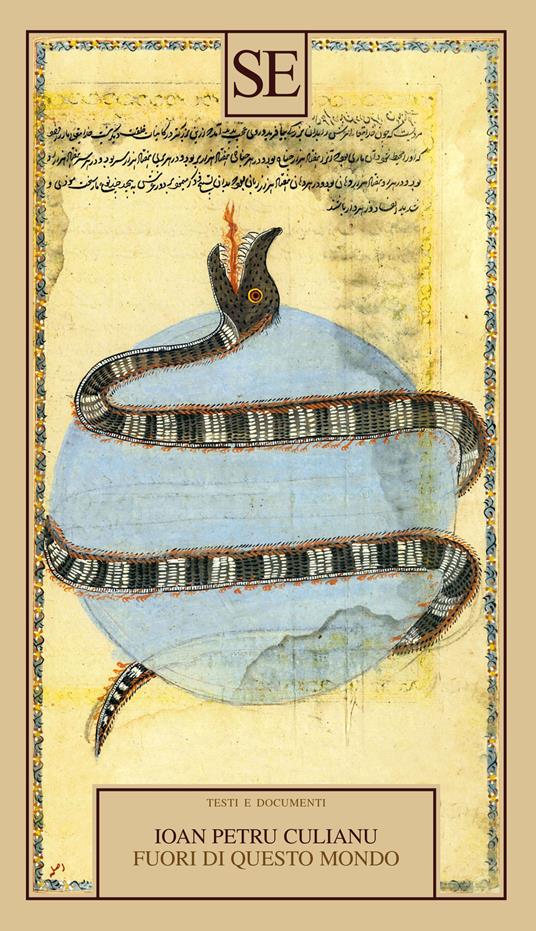
"Fuori di questo mondo"- Il testamento spirituale di
- Ioan Petru Culianu
- rec. di
- Giovanni Sessa
- È nelle librerie un libro davvero importante. Ci riferiamo a, Fuori di questo mondo di Ioan Petru Culianu, comparso nel catalogo SE (pp. 243, euro 26,00). Il volume è stato ben tradotto nella nostra lingua da Maria Sole Croce ed è impreziosito dalla postfazione contestualizzante di Federico Ferrari. Si tratta dell’ultimo libro dell’intellettuale romeno. Poco dopo avere ricevuto, nel 1991, le bozze di questo volume, Culianu venne assassinato, in circostanze tuttora misteriose e di cui molto é stato scritto, nei bagni della Divinity School dell’Università di Chicago, dove insegnava Storia del cristianesimo e Storia delle religioni. Il libro, tanto nel titolo quanto nei contenuti, rimanda al volume, Uscite dal mondo di Elémire Zolla, studioso con il quale, negli anni immediatamente precedenti, il romeno aveva intrattenuto proficui rapporti intellettuali, condividendo alcuni aspetti della prospettiva teorica del pensatore italiano. Ma chi era Culianu? Qual è stata la sua formazione?
- ...
- Nato, nella Romania comunista, in una famiglia borghese, fin dall’adolescenza mostrò una non comune versatilità intellettuale. Apprese, con facilità, molte lingue moderne, fu poliglotta, medesima propensione conoscitiva ebbe per le lingue antiche. La sua formazione universitaria fu di stampo umanistico, anche se il giovane evidenziò un interesse non comune per la scienza “ultima”, in particolare per gli sviluppi della fisica relativistica einsteiniana e, di rimando, per il dibattito epistemologico. Patì, non poco, il clima culturalmente claustrofobico del paese natale. Riuscì ad evadere da tale asfissia intellettuale, grazie a una Borsa ottenuta presso l’Università di Perugia. Giunto in Italia chiese asilo politico, subendo, in patria, un processo in contumacia. A Milano, sotto la guida di Ugo Bianchi, approfondì gli studi sullo gnosticismo, in particolare si occupò dell’esegesi di tale eresia in Hans Jonas. Si trasferì presto in Olanda e da lì giunse a Parigi. Nell’ambito storico religioso, suo riferimento imprescindibile è da considerarsi Mircea Eliade, maestro di un’intera generazione di intellettuali non-conformisti del paese danubiano. Sotto il profilo filosofico-teologico guardò al neoplatonismo rinascimentale e, nell’ultima fase di vita, alla Cabala e alla mistica ebraica. La lettura di Fuori di questo mondo rende edotti, ricorda Ferrari, che l’iter intellettuale di Culianu è stato segnato da evidente continuità: «l’estasi, le fuoriuscite dal mondo, dall’io, dalla parola sono le esperienze cui fin dalla gioventù egli aveva dedicato i propri studi» (p. 242).
- ...
- Eccolo, allora, attraversare, in forza di una straordinaria erudizione multidisciplinare, le più disparate tradizioni relative alle “uscite dal mondo”. Nel volume vengono chiamate in causa l’antica sapienza egizia, la visione taoista, la concezione della vita di quelli che Colli ha chiamato i Sapienti greci, qualsivoglia aspetto dei viaggi interplanetari, ultraterreni o nel regno di Ade. Le argomentazioni di questo esegeta d’eccezione coinvolgono il lettore in un viaggio spiraliforme, nel quale il tema della “fuoriuscita” dal senso comune (meramente empirista), si ripete di continuo, in modalità ossessiva. Nella scrittura di Culianu inizio e fine, come tutte le opposizioni dicotomiche, si confondono, si dicono in uno: egli mira, infatti, a un’apertura, a esporsi sull’origine.
- ...
- Ruolo dirimente, ai fini della comprensione del testo, a parere di chi scrive, è da individuarsi nei primi due capitoli. In essi lo studioso sostiene che: «il mondo esterno è un costrutto della nostra percezione […] privo di “oggettività” […] il mondo fuori di noi e il mondo dentro di noi […] non solo interferiscono tra loro […] ma è anche difficile capire dove finisca l’uno e dove cominci l’altro» (p. 16). Insufficienti risultano le spiegazioni che chiamano in causa la trasmissione genetica o l’esistenza di un inconscio collettivo che starebbe alle spalle delle testimonianze, antiche e moderne, di “uscite dal mondo”. Al contrario, è necessario guardare alla tradizione culturale, all’esistenza di sistemi di idee che tendono, nel tempo e nello spazio, a ripetersi, ogni volta in forma originale e differenziata. Si assiste a: «una rielaborazione continua di antiche credenze, che implica oblio, annullamento e innovazione continui» (p. 20), come nelle corde della filosofia di Andrea Emo, che riteneva la conoscenza essere, ab origine, legata all’oblio, la salvezza alla rinuncia a essa.
- ...
- Culianu, nel secondo capitolo, discute la possibilità dell’esistenza della “quarta dimensione” intuita da Hinton, che si riverberò nella fisica di Einstein. Dimensione presente anche in Flatlandia di Abbot, in Alice nel paese delle meraviglie di Carroll e, soprattutto, in Borges: «La quarta dimensione ci costringe ad accettare l’ipotesi che esistano molti livelli di realtà superiore», livelli non dissimili dagli Stati molteplici dell’essere di cui ha detto Guénon e dei quali ebbe contezza Gurdjieff. Se abbiamo ben inteso, categoria centrale, in questo libro, è quella dello “sciamanesimo”, stante la lezione in tema di Eliade, che vi lesse un insieme di tecniche estatiche mirate a realizzare il contatto con l’universo parallelo delle potenze cosmiche, a beneficio dei singoli e delle comunità. D’altro lato, in questo libro e nelle altre opere di Culianu, si evince il debito gnostico. Il suo, rileva Ferrari, è esempio di: «una gnosi contemporanea, di una salvezza per mezzo della conoscenza in un mondo […] opera del Male» (p. 234). Una gnosi centrata sulla potenza immaginante della mente, sui suoi spazi appartenenti a n dimensioni possibili. Sono i mutamenti del nostro immaginario ad aver dato vita, e potranno ancora farlo infinite volte, ai diversi paradigmi epistemici dell’umanità.
- ...
- La conoscenza prende avvio da principi semplici, elementi inaugurali che il Nostro interpreta in prospettiva tanto diacronica quanto sincronica. Essi dipendono e si trasformano alla luce di fattori ed interferenze diverse. Pur muovendosi in direzione di una mathesis universalis, Culianu presenta una teoria dell’intertestualità, della “trasmissione”, del tradere che si pone oltre il prospettivismo, in funzione ontologica. È il “senso interno” aristotelico a fungere da guida verso l’origine: «l’anarchos senza cominciamento», chiosa Ferrari (p. 238). In tale itinerario speculativo, egli rielabora, in modalità originale, le tesi di Feyerabend (anarchia della conoscenza) e di Bloom (“dislettura” decostruttiva derridiana). "Fuori dal mondo" è libro che abbatte gli steccati segnati dagli idola contemporanei. Chi scrive ritiene che essenza ed esistenza, essere e nulla si diamo sempre e solo in uno. In Culianu, in forza del debito gnostico, il mondo “altro” che si incontra nella “uscite dal mondo”, almeno in alcuni casi, pare mantenere una sua distanza dal mondo “reale”, in quanto connotato da residuale trascendenza. Nonostante ciò, Fuori di questo mondo è testo che illumina l’oblio nel quale il pensiero è caduto nell’età della post-verità. Utile a quanti vogliano mettersi alla prova, vogliano provare a pensare “dalla fine” della filosofia.
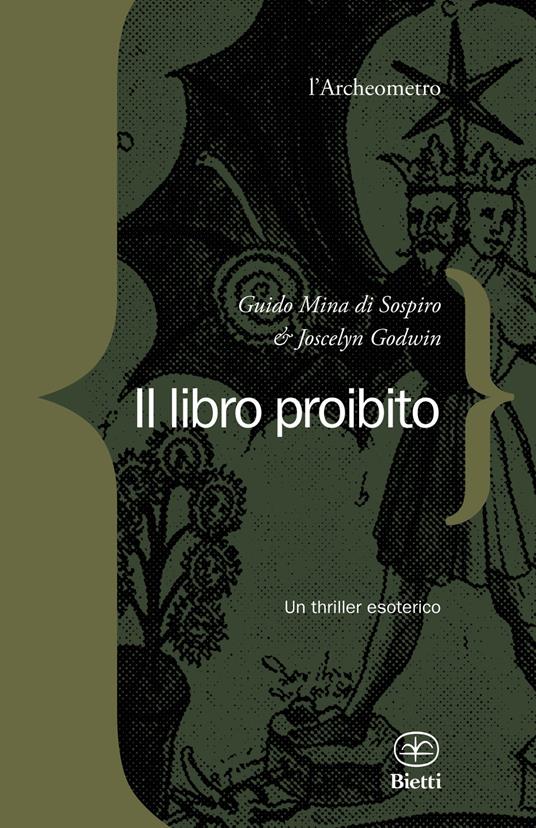
Il libro proibito- Un thriller esoterico di
- Mina di Sospiro e Godwin
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Joscelyn Godwin è considerato, a livello internazionale, uno dei più rilevanti studiosi di esoterismo. Molte sue opere sono tradotte anche nella nostra lingua. Guido Mina di Sospiro è, a sua volta, scrittore di vaglia, autore di numerosi romanzi dai quali traspare il suo interesse per le dottrine iniziatiche. È da poco nelle librerie, per i tipi delle Edizioni Bietti, ben tradotto da Andrea Scarabelli, un volume che i due studiosi hanno scritto a quattro mani, Il libro proibito. Un thriller esoterico (per ordini: 02/29528929, pp. 357, euro 22,00). Dalle sue pagine, il lettore può evincere, non solo la grande padronanza degli autori dei plessi più rilevanti del sapere ermetico, del sapere “riposto” proprio della Philosophia perennis, ma anche la loro non comune capacità scrittoria. La prosa è trascinante, conduce il lettore nelle intricate vicende del thriller e, soprattutto, riesce a far vivere e percepire le “atmosfere”, l’alone magico in cui sono coinvolti, volontariamente o inconsapevolmente, a seconda dei casi, i principali protagonisti del racconto.
- ...
- Al centro delle vicende sta la famiglia aristocratica dei Della Riviera. Di generazione in generazione, questa Gens, narrano Mina di Sospiro e Godwin, avrebbe trasmesso al momento delle nozze del primogenito, un “libro segreto e proibito”: l’edizione inedita, riservata ai membri di questa schiatta nobiliare, di un testo alchemico assai noto, pubblicato in prima edizione nel 1605 dall’ermetista Cesare Della Riviera, Il Mondo magico de gli Heroi. Il trattato richiama le posizioni ermetiche di John Dee ed è: «la pietra miliare di una corrente di alchimia spirituale italiana, tuttora attiva» (p. 351). È, a tutt’oggi, in commercio l’edizione annotata, introdotta e modernizzata nel linguaggio, da Julius Evola, data alle stampe più volte a muovere dal 1932. Protagonista negativo del giallo è il Barone Emanuele Della Riviera, l’ultimo ad aver ricevuto la pesante eredità del testo “proibito” del suo illustre antenato. I dati storici, ne Il libro proibito, sono commisti alla creazione fantastica: «le allusioni alla vita contemporanea rappresentano in modo emblematico il primo decennio del XXI secolo» (p.7), frangente storico nel quale sull’Europa sembrava incombere il pericolo islamista. Il thriller si apre, infatti, con un attentato alla cattedrale San Petronio di Bologna, dal quale uscì indenne, miracolosamente, Leo Kavenaugh, docente di Italianistica presso la Georgetown University.
- ...
- Il Barone Emanuele, alla ricerca di “realizzazione” attraverso rituali di magia sexualis, tiene nella villa avita, ubicata nelle campagne veronesi, periodiche conferenze su tematiche e simboli dell’ermetismo a un centinaio di giovani accoliti, provenienti da ogni parte d’Europa. L’aristocratico vorrebbe porsi alla testa di una nuova Lega Santa, capace di rispondere sul campo, come avvenne a Lepanto, all’invasione musulmana. Auspica una rinascita dell’Europa, apparentemente legata alla tradizione cattolica, in realtà mirata a far risorgere un Imperialismo pagano: «debellata la minaccia islamica, avrebbe ripulito l’Europa dal giudeo-cristianesimo» (p. 314). Emanuele, lettore attento del volume di Cesare, presto si rese conto di non essere, “per natura”, dotato per tale Via. Per sopperire a tale mancanza, si dette alla pratica dei riti di magia sexualis con la giovanissima nipote Angela, facilmente assoggettata al suo volere, e dopo la morte di questa, avvenuta durante un rito e causata dalla compressione dell’aorta, avrebbe voluto proseguirli servendosi di sua sorella maggiore, la bella Orsina, già assistente di Kavenaugh negli USA. Il professore, innamorato (senza volerlo ammettere) di Orsina e ricambiato dalla donna, nel frattempo convogliata a nozze con un ricco finanziare di origini scozzesi, Nigel, era stato chiamato in Italia da Orsina Della Riviera, per dipanare il mistero del “libro proibito”. Non ci soffermiamo su tutti momenti della trama, lasciamo che il lettore li scopra entrando nella pagine del libro.
- ...
- In ogni caso, il narrato è ricco di colpi di scena che si sviluppano, in particolare, nel Palazzo Della Riviera sul Canal Grande a Venezia, una sorta di trascrizione architettonica delle fasi dell’Opera, nigredo, albedo, rubedo. Nell’“Antro di Mercurio”, costruito nell’area sottostante il Palazzo, veniva custodito il “libro proibito”, posto su una sorta di altare. A sciogliere l’intrico sarà il professore americano che, dotato di naturali capacità magiche e studiando, dopo averla rocambolescamente trafugata dall’Antro, la versione originale de Il Mondo magico de gli Heroi, vide, in un sofferto vaticinio, l’episodio dell’assassinio di Angela ad opera dello zio, e intuì i rischi cui sarebbe andata incontro la stessa Orsina. Inizialmente, gli inquirenti imputarono a Nigel il delitto, in quanto il cadavere della giovane era stato trovato nel bagagliaio della sua automobile. Il “femminile”, il suo potere magnetico, attrattivo e rivelativo, è al centro di queste pagine, non solo nelle figure di Angela e Orsina, ma anche nelle parole dell’anziana domestica Marianna, incolta, che metterà sulla strada della risoluzione del caso il docente-mago“bianco”. Gli ambienti, siano essi le amene e verdeggianti colline venete, cantate da Foscolo - non casualmente autore d’elezione di Kavenaugh, a causa delle sofferenze d’amore raccontate nell’Ortis - o le magiche trasparenze di Venezia, rivelanti, ad occhi sapienti, la possibilità dell’impossibile, svolgono ruolo dirimente. Il misterium vitae, in essi, sovrasta ogni cosa, traligna nei sotterranei del Palazzo: «Angela gridò […] finché realizzò che quelli di fronte a loro non erano i tentacoli di una piovra, ma le radici di un enorme albero» (p. 127), il secolare platano del giardino. Il simbolo anagogico dell’Albero, è essenziale per comprendere il senso del narrato e l’esito della prassi alchemica.
- ...
- Il Barone perverso e i suoi seguaci attentatori, specificano gli autori nelle Postille che chiudono il volume, non sono veridica rappresentazione della Philosophia perennis, ne sono tragica parodia. Emanuele è: «parodia di quegli evoliani che alterano e viziano lo scopo di tale magia “eroica” e […] dell’intera tradizione ermetica» (p. 351). Per questo, il nobile Della Riviera troverà la giusta punizione e il suo piano diabolico fallirà. A trionfare sarà il misterium coniuctionis che unisce, in uno, il “maschile” e il “femminile” del professore e di Orsina. Mina di Sospiro e Godwin hanno scritto un libro letterariamente godibile, coinvolgente e importante.
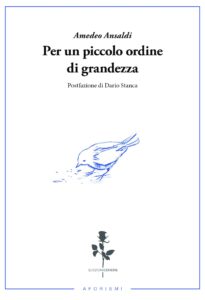

- Gli aforismi di uno scettico
- L’opera di
- Amedeo Ansaldi
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Usciamo dalla lettura di tre raccolte di aforismi di Amedeo Ansaldi. L’autore è un traduttore, vive in una cittadina sulle sponde del Lago Maggiore. Le sue opere hanno ricevuto significativi riconoscimenti: ha vinto il premio internazionale per l’Aforsima “Torino in sintesi” e, nel 2014, il Premio “Le figure del Pensiero”. Suoi aforismi sono comparsi, nel 2013, in traduzione inglese nell’antologia, The New Italian Aphorists. Giorgio Gramolini, nel Preludio alla silloge di Ansaldi, L’onere delle condizioni, uscita nel catalogo di Babbomorto Editore, ha sostenuto che la “scrittura breve” del nostro autore è: «indipendente ed equidistante da tutte quelle coloriture […] che essa è venuta spesso ad assumere» nell’età del digitale e di internet.
- ...
- L’esercizio compositivo di Ansaldi ha, proprio per questo, tratto contenutistico-filosofico inattuale testimoniante, non si tratta di un gioco di parole, la perenne attualità di tale genere letterario. Dario Stanca, nella postfazione a, Per un piccolo ordine di grandezza, dato alle stampe in tiratura limitata dalle preziose Edizioni Cenere, ha rilevato come Ansaldi non sia, sic et simpliciter, ascrivibile alla grande tradizione aforistico-moralistica francese. I suoi riferimenti, possono essere, di contro, individuati in Leopardi, Caraco e Cioran, maestri di disincanto.
- ...
- La scrittura di Ansaldi è elegante, sobria, “ben educata”, si fa latrice di ciò che Kierkegaard definì “comunicazione d’esistenza”. Una modalità espressiva che vuole decostruire, nel lettore accorto, le false certezze del senso comune. Ci sentiamo prossimi alla sensibilità dell’autore: al termine della lettura delle sue opere lo abbiamo avvertito quale comes di vaglia, nostro compagno di viaggio. I suoi aforismi, così si sarebbe espresso Zolla, sono, infatti: «Verità segrete esposte in evidenza». Ansaldi mostra, in prima istanza, di aver contezza che nella vita e nella physis, gli opposti, i contrari, si danno sempre in uno, istituiscono un rapporto relazionale, non dicotomico, come nelle corde del logo-centrismo. Essere e nulla, essenza ed esistenza, uno e molti, dicono il medesimo. Del resto l’aforisma, la frase breve, non testimonia forse che l’universale, il principio, l’origine, vive solo nel particolare? Ciò induce l’autore a rilevare: «Se Dio esiste, Egli vive tutte le nostre vite, sante e turpi, come fossero la Sua» (Per un piccolo ordine di grandezza, p. 16). Il Dio delle religioni rivelate, ente assolutizzato, è: «metafisica da operetta» (Manuale di scetticismo, Punto a capo Edizioni, p. 21). Tra gli aforismi leggiamo anche: «Aborro la nudità, nella quale risalta il genere e rimane negletta la persona» (Per un piccolo ordine di grandezza, p. 13).
- ...
- Ansaldi si riferisce alla nudità fisica: in realtà, il suo percorso dischiude al lettore un’altra nudità, ben più profonda, spirituale ed esistenziale, la vita nuda, il suo essere appesa a un’origine libera, che la rende effimera, tragica ma capace di ammaliare, di meravigliare. L’uomo libero, cui allude lo scrittore, testimonia il principio, non vuole essere servo, ma neppure padrone, diffida degli idola del presente e del passato, adorati dai benpensanti: «I perbenisti: sono sempre loro che si scandalizzano, e sono sempre ancora loro che soffocano lo scandalo» (Manuale di scetticismo, p. 31). Quello di Ansaldi è, al pari del lascito dei “suoi autori”, esercizio di parresia che, l’interprete sprovveduto, potrebbe leggere quale testimonianza di “mal di vivere”, mera affermazione pessimistica. In realtà, solo tenendo gli occhi ben aperti sull’abisso dal quale la vita si schiude, vale a dire un non originario, dynamis, libera possibilità non normabile dal pensiero, ci è dato conseguire quello stato di serenità, cui allusero gli stoici. In ciò, un ruolo di rilievo come in Leopardi, è rivestito dalla creazione estetica: «Il mio ateismo è scosso dalle fondamenta quando leggo una pagina scritta divinamente» (Per un piccolo ordine di grandezza, p. 6). La “menzogna”, l’“errore” poietico concedono all’uomo di proseguire a vivere, pur nella consapevole esposizione al nulla.
- ...
- L’uomo libero si apre così alla pietas: per lui non contano le consuetudini sociali, l’esibizione del rango o della professione. Si trasforma in vagabondo, in colui che ha contezza che il viaggio di tutto ciò che vive non ha mai una metà reale, è senza fine e senza scopo. Ansaldi è, alla luce di tale acquisizione teorica, un inguaribile “perdigiorno della letteratura”. Dai suoi aforismi traligna una caustica ironia nei confronti delle manie del tempo presente (ma anche nei confronti di se stesso). Il suo esercizio scrittorio è lama di coltello che si conficca nel pregiudizio del progresso, colpendo a fondo la filosofia aziendale oggi dominante, mirata a catalogare e mercificare la realtà. Non casualmente sostiene, con accenti che ricordano Ernst Jünger: «La decadenza […] è incominciata con la misurazione del tempo […] fino alle tristezze inoppugnabili dell’orologio» (Manuale di scetticismo, p. 9) e ha trovato il proprio momento apicale nelle rigidità del burocratismo, sottraenti anima alla vita. La pietas dell’uomo libero la si evince in quanto Ansaldi sostiene a propostito della vita animale: «la vita degli animali […] presenta tratti pienamente epici […] agonie strazianti […] atti di meravigliosa abnegazione […] le loro abissali sofferenze non trovano però degni cantori» (ivi, p. 41).
- ...
- Con tale asserzione egli restituisce dignità e “anima” a questi esseri viventi, sottomessi alla crudeltà umana. Perché, sia chiaro, come ha insegnato Karl Löwith, chi guarda alla physis tragica quale unica trascendenza possibile, non spera e non dispera: «Temere e sperare: le due facce di una stessa, fondamentale ignoranza» (ivi, p. 41), chiosa Ansaldi. I suoi aforismi, se abbiamo ben inteso, sono un invito a portarsi oltre i confini segnati dall’Io, nelle terre solitarie epoco battute dove regna coscienza, consapevolezza. Per giungere a tanto è necessario, lo suggeriva Epicuro, “vivere nascosti”, isolati dalla massa. L’ aspirazione suprema degli individualisti è, in fondo, quella di porsi a guida di quest’ultima. L’uomo che vive nella consapevolezza si sottrae a tale gioco delle parti, è sempre oltre. Lo scetticismo, come ben sapeva Rensi, ha tratto liberante.
- ...
- Ci auguriamo che Ansaldi, se avrà modo di leggere queste brevi note, non sia indotto a ripetere: «Non mi sento mai tanto defraudato come quando parlano troppo facilmente di me» (Ivi, p. 20).
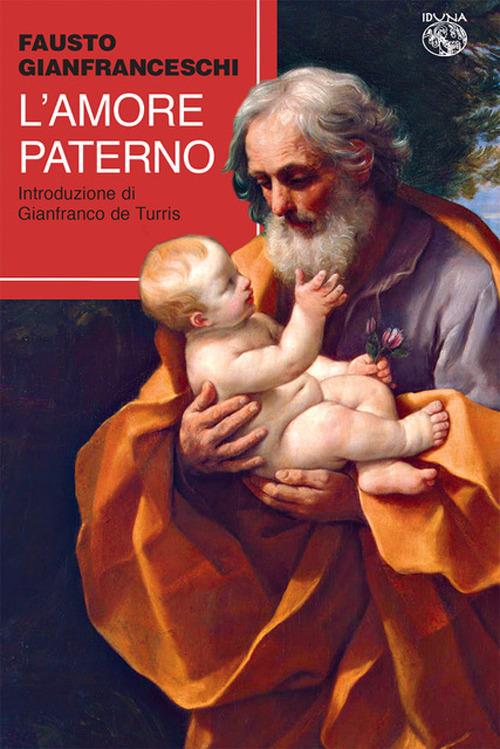
"L’amore paterno"- Nuovamente nelle librerie un libro di
- Fausto Gianfranceschi
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Fausto Gianfranceschi fa parte della ristretta pattuglia di intellettuali che animarono, con il loro apporto originale, la cultura non conforme a muovere dal secondo dopoguerra. Uomo colto, erudito, animato da un non comune coraggio esistenziale. Lo ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita e me ne rammarico, benché avessi letto e molto apprezzato, al momento del nostro incontro, i suoi libri. Era stato colpito da un mio scritto dedicato all’analisi del nichilismo, comparso sulla rivista di Sandro Giovannini «Letteratura-Tradizione». Giano Accame fece da intermediario tra noi e mi fissò un appuntamento con Gianfranceschi. Andai a trovarlo nel suo appartamento, era il 2008. Per il Settimo Sigillo era da poco uscita la mia monografia dedicata a Carlo Michelstaedter. Mi ricevette nel suo studio, parlammo a lungo del mio saggio ma, soprattutto, della sua formazione intellettuale e spirituale, della frequentazione di Evola e della sua successiva opzione di fede cattolica. Compresi che l’uomo Gianfranceschi incarnava esemplarmente il mondo ideale cui aveva aderito.
- ...
- In questi giorni, la rilettura della nuova edizione di un suo bellissimo volume, L’amore paterno, comparso nel catalogo Iduna, mi ha definitivamente persuaso della veridicità dell’impressione di allora (per ordini: associazione.iduna@gmil.com, pp. 127, euro 12,00). Il libro è preceduto dall’introduzione di Gianfranco de Turris, nella quale è rievocata, in tono nostalgico e appassionato, la loro amicizia. De Turris, inoltre, ricostruisce organicamente l’iter intellettuale e professionale di Gianfranceschi. Il libro del quale parliamo è prezioso, aureo, un inno alla vita, scritto per celebrare ciò che, per la cultura dominante, è tabù, l’amore paterno. Le sue pagine narrano, in una descrizione sostenuta da una prosa affabulatoria da cui traligna in ogni parola, la gioia che Fausto visse in occasione della nascita della figlia Michela. L’autore si intrattiene, in particolare, sui rapporti instaurati con la bimba nei primi tre anni di vita della piccola. Sappia il lettore che, in quel frangente, lo scrittore aveva cinquant’anni e da poco aveva perso, a causa di un tragico incidente stradale, il figlio Giovanni, poco più che ventenne. L’elaborazione di questo terribile lutto, il confronto con l’ineluttabilità della morte, erano stati messi a tema da Gianfranceschi nel volume, Svelare la morte.
- ...
- La nascita di Michela fu, per Fausto, un ritorno alla vita, un riconciliarsi con la sua positività e meraviglia: «Riflettendomi nell’aura di mia figlia neonata […] ho visto che leggevo nel libro dell’uomo cominciando dallo stato giusto: quando è intonso, non quando è consunto e riscritto tanto male» (p. 10). Viviamo nelle mefitiche nubi create dal sistema della menzogna, in un mondo centrato sulla degradazione del piacere perseguita dall’utopismo, che vorrebbe emendare, correggere la natura e la vita. Il risultato cui si è giunti lungo questa via, è un mondo tanatocratico, nel quale la memoria, personale e comunitaria, è obliata. Per la qualcosa, rileva lo scrittore: «Tutto, oggi, ha bisogno di essere riscoperto nella sua semplicità ed evidenza» (p. 11) e l’accoglienza amorevole, calda e partecipe di un figlio riconduce alla semplicità, all’innocenza pura dei bambini. Lo seppe Hofmannsthal, ricorda Gianfranceschi, che scrisse: «Solo gli artisti e i bambini vedono la vita così com’è […] Sono gli unici in grado di concepire la vita come totalità» (p. 5). Nel venire al mondo di un figlio è da vedersi: «la nascita dalla quale ricomincia sempre la storia dell’uomo nella perenne fedeltà all’archetipo e nell’innumerabile varietà di destino» (p. 11). Si tratta della continua ri-creazione del mondo nel tradere, nella trasmissione della vita e del sapere di padre in figlio.
- ...
- Se per l’adolescente il padre incarna l’esempio, la Legge, per il bambino l’amore paterno si mostra allo stato puro, carico di sorgiva freschezza. Lo scrittore rievoca le prime cure prestate a Michela, ricorda il suo primo vagito, il cingerla tra le braccia quale germoglio di vita, il suo discorrere con lei nel silenzio: «I figli fanno crescere. Quale meraviglia assistere al melodico risveglio della tua anima neonata» (p. 21), afferma Gianfranceschi. In tale contesto, l’affermarsi della Parola in Michela assume per il padre senso di evento cosmico: «La vita fluisce in te anche dalle parole che ti danno posto nel mondo» (p. 28). L’alimentazione dell’infante non è mero bisogno biologico, ma atto che lo unisce alle radici della realtà, di cui i bambini sono ornamento e lode. In forza della loro sensibilità totalizzante, la casa, luogo degli affetti, è vissuta quale templum, ha valenza sacra, così come le persone che la abitano. Tutto ciò è negato dalla cultura barbara che ci attornia, che vorrebbe ridurre l’uomo a puro istinto, ad animalità. L’intuizione fantastica del mondo di Michela, è prova che il cuore sente, percepisce e parla.
- ...
- Il bambino si rispecchia, si scopre nella propria natura più intima, nel dare e ricevere amore: «principio permanente di vita» (p. 46). La paura della bimba chiarisce come l’esistenza sia effimera, solo i bambini sanno confrontarsi serenamente con i mostri della fiabe: hanno consapevolezza che il male è inscritto nello stesso bene e consente di conoscerlo per antitesi. In ogni bambino vige il sentimento poetico del mondo, che molti adulti dimenticano. Lo si evince dallo stupore di Michela per il bello, per le immagini che tanto l’attraevano nei libri d’arte, per la meraviglia dei giardini, colta durante le passeggiate a Villa Pamphili. In questi luoghi, stante la lezione di Rosario Assunto, pensatore ricordato da Gianfranceschi, Prometeo e Orfeo sono conciliati, l’agire dell’uomo è sintonico a quello che fa mostra di sé nella manifestazione naturale: i loro viali illuminati dal sole conducono in uno spazio-tempo carico di atmosfera, magico. Lo scrittore si rivolge alla figlia con queste parole: «Se sono tuo padre, e se sono un padre vero, non posso chiudere gli occhi davanti all’evidenza che ogni destino […] si forma nel legame con altri destini» (p. 125), innanzitutto nella famiglia.
- ...
- L’amore paterno, ne abbia contezza il lettore, non è semplicemente testimonianza del sentimento di un padre per la figlia, è libro antimoderno che guarda a un futuro libero dalle miserie riduzioniste del presente: encomio commosso al sempre della vita.
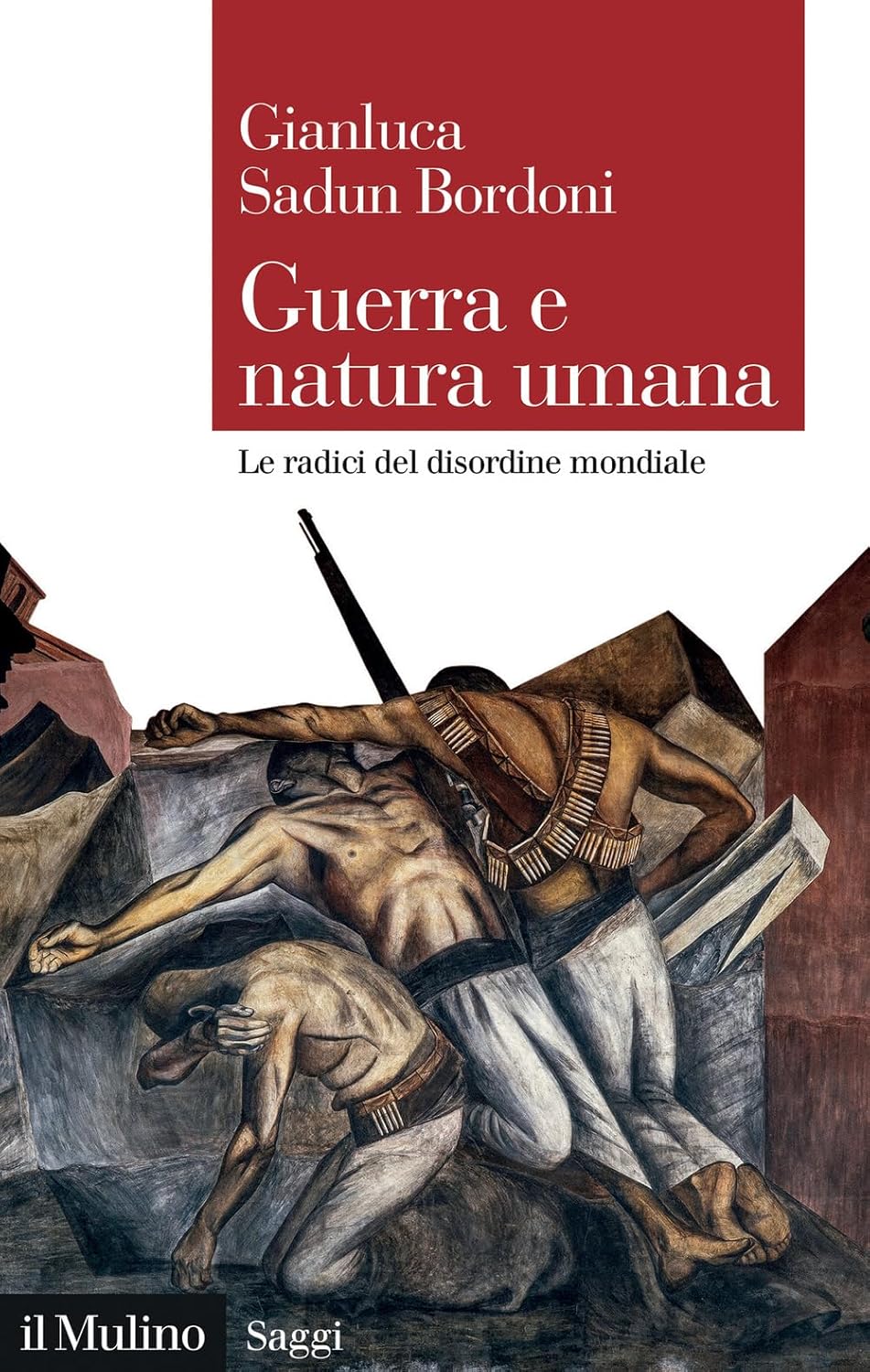
Gianluca Sadun Bordoni- Guerra e natura umana
- (Il Mulino, Bologna 2025, pp. 341, € 20,00)
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
Il ritorno della guerra in Europa e soprattutto nei mass-media rende di grande interesse ed attualità due idee – o meglio idola – contemporanei: che la guerra sia (solo) frutto di decisioni e culture belliciste e che il “progresso” (correntemente inteso) porti al suo superamento come mezzo di risoluzione dei conflitti. Accanto alla guerra – aggiungo io – oggetto in via di estinzione è anche il nemico. A meno che non si tratti di colui/coloro che si oppongono alle suddette convinzioni: nel qual caso si tratta di un arcinemico, un nemico assoluto, colmo di tutto il male possibile.- ...
- Scrive l’autore “non c’è dubbio che il fenomeno politico più eclatante di questi anni sia il ritorno prepotente del conflitto tra le grandi potenze. Si tratta di un brusco e amaro risveglio dopo il breve interludio seguito alla conclusione della guerra fredda, in cui parve che, assieme alla storia, fosse prossima a finire la sua ombra ferrigna, cioè la guerra. Dall’altro lato, la rivoluzione in atto nelle scienze antropologiche…, ha reso ineludibile confrontarsi con l’evidenza scientifica che la guerra appartiene all’uomo sin dalle sue origini”.
- ...
- Ma il carattere anarchico, conseguente alla parità dei soggetti politici internazionali, esclude un potere superiore decisore dei conflitti. Il problema della natura umana, consustanziale al realismo politico (v. Tucidide e l’Ambasciata ateniese ai Meli) può essere affrontato “nel quadro delle scienze biologiche. Uno degli obiettivi di questo libro è in tal senso quello di innestare sul tronco del realismo politico l’analisi scientifica della natura umana, e cioè l’antropologia evoluzionistica”. Il libro è diviso in due parti, “la prima parte, storico-politica, intende mostrare il naufragio del tentativo moderno di superare la perenne precarietà della pace, una tregua tra due guerre, mediante un assetto durevolmente pacifico delle relazioni tra stati, mirando addirittura a una «pace perpetua»”. Nella seconda si analizza il rapporto tra guerra e natura umana (Proudhon) alla luce anche dei moderni risultati della biologia e dell’antropologia (e non solo), onde rispondere alla domanda se la guerra sia “un’attività con profonde radici nella nostra storia naturale, ovvero un adattamento evolutivo”. Data l’inevitabilità della guerra si chiede Sadun Bordoni nella conclusione se “la superiore intelligenza, capacità tecnica e presumibilmente aggressività, che consentirono a Homo sapiens di affermarsi nella competizione con altre specie di uomini, potrebbe causarne l’autodistruzione, anche solo parziale. Non si tratta infatti solo dell’ipotesi di un’estinzione della specie: anche un radicale collasso di civiltà rappresenterebbe il giorno del giudizio per l’uomo”.
- ...
- Due considerazioni del recensore. L’ineliminabilità del conflitto e della guerra è una regolarità della politica (Miglio) e un presupposto del politico (Freund). Tanto per ricordare due acuti studiosi del secolo scorso, senza bisogno di citare i loro (tanti) predecessori da Tucidide, passando per Machiavelli e Hobbes fino a Carl Schmitt. Senza conflitto e nemico non si comprende né la politica e neanche – tra l’altro – il diritto (Carnelutti tra i tanti): non se ne può dare una giustificazione razionale. Il fatto poi che chi pensa il contrario non indica, in millenni di storia, alcuna comunità che sia esistita senza capi, senza nemici e senza conflitti è indicativo della regolarità di questi e del carattere favolistico del contrario. Che vengano, come scrive Sadun Bordoni, indagini moderne a confermare ciò è un’ulteriore conforto alla tesi della regolarità del conflitto e del nemico. Tuttavia tale tesi deve contemperarsi con l’esistenza del libero arbitrio che se rende comunque possibile la guerra, può indurre a scegliere la pace. Ne deriva che le concezioni antropologiche della bontà naturale, del raziocinio, del progresso (e così via) nonché i loro sostenitori potrebbero finire col generare un pianeta senza guerre. Neanche tale concezione può essere condivisa – anche se auspicabile. La modernità ha perso la distinzione tra ciò che è impossibile e quindi non oggetto di prescrizioni giuridiche, come osservare la legge di gravità, nutrire i tavoli, far volare gli asini (Spinoza), cioè l’impossibile ontologico e ciò che, pur essendo possibile, è altamente improbabile, come contrario a comportamenti costanti. Ossia alle regolarità (psicologiche e) sociologiche; onde si può evitare una guerra ma non eliminare la guerra dalla possibilità (dalla volontà e dalla natura) umana.
- ...
- La regolarità del potere di Tucidide, la legge ferrea dell’oligarchia, la distinzione amico-nemico sono conformi al comportamento umano e quindi regolari. Se una comunità di stiliti nella Tebaide o una tribù polinesiana sono vissute senza capi e senza nemici ciò conferma il carattere di eccezione rispetto alla costanza di comportamenti contrari. E la necessità quindi di costruire gli argini per proteggersi dalle (future) inondazioni (Machiavelli). Cosa che questo libro aiuta a fare.
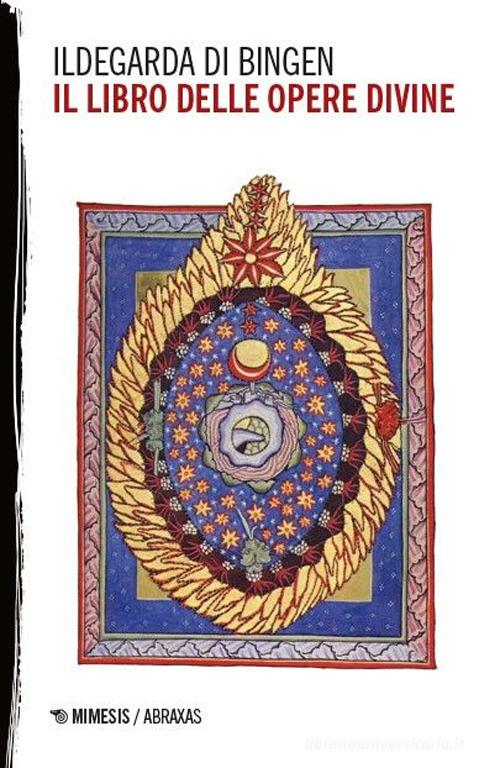
"Il libro delle opere divine"- Ildegarda di Bingen
- e il cristianesimo “naturalistico”
- rec. di
- Giovanni Sessa
- È nelle librerie, per i tipi di Mimesis, l’opera capitale di una delle figure più rilevanti, ma meno note e studiate, della filosofia medievale. Ci riferiamo a, Il libro delle opere divine, di Ildegarda di Bingen (per ordini: mimesis@mimesisedizioni.it, 02/24861657).
- ...
- Il volume raccoglie, in un Prologo e in due parti, dieci “visioni” della contemplativa considerata, dalla vulgata esegetica prevalente, sic et simpliciter, “mistica” cristiana. La lettura del testo mostra, al contrario, soprattutto nei “commenti” di Ildegarda alle “visioni”, che la sua personalità è molto più complessa. Fu, di certo, una mistica, seppur in possesso di una cultura fuori dal comune, non solo filosofico-teologica, ma anche, per l’epoca in cui visse, “scientifica”. Il suo sapere fu enciclopedico, integrale: da un lato, annunciava, anzi tempo, il gusto umanistico nel rintracciare relazioni tra micro e macrocosmo, mentre dall’altro, in forza di una straordinaria capacità di sintesi, si fece latore di un cristianesimo, al pari di quello francescano a lei succedaneo, atto a recuperare la physis, la centralità della natura. Il volume è impreziosito dalle Tavole miniate contenute nel manoscritto n. 1942, conservato presso la Biblioteca Statale di Lucca, che permettono al lettore di avere proficuo accesso al multiforme mondo simbolico dell’illuminata studiosa.
- ...
- Per entrare nelle vive cose della trattazione di Ildegarda, è necessario aver contezza che le “visioni” furono trascritte nel decennio che va dal 1163 al 1174. Periodo cruciale nella vita della pensatrice, impegnata nella fondazione del monastero di Eibingen e nella redazione della Vita di San Disibodo. Inoltre, nel medesimo frangente temporale, la donna affrontò la morte del fedele segretario Wolamr, valido aiuto nella stesura de, Il libro delle opere divine. Dopo il luttuoso evento, il volume fu terminato grazie al contributo del nipote della badessa, Wezelin, e di Ludovico di Sant’Eucario. L'opera può essere considerata una risposta, teoricamente assai potente, al conflitto che, con Federico I, stava contrapponendo la Chiesa all’Impero. Al magistero spirituale di Ildegarda aveva guardato con interesse lo zio di Federico, Corrado III. In forza di tali rapporti con l’autorità imperiale, la mistica si sentì indotta a inviare epistole accorate all’Imperatore, perché questi sanasse il conflitto in essere. Le tensioni del papato nei confronti di Fedrico I avevano portato all’assassinio dell’arcivescovo filo-imperiale di Magonza, città non distante da Eibingen.
- ...
- Fin dall’incipit dell’opera, inoltre, Ildegarda dichiara la propria ispirazione giovannea. Giovanni evangelista, al pari della pensatrice, aveva fatto discendere nella propria anima l’ispirazione divina, nutrendosi della profondissima rivelazione che sgorga dal cuore del Cristo, dio incarnato, potente e sofferente, che si è fatto uomo per salvare il mondo. L’impianto giovanneo del libro è mirato a fornire una risposta forte allo gnosticismo dualista, in quel tempo tornato prepotentemente sulla scena con il bogomilismo e con la dottrina catara.
- ...
- I commenti alle “visioni” (indotte da un’accentuata sensibilità psichica e, stando a certi interpreti, risultato anche delle potenti emicranie che affliggevano la monaca), sono articolati da Ildegarda con continui rimandi ad Agostino, Boezio, Giovanni Scoto Eriugena e alla Scuola di Chartres. Nella prima “visione” emerge una figura splendente di oro e di rosso, simboleggiante una vera e propria visualizzazione immaginale e non logocentrica della conoscenza, richiamante la dottrina stoica del fuoco, energia atta a preservare l’armonia mundi. Il Lógos è identificato con il pneuma, soffio infuocato, anima del cosmo. L’espressione chiave al fine di interpretare il mondo ideale della mistica è viriditas, “energia verdeggiante”. La nozione fa rilevare l’intenzione teorica dell’autrice: scendere in profondità all’interno delle metamorfosi naturali per cogliervi, con Dionigi l’Aeropagita, il principio animato, la sua “non-forma”. Una sorta di “razionalità biologica” sempre all’opera. Agostino aveva, del resto, insegnato che il: «generarsi del pensiero nel linguaggio, costituisce modello privilegiato per comprendere la generazione del Padre nel Verbo» (p. 13). La parola divina si manifesta nel duplice ordine della natura e della Scrittura, per questo Ildegarda scrive, testimonia il Verbo e, con Eriugena, interpreta, anti dualisticamente, in modalità cosmologico-antropologica il Prologo di Giovanni. Il Verbo, in queste pagine, ha tratto naturale, “fiorisce”, “ri-suona” in tutti gli enti.
- ...
- Al modo dei Maestri di Chartres, in Ildegarda lo Spirito Santo assume valenza di connectens, è nexus che lega il trascendente all’immanente. Non si tratta ancora di panteismo in quanto, a dire della pensatrice visionaria, vi è una distinzione tra la prescienza di Dio: «nella cui eternità è fondata, platonicamente, la realtà delle cose, e il successivo apparire dell’opera divina nel tempo» (p. 19). Certamente, tali tesi, rappresentano un momento di innesco di una nuova prospettiva teoretica portata a compimento durante la Rinascenza. Ildegarda, da interprete fedele di Giovanni, rinvia, inoltre, alla dimensione soteriologica, alla teologia della storia, in una prospettiva per certi tratti non dissimile da quella di Gioacchino da Fiore. Lo si evince dalla parte conclusiva del volume, anche se il tema escatologico emerge, in tutta evidenza, già nella prima “visione”. In essa, l’itinerario verso il nulla di Lucifero, angelo ribelle, è simbolicamente rappresentato in una circonferenza di oscurità e male, mentre la paternità divina è visibile in una diversa circonferenza, “circolo di pienezza”. L’apertura al “naturalismo” è innegabile nella seconda “visione”. In queste pagine, i venti animano l’uovo cosmico originario (tradizione orfico-pitagorica), trasferendo il “soffio vitale” al mondo. Ogni vento riveste una particolare valenza simbolica, in un cosmo sacralmente orientato e animato, dall’interno, dal principio. Medesimo ruolo giocano gli animali-simbolo, leopardo, lupo, leone e orso, così come il firmamento.
- ...
- L’uomo cosmico di Ildegarda è copula mundi: il suo agire può avere esiti anagogici o catagogici. Il monaco è paradigma di tale cosmicità. Un monachesimo, quello della badessa, lontano dal rigorismo ascetico, aperto al “femminile” e al “generativo”, capace di veicolare verso l’alto gli impulsi meramente “biologici” (come statuito dalla Regula Benedicti, cui l‘autrice guarda quale positivo esempio di azione nel mondo), non contrastando, in toto, la realtà corporale della vita.
- ...
- Ildegarda è alla ricerca della giusta misura tra contemplazione e azione. La sua filosofia rappresenta un anello di rilevo in una corrente carsica del pensiero europeo che fiorirà nel Rinascimento con Bruno e si riaccenderà nella mistica di Böhme e di von Badeer, per riaffacciarsi nella filosofia del Novecento, in particolare italiana.
- ...
- Il libro delle opere divine di ldegarda di Bingen, animato da non comune potenza linguistico-affabulatoria, è opera di spessore, sulla quale bisognerà tornare a riflettere.
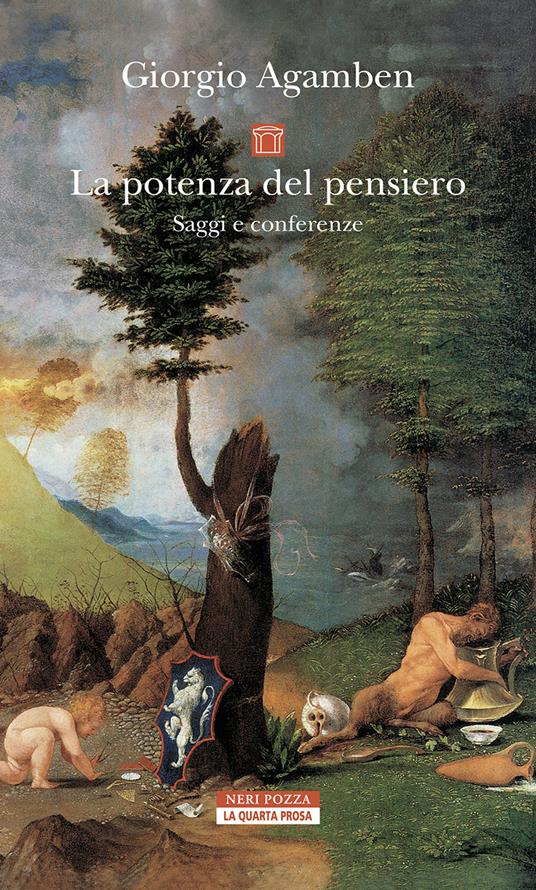
"La potenza del pensiero"- Saggi e conferenze
- di
- Giorgio Agamben
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Giorgio Agamben è pensatore di valore, una delle voci più significative e libere del panorama teoretico dell’Italia contemporanea. Lo mostra la sua ultima fatica, La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, comparsa nel catalogo di Neri Pozza Editore (pp. 392, euro 26,00). Il testo è una silloge di conferenze e di scritti inediti o pubblicati su riviste, a muovere dal 1980 ad oggi, ed è articolato in tre sezioni: Linguaggio, Storia, Potenza. Volume composito,organico nei contenuti, dal quale si evince l’erudizione speculativa dell’autore esser supportata dalla volontà di far luce sui plessi della filosofia europea che hanno indotto lo stato presente delle cose. L’espressione linguistica di Agamben è sostenuta da volontà di parresia, dal voler, nell’epoca della post-verità, confrontarsi, in modalità originale, con problematiche teoretiche dirimenti per il nostro tempo. Le argomentazioni hanno sviluppo spiraliforme: come in ogni autentico filosofare, lo scritto torna di continuo, “ossessivamente”, sui medesimi temi, fin dall’ incipit, La cosa stessa (del pensiero).
- ...
- Agamben, in questo saggio, si intrattiene sulla Settima lettera di Platone, il più delle volte interpretata dalla critica quale testimonianza dell’esistenza di dottrine non scritte nel pensiero del grande Ateniese, dottrine rinvianti a un “primo”, a un’origine indicibile. In realtà, Platone, spiega il pensatore, dopo aver fatto riferimento al nome, al discorso definitorio, all’immagine e alla scienza, chiama in causa un “quinto”, la cosa stessa cui il pensiero mira. Il filosofo greco afferma: «nel modo più esplicito che “se non si sono colti i primi quattro” […] non si potrà mai conoscere compiutamente il quinto» (p. 13). La “cosa del pensiero”, il contatto di cui ha detto Colli, la si può toccare, in modalità immediata: «sfregando gli uni sugli altri nomi, logoi, visioni e sensazioni e mettendoli alla prova in confutazioni benevole» (p. 13). La sparizione del linguaggio nell’indicibile, sic et simpliciter, esoterico, induce, al contrario, la definitiva perdita della filosofia: «La cosa stessa ha dunque nel linguaggio il suo luogo eminente, anche se il linguaggio non è senz’altro adeguato ad essa» (p. 14). La cosa stessa, l’eidos, non è altro dal reale, non ne rappresenta un duplicato, non è oscuro presupposto del nome e del logos, ma sta: «nel medio stesso della sua conoscibilità, nella pura luce del suo rivelarsi» (p. 16). Il sapere logocentrico ha reso il linguaggio presupponente e oggettivante riducendo la “cosa del pensare” a: «un essere su cui si dice e in un poion, in una qualità e determinazione che di esso si dice» (p. 16).
- ...
- La sua reale conoscibilità, in tale prospettiva, è stata smarrita. Platone si limita ad annunciare l’aporia del linguaggio metafisico, con la quale si sta confrontando il pensiero contemporaneo. Il tratto non-linguistico dell’origine può, difatti, essere pensato solo nel linguaggio. La comunicazione filosofica deve venire in aiuto, con la parola, alla Parola stessa. Aristotele, ricorda l’autore, fece subentrare alla “cosa del pensiero”, la sostanza prima, ciò che non si dice su un soggetto, né in un soggetto. La sostanza divenne il presupposto su cui si fonda ogni dire anche se, come individuum, rimase ineffabile. Agamben, per questo, considera Aristotele padre della mistica occidentale. Su tale fondamento il filosofo diviene: «scrivano del pensiero e, attraverso il pensiero, della cosa e dell’essere» (p. 22). Compito della filosofia dell’avvenire sarà quello di restituire alla “cosa del pensiero” un posto conveniente nel linguaggio. In tal senso ha operato Derrida, con il proprio experimentum linguae. Tale esperimento è centrato sul concetto di traccia. Si badi, il francese si riferisce paradossalmente a un non-concetto che mette in discussione la stessa idea di senso sulla quale è fondata la logica occidentale. La traccia è una sorta di scrittura della potenza, scrittura che, di fatto, a dire di Agamben, nessuno ha finora messo in atto, in quanto implica un ripensamento del concetto aristotelico di dynamis, potenza-possibilità.
- ...
- È la dynamis il cuore vitale della filosofia di Agamben. Lo si evince dal saggio che dà il titolo al volume, La potenza del pensiero. Pagine illuminanti che chiariscono il duplice tratto della potenza nello Stagirita: possibilità di potere e di non-potere (privazione) in uno. L’atto aristotelico non è che periechein, “ciò che avvolge” momentaneamente nel suo darsi, il prius, la mai normabile dynamis, come comprese Andrea Emo: «La potenza è […] definita essenzialmente dalla possibilità del suo non-esercizio […] L’architetto è potente in quanto può non costruire» (p. 270). La grandezza umana è anfibia, è potenza di non passare all’atto. Solo non-potendo possediamo la nostra più propria potenza, il nostro operare risulta inoperoso (Nancy). Tale situazione testimonia l’impossibilità del soggetto moderno, induce la necessità di una sua decostruzione, alla luce della quale risulterà davvero potente chi, al momento del passaggio all’atto: «non annullerà […] la propria potenza di non […] ma la farà passare integralmente in esso come tale» (p. 278), come accade negli enti della physis intesa quale mixis.
- ...
- Agamben porta, inoltre, la sua attenzione esegetica sul libro di Lévinas, Filosofia dell’hitlerismo. In queste pagine si sostiene che l’interesse per la fatticità e il “ci” dell’Esser-ci, da parte del nazionalsocialismo e di Heidegger, il loro muovere dalla vita nuda, sono portato teorico della filosofia europea. Il nazismo non può essere esorcizzato con condanne o apologie comminate a questo o quel filosofo prossimo a tale movimento. Sarebbe, di contro, auspicabile comprendere come il “ci” della condizione umana, non debba essere vissuto e pensato in termini di chiusura, ma in funzione di reale “apertura”, di fattiva esposizione a quell’idea di potenza inoperosa che potrebbe farci superare l’impasse del presente, segnata dal capitalismo computazionale: «Il testo di Lévinas […] può allora offrire l’occasione per prendere coscienza della nostra imbarazzante prossimità con il nazismo» (p. 317), visto il tratto “epidemico”, in senso greco (la definizione è di Emo) assunto dalle democrazie liberali. Agamben mostra, inoltre, come il tema dell’Immemoriale sia presente nella speculazione moderna e come abbia in essa assunto tratto immaginale. In particolare, ciò è avvenuto nell’eterno ritorno di Nietzsche. In tale immagine essere e divenire si danno, anche cronologicamente, in uno, vivono in costante interdipendenza. L’immagine dice di una potenza in fieri che ha in sé i due momenti della dynamis aristotelica, eternamente ritornante e implicante l’oblio. Della cosa, ricorda l’autore, ebbe contezza Dino Campana.
- ...
- La potenza del pensiero è libro che meriterebbe trattazione diversa da quella di una recensione. Della qualcosa ci scusiamo con autore e lettori. Ci auguriamo di aver presentato almeno alcun plessi dell’articolata proposta teorica di Agamben.
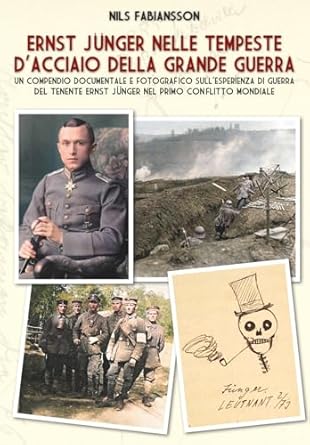
Jünger nelle tempeste d’acciaio- Un compendio documentale e fotografico di
- Nils Fabiansson
- rec. di
- Giovanni Sessa
-
- Ernst Jünger è, al di là dei giudizi politici espressi sulla sua opera, uno dei grandi nomi della letteratura europea del Novecento. Un illustre “figlio del secolo XX”, periodo di contraddizioni e tragedie, ricco di slanci ideali. Nella vasta produzione jüngeriana un ruolo di primo piano riveste il libro che lo rese noto al grande pubblico, Nelle tempeste d’acciaio. Un volume dedicato a rievocare, in presa diretta, la partecipazione dello scrittore al Primo conflitto mondiale sul fronte occidentale. È da poco disponibile per il lettore italiano un volume di Nils Fabiansson, Ernst Jünger nelle tempeste d’acciaio della Grande Guerra, comparso nel catalogo di Italia Storica Edizioni, il cui senso è svelato dal sottotitolo, Un compendio documentale e fotografico sull’esperienza di guerra del tenente Ernst Jünger nel Primo conflitto mondiale (pp. 184, euro 25,00). Il volume è curato da Andrea Lombardi, la traduzione è di Vincenzo Valentini. L’autore è uno storico ed archeologo svedese, autore, tra le altre cose, di una guida di viaggio sul fronte occidentale del conflitto che inaugurò il “secolo breve”.
- ...
- Per comprendere le intenzioni dello studioso svedese è bene muovere dalle considerazioni di Christopher Tilley, docente di storia materiale, che a proposito del paesaggio ha rilevato che: «i luoghi sono da sempre molto più che punti di localizzazione, perché hanno significati e valori distintivi per le persone» (p.7). Lo stesso Jünger sostenne, a più riprese, di essere magneticamente attratto da alcuni “luoghi”. Per questo motivo, Fabiansson conduce il lettore sui campi di battaglia descritti da Jünger Nelle tempeste d’acciaio, non solo confrontando e fornendo l’esegesi delle molteplici revisioni cui quest’opera fu sottoposta dalla scrittore, ma servendosi di un ricchissimo apparto iconografico contenete fotografie tratte da archivi pubblici e privati (particolarmente suggestive e rievocative dell’“atmosfera”, del “clima spirituale” allora aleggiante sulle trincee, risultano essere quelle in bianco e nero), di pagine dei diari dello scrittore tedesco, di mappe da lui disegnate su taccuini e immagini dei luoghi delle battaglie come appaiono oggi. Fabiansson, si badi, non mira a realizzare una sorta di turismo bellico-letterario, che Jünger non avrebbe apprezzato, ma resta fedele allo sguardo stereoscopico e glaciale dello scrittore. I testi inerenti la guerra del tedesco sono stati costruiti su quelli che Jünger definì “speciali poteri percettivi”, che gli consentirono di osservare dolore e morte con sguardo privo: «di sentimentalismi, con asciuttezza e fredda precisione» (p. 9).
- ...
- Il narrato si articola in cinque capitoli che analizzano le fasi del conflitto a muovere dall’agosto del 1914 per giungere ai tragici eventi del novembre 1918, momenti al cui centro si staglia la figura dell’uomo Jünger e si conclude in un Epilogo, nel quale l’autore presenta le numerosissime traduzioni all’estero di Nelle tempeste d’acciaio. Troppo spesso si è sostenuto che Nelle tempeste d’acciaio sia stato, sic et simpliciter, testimonianza dell’eroismo mostrato in combattimento dall’autore. In realtà, la lettura di Fabiansson ci restituisce uno Jünger a tutto tondo, umano troppo umano, che in molti plessi del libro racconta che: «in diverse occasioni avesse (aveva) lasciato i suoi commilitoni in balia del nemico» (p. 9). Il fatto che citi tali esempi di fallimento personale è fatto rilevante. Lo scrittore tedesco seppe affrontare, in molte circostanze, come emerge da questo studio, con sprezzo del pericolo, il rischio della morte. Patì ferite alle gambe e alla testa (conservò il suo elmetto con il foro del proiettile che lo aveva trapassato) e, per questo, fu insignito delle più alte onorificenze militari al merito. Nonostante ciò, nel 1972 affermò che: «i ricordi dei suoi giorni di scolaro erano più vividi di quelli di combattente di guerra» (p. 10). Si lagnava, infatti, anche alla luce della sua nuova visione della vita, ben rilevata dalla esegesi del suo pensiero da Evola, che i lettori si intrattenessero, a molti decenni di distanza dalla loro pubblicazione, sui suoi scritti di guerra definiti ormai «Vecchio Testamento» (p. 10).
- ...
- Non fu solo il “cuore avventuroso” a indurre Jünger ad arruolarsi volontario, ma anche la precisa volontà di meravigliarsi e di comprendere in profondità il senso della guerra; si chiese se essa celasse ancora, di là dai massacri che la “guerra dei materiali” imponeva, per chi la viveva in prima persona, una possibilità realizzativa. La sua risposta fu positiva. Il combattimento determina il superamento della routine borghese, ponendo l’uomo di fronte alla potestas che lo anima e che aleggia in tutta la natura. La guerra distruttiva pare travolgere tutto. Le descrizioni dei campi di battaglia dello scrittore tedesco, ci fa entrare nelle vive cose del paesaggio bellico, attraversando e confrontandosi con l’eterna metamorfosi ciclica che lì costituisce. Jünger seppe, come colse il filosofo Karl Löwith, che il permanente e lo stabile nella vita umana è dato solo dalla “trascendenza” della natura. Durante il Secondo conflitto mondiale, rilevò che la Piccardia: «con le sue dolci ondulazioni, i villaggi incastonati nei frutteti, i pascoli, attorno ai quali si allineano i filari di alti pioppi […]» (p. 22), lo avevano fatto fremere dalla gioia. Non casualmente, durante il periodo trascorso a Monchy e a Douchy, di cui dice in Giardini e strade, si dette nelle trincee, alla “caccia sottile” degli insetti. Quindi, neppure nelle circostanze drammatiche della guerra, in Jünger venne meno la passione entomologica, nella convinzione che nel “particolare” si dia il principio, l’universale. Catalogò ben 143 tipologie di insetti.
- ...
- Anche il potere di Eros non fu obliato dal senso della morte incombente, in quanto, grecamente, Eros e Thanatas si dicono in uno. Così, il 5 giugno 1916, annota laconicamente: «Jeanne a Combrai» (p. 25), a testimoniare un fugace amore di trincea. Così come non furono tacitati in lui gli affetti più cari. Significativa è la narrazione di Fabiansson degli incontri con il fratello Friedrich Georg, durante i quali i due goderono degli effetti rilassanti del vino di Borgogna e delle fumate, in pipe di sepiolite, del tabacco Navy cut inglese (a causa delle ferite riportate, il pensatore durante la Prima guerra, sperimentò anche l’etere e altre sostanze psicotrope). Commovente, inoltre, il ricordo che Jünger ci ha lasciato dei suoi camerati, siano essi ufficiali o fedeli attendenti che, per lui, sacrificarono la vita.
- ...
- Il libro dello studioso svedese, non è quindi, un semplice “compendio” per leggere Nelle tempeste d’acciaio, ma volume di rilevo per l’esegesi dell’intera opera di Ernst Jünger.
- IL TRAMONTO DELLA SPD
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Il pessimo risultato della SPD alle recenti elezioni tedesche è “il peggior risultato nell’ultimo secolo di esistenza di questo partito” (è stata così indicato negli articoli che ho letto), induce due considerazioni congiunte tra loro.
- ...
- La prima, che qui non ripeto, perché spesso ci sono tornato, è che è venuta meno l’opposizione principale nel “secolo breve” cioè quella tra proletariato e borghesia, a seguito del crollo del “socialismo reale”; onde viene meno anche la necessità di quei partiti che della suddetta opposizione erano la conseguenza e l’espressione (politica e organizzativa).
- ...
- La seconda: di quella opposizione la SPD era il caso (e il prodotto) più importante. Quale espressione dell’evoluzione e dei travagli a un tempo del movimento operaio, del socialismo e della sinistra in genere da circa un secolo e mezzo. Il partito ispirato a Marx, Engelss e Lassalle, nato nel 1875, che aveva visto al proprio vertice Bebel, Kautsky, Bernstein fino a Willy Brandt e ai dirigenti successivi alla II guerra mondiale; il partito che è stato oggetto di studio anche di pensatori non proprio socialisti come Spengler e Michels è ridotto ai minimi termini. Spengler ne notava il carattere disciplinato (prussiano/comunitario) contrapposto allo spirito disordinato e individualista (francese e inglese). Mentre Michels vi trovava conferma della regolarità (Miglio) della classe politica e della ferrea legge delle oligarchie che dominavano anche in un movimento teso ad una prospettiva di liberazione totale (la società senza classi). In effetti Spengler scriveva che “in quella classe operaia forgiata da Bebel in un potente esercito, nella sua disciplina e fedeltà, nel suo cameratismo, nella sua disponibilità ai più estremi sacrifici, sopravviveva quell’antico stile prussiano”.; e che un socialismo tedesco o meglio prussiano significa che questo si conforma alla convinzione generale (istinto/guida) che il potere appartiene alla comunità mentre in quello inglese appartiene all’individuo e in quella francese a nessuno. Combinandosi col socialismo questa convinzione (notata da altri come di derivazione luterana) genera un socialismo gerarchico-comunitario, in sostanza autoritario.
- ...
- Nel secondo dopo guerra Kirchheimer coniava il termine di “partito pigliatutto” ispirandosi (anche) all’evoluzione dell’SPD; connotati salienti del “partito pigliatutto” erano (rispetto al “partito di classe” che l’aveva preceduto) di fare riferimento a un insieme di gruppi sociali e una evidente de-ideologizzazione. A seguito del crollo del comunismo, della perdita dell’opposizione borghese-proletario e dell’emergere di una nuova frattura decisiva (globalizzazione-sovranpopulismo), anche un partito esemplare e glorioso come la SPD pare giunto ai minimi termini come i suoi analoghi di sinistra (e spesso anche di destra). Né l’insediamento sociale, né l’aver governato per decenni, né la tradizione più che centenaria hanno retto alla neutralizzazione dell’opposizione che li ha generati e all’indebolimento dei fattori d’integrazione. Una lezione per l’avvenire.
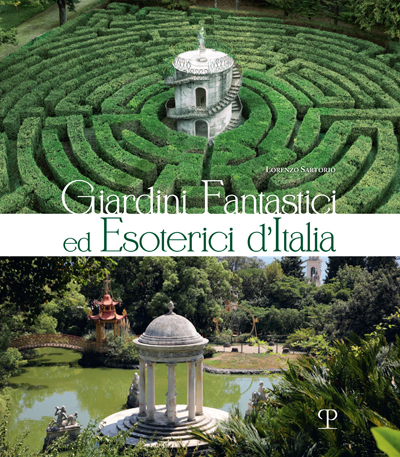
Giardini fantastici ed esoterici d’Italia- Un saggio di
- Lorenzo Sartorio
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Da tempo ci occupiamo di giardini. In particolare di filosofia del giardino. Per questo abbiamo avvertito la necessità, dopo averlo letto, di parlare di un recente libro in tema. Ci riferiamo al volume di Lorenzo Sartorio, studioso milanese e viaggiatore appassionato, Giardini fantastici ed esoterici d’Italia, nelle librerie per Edizioni Polistampa (per ordini: info@leonardolibri.com, 055/73787, pp. 208, euro 30,00). Si tratta di un saggio aperto dalla contestualizzante prefazione di Paola Maresca, corredato da un ricco e prezioso apparto iconografico (foto scattate nei luoghi descritti, da Sartorio stesso). La prosa affabulatoria dell’autore rende gradevole la lettura e mira a far compiere al lettore accorto un viaggio nei giardini fantastici ed esoterici italiani: viaggio nel tempo e nello spazio ma, soprattutto, iter da compiersi in interiore homine.
- ...
- Qualsivoglia “passeggiatore solitario” (la definizione è di Rousseau) abbia la ventura di accedere in uno di questi luoghi pregni di meraviglia, percepisce un “atmosfera”(fuzei, in lingua giapponese), sottraendosi, in tal modo, ai processi di “fattorizzazione” propri della conoscenza concettuale e logocentrica. Il giardino è, lo sostenne, il filosofo Merleau-Ponty, “un campo d’esperienza” nel quale si acquisisce contezza della coincidenza oppositorun, dell’essere gli opposti in un rapporto di relazione non-escludente. In tal senso, si vada alle pagine che, nello Zibaldone, Leopardi dedicò al giardino. In esse il poeta-filosofo sostiene che nel momento del fulgore primaverile-estivo della vegetazione, nell’erompere dei profumi e dei colori dei fiori, è possibile presagire inscritta in essi, la loro fine, l’inverno della vita. L’esegesi di Sartorio muove dai giardini italiani del Rinascimento, spingendosi fino ai Parchi realizzati nel tardo Ottocento: in essi, gli architetti-giardinieri dell’Umanesimo, a seguito del recupero neoplatonico del sapere ermetico, trascrissero le tappe di veri e propri percorsi iniziatici. Durante la Rinascenza «Un ruolo fondamentale per questa rinnovata concezione del giardino la ebbe la pubblicazione, nel 1499, del libro Hypnerotomachia Poliphili» di Francesco Colonna (p. 16).
- ...
- Sartorio accompagna il lettore, con persuasività di accenti e fondato sapere ermeneutico-simbolico, in diciotto giardini e parchi di grande rilevanza. Non si limita a descrivere e interpretare senso e significato riposto di questi luoghi, ma si sofferma sulle originali personalità dei loro ideatori. Entriamo, con la dovuta cautela, in alcuni di essi. Muoviamo dal Parco mediceo di Pratolino, voluto da Francesco I (1541-1587). Il progetto ebbe inizio nel 1568. Allo scopo, furono deviate le acque del Monte Senario che andarono ad animare le spettacolari fontane e gli automi del giardino, dando vita a un gioco d’acque assai suggestivo. L’ingresso, in origine collocato a Nord, conduceva alla fontana di Giove: «da cui si sviluppava un complesso percorso alchemico-filosofico» (p. 23). L’iter del “risveglio” era ben simbolizzato dal labirinto, metafora: «del cammino tortuoso da dover effettuare per raggiungere il Centro» (p. 24). Il genius loci a Pratolino è incarnato dalla statua dell’Appennino del Giambologna. In sintesi, il giardino mette in scena, in una serie di grotte, i tre momenti della trasformazione alchemica, nigredo, albedo e rubedo, al culmine della quale l’adepto consegue uno stato di sublimazione permeato da Eros, idendificandosi con l’Uno-Tutto. Non dissimile è il Sacro Bosco di Bomarzo, posto in essere da Vicino Orsini quale tempio, fantasticamente adorno di statue e figure mostruose, per la cui decodificazione rinviamo all’esemplare esegesi di Elémire Zolla. Quando il neo-paganesimo umanistico fu sopraffatto dalla montante marea controriformista, divenne, una sorta di “reclusorio” per quegli spiriti che avevano serbato una sensibilità iniziatico-pagana.
- ...
- Altrettanto rilevante è il Parco Durazzo Pallavicini, di Pegli, nel quale il percorso esoterico si snoda: «in una vera e propria recita teatrale suddivisa in atti, nelle quali il visitatore diventa […] il protagonista principale» (p. 96) di una metamorfosi realizzata all’interno di un paesaggio panico, mediterraneo-solare. Il merito di questa costruzione va attribuito ad Alessandro Pallavicini e allo scenografo Michele Canzio, entrambi prossimi alla visione del mondo massonica. Nell’esodo finale del tragitto teatrale, si realizza la trasformazione della “pietra grezza” della personalità in “pietra levigata”. I giochi d’acqua, con la loro trasparente sonorità, esercitano un ruolo di primo piano. Medesima considerazione può valere per lo Storico Giardino Garzoni di Collodi, sorto nei pressi del “Parco di Pinocchio” (personaggio la cui vicenda esoterica incuriosì lo psicanalista Emilio Servadio, sodale di Evola). In esso, l’originario percorso mistico-allegorico conducente al Romitorio, divenne effettivo iter realizzativo. Il Bosco Isabella, ubicato nel territorio di Radicofani e voluto da Odoardo Luchini, massone ed influente uomo politico, fu da questi dedicato a sua moglie Isabella. È esempio di sincretismo culturale, sintesi di suggestioni romantiche e di simbologia massonica. Attualmente versa in stato di degrado a causa di prolungata incuria. Bisogna entrare in questo spazio: «tenendo conto che la Massoneria si è spesso ispirata, per le sue costruzioni, al Tempio di Salomone di Gerusalemme […] e ad Harim, il suo architetto ideatore» (p. 131).
- ...
- Non si può tacere, in questo contesto, il lascito dell’architetto Tomaso Buzzi, noto con il nome di La Scarzuola, nel cuore dell’Umbria. È una città-giardino fantastica, eretta nel luogo in cui S. Francesco costruì una capanna di “scurza”, pianta locale che dà il nome alla creazione di Buzzi. La “Scarzuola” può essere interpretata: «come vero e proprio viaggio di iniziazione […] in cui il visitatore-novizio si trova per prima cosa a lasciare la Città sacra per poi intraprendere la strada dell’Amore» (p. 142) e farvi ritorno da “risvegliato”. Significativa risulta essere, per la simbologia in essa presente, anche Villa Giulia di Palermo. Fu voluta dai Borbone, Goethe la definì: «il più bell’angolo della terra» (p. 146). Concludiamo le nostre riflessioni, soffermandoci sul labirinto della Fondazione Cini all’isola S. Giorgio di Venezia, intitolato allo scrittore Borges. Si tratta di un labirinto “letterario”, di recente tracciato. Il suo rigore geometrico: «nasconde sempre qualcosa di enigmatico che non permette mai di classificarlo in toto» (p. 171). Si sottrae alle definizioni, rendendo edotto il visitatore che nei giardini, l’io si smarrisce e dalle sue ceneri sorge il Sé. In questi luoghi Prometeo e Orfeo sono conciliati, gli opposti si danno in uno. Mirabile e tragica coincidentia oppositorum, sulla quale alita dynamis, libertà-potenza sempre all’opera nella physis. Chi sappia attraversare consapevolmente i giardini di Sartorio, incontrerà, per dirla con Zolla, «verità segrete esposte in evidenza».
- AVANTI IL PROSSIMO (2.0)
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Faccio seguito ad un mio articolo con lo stesso titolo per aggiungervi qualcosa, ma anche per analizzare alcune delle reazioni al discorso di Vance e le prime mosse di Trump sulle trattative per far cessare la guerra in Ucraina. Particolarmente interessanti sono quelle dei guerrafondai italiani (e non solo) delusi. Non potendo schierarsi contro il tentativo di Trump di trattare la pace, sostengono (soprattutto) due tesi.
- ...
- La prima che occorre rispettare il diritto internazionale: l’aggressore (criminale) va sempre punito. A certe anime belle (quanto ipocrite) va ripetuto che la storia trabocca di aggressioni finite con accordi di pace che riconoscevano (le ragioni e) le conquiste (in parte e talvolta in tutto) degli aggressori. La guerra è nomogenetica: genera un ordine nuovo che è la base e la conseguenza della pace raggiunta. A non prendere atto della realtà la pace non si fa mai.
- Come del pari, spesso è polemogenetico il diritto: sempre la storia (e non solo) è gravida di guerre nate per pretese giuridiche – alcune fondate, altre no – invocate a sostegno del perseguimento di interessi dei belligeranti. Peraltro nel conflitto russo-ucraino è tutt’altro che insostenibile che la mancata attuazione degli accordi di Minsk e la guerra strisciante contro le minoranze russofone costituissero valide ragioni per l’“operazione militare speciale” di Putin. Resta il fatto che, se non si tratta per un nuovo ordine, la conseguenza non può essere che la prosecuzione della guerra, contrariamente a quanto le teste – hegelianamente gonfie di vento – di chi vorrebbe il ritorno allo statu quo ante, come condizione per la pace. Ossia la sconfitta dell’aggressore.
- ...
- La seconda tesi è surreale: si sostiene che non si può far la pace con Putin perché è un nemico. A parte l’ovvia replica che per far cessare (lo stato di) guerra occorre trattare la pace con il nemico, giacché non si è mai vista una trattativa con un non belligerante, per assenza di oggetto, occorre comunque considerare che, atteso lo stato di potenziale inimicizia in cui si trovano i soggetti di diritto internazionale per natura, non sia opportuno che la pace coinvolga (anche) qualche non belligerante, i cui interessi possono essere compromessi da una guerra. Ma questo non esclude che essenziale della pace è che la trattativa abbia come soggetti gli Stati nemici e in guerra. Nemici reali e attuali, non potenziali.
- ...
- In terzo luogo, e come conseguenza ventilata e implicita: trattare e non dettare è il miglior sistema per concludere una pace durevole. Il che significa farsi carico anche degli interessi e delle aspettative del nemico. Un pessimo esempio dell’inverso fu il “trattato” di Versailles, non negoziato con la Germania, ma imposto e per questo denominato “dettato”. E di cui Papa Benedetto XV disse che il di esso effetto sarebbe stata una nuova guerra tra vent’anni (previsione esatta anche nei tempi).
- ...
- Quarto: rispettare il diritto internazionale restituendo le terre occupate ante bellum dicono i buoni. E l’attuale situazione di fatto? Questo è proprio il contrario della situazione al fronte: dove Putin ha occupato praticamente tutta l’area russofona dell’Ucraina, per cui non è chiaro perché dovrebbe restituirla, ma d’altra parte sarebbe suo interesse evitare una pace troppo dura per l’Ucraina.
- ...
- Quinto: non insistere tanto, al contrario di quanto fanno i guerrafondai in servizio permanente effettivo, sulla criminalizzazione di Putin, per una serie di ottime ragioni. La prima delle quali è ch’è decisamente strano trattare con un criminale. E non distinguere questo dal nemico, come già nel diritto romano “‘Hostes’ hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri ‘latrones’ aut ‘praedones’ sunt”. Distinzione che è passata nel diritto internazionale (westfaliano); il suo tramonto (parziale) ha connotato le guerre “assolute” del XX secolo (le due mondiali e quelle di decolonizzazione).
- ...
- Su “L’Opinione delle libertà” Savarese, Sola e Holmes hanno ricordato le incongruenze, le falsificazioni della realtà, le omissioni di una propaganda anti-russa che ha raggiunto (e talvolta sorpassato) i limiti del ridicolo, ora stigmatizzata della nuova amministrazione Trump. Holmes ha più diffusamente di quanto da me fatto (v. il “Primo della classe”) sottolineato la corrispondenza tra le prime mosse di Trump e i consigli di Machiavelli; in particolare ai governanti innovatori, di stare accorti perché toccano interessi consolidati. Segnatamente le mosse del nuovo Presidente, come il discorso di Vance, denotano la consapevolezza dei governanti americani di essere, il cambiamento in atto, più un passaggio d’epoca che una sostituzione di un governo con uno di segno opposto.
- ...
- Mentre termino di scrivere queste righe si è votato in Germania. Nell’articolo “Avanti il prossimo” mi riferivo (nell’immediato) proprio a Scholz, puntualmente defenestrato dai suoi elettori, secondo un copione che va avanti in occidente da diversi anni, invariato. I partiti anti establishment aumentano sempre e spesso vanno al governo. Quando non ci riescono i governi messi su sono instabili, come notato da Vance. Come invariate sono le reazioni (e le veline mainstream conseguenti) delle élite europee (in lista di sbarco).
- ...
- Non so se sia ormai troppo tardi per loro organizzare una contrapposizione all’offensiva politica trumpiana, ma occorre aggiungere che il carattere “nuovo” di questa impone non una reazione come quella già in atto, che i Trump-sovran-populisti rompono l’unità europea (fanno il gioco degli USA, sono i maggiordomi del nuovo padrone, ecc. ecc.), giacché come difensori dell’indipendenza europea le élite non sono in condizioni di dare lezioni a nessuno, ma ancor più, perché l’unità europea, come gli ha (implicitamente ed esplicitamente) ricordato Vance, l’hanno liquidata loro.
- ...
- Se ai costruttori dell’Europa (da Adenauer a Monnet, da Spaak a Martino) era evidente che l’Europa occidentale (democratica e liberale) non era altro che la creazione del cristianesimo occidentale, a loro questa ovvietà è ostica, al punto di aver rifiutato le radici giudaico-cristiane (e aggiungiamo greco-romane) che hanno tenuto uniti i popoli malgrado organizzati in diverse sintesi politiche, da ultimo gli Stati nazionali. Alla divisione verticale in Stati, che i loro predecessori volevano (e speravano) gestire hanno sostituito quella orizzontale tra élite e popoli, oltretutto coltivandola, sia per inconsapevolezza, sia per miope interesse, così facendola diventare prevalente e decisiva.
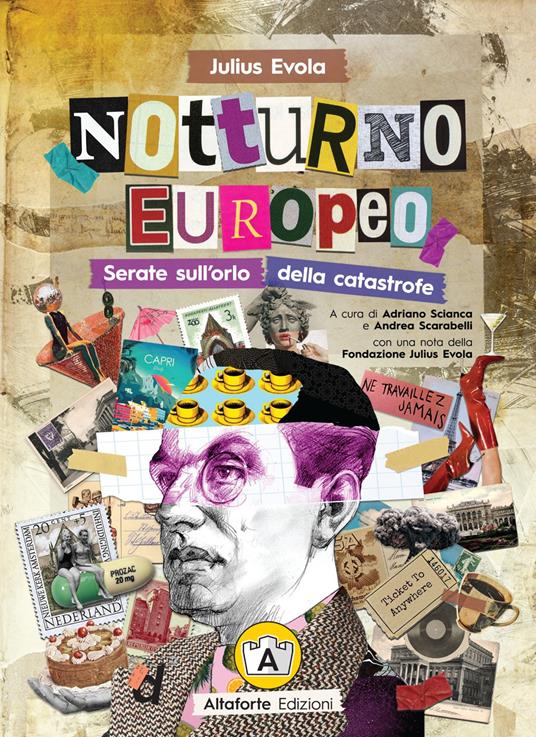
"Serate sull’orlo della catastrofe"- Le notti di Evola nelle capitali d’Europa
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Nell’anno da poco concluso, il 2024, cinquantenario della morte di Julius Evola, sono stati pubblicati diversi libri sul pensatore tradizionalista e nuove edizioni di sue opere. Ci occupiamo qui dell’ultima uscita, la silloge di articoli evoliani intitolata, Notturno europeo. Serate sull’orlo della catastrofe, comparsa nel catalogo di Altaforte Edizioni per la cura di Andrea Scarabelli e Adriano Scianca (pp. 156, euro 16,00).
- ...
- Il libro è aperto da una Nota della Fondazione Evola. L’introduzione è firmata da Scarabelli, la postfazione da Scianca. Il volume raccoglie una serie di reportage del filosofo risalenti agli anni Trenta (solo due degli articoli antologizzati sono del 1929). In essi l’autore si mostra attento osservatore della “vita notturna” delle principali capitali europee. I testi sono tratti da diverse testate alle quali il pensatore collaborava: innanzitutto da Il Regime Fascista di Farinacci, per il quale Evola fu, dal 1937, “corrispondente estero”, ma anche dal Tevere, dal Corriere Padano e dal Roma. Il volume è chiuso da un’Appendice che raccoglie due lettere del tradizionalista al pittore de Pisis e testimonianze varie sulla frequentazione evoliana dei locali notturni.
- ...
- A qualche lettore, questo interesse del pensatore, questa sua attività poco nota, potrebbe sembrare atipica o, addirittura, impensabile. In realtà, non è così. Comprendere le ragioni che indussero Evola a frequentare i tabarins fino all’alba, e non solo i chiostri dei Cistercensi o le alte vette innevate, consente di acquisire piena contezza della sua personalità, centrata sulla volontà di mettersi costantemente alla prova.
- ...
- Nelle capitali europee egli si recò per intervistare insigni rappresentati del mondo della politica e della cultura del tempo, in particolare il milieu rivoluzionario-conservatore tedesco e austriaco, esplicitando, in tal modo, le sue intenzioni metapolitiche che, come nota Scarabelli, ebbero: «la rivoluzione conservatrice come ascissa “orizzontale” e il tradizionalismo integrale come ordinata “verticale”» (pp. 12-13). La “vita notturna” è osservata dal filosofo con attenzione e distanza interiore propria di un “convitato di pietra”. Per capire il senso profondo della silloge è bene tenere in considerazione il fatto che Evola scrisse questi pezzi sull’orlo della catastrofe europea, nell’imminenza dell’esito esiziale del Secondo Conflitto. Può valere da introduzione, quanto il filosofo nota in Momenti dell’Europa notturna: «”Vita notturna” è […] un concetto borghese. Alla concezione borghese […] si deve […] l’opposizione fra la vita normale diurna, più o meno addomesticata […] e la “vita notturna, intesa come […] compensazione […] con caratteri di cosa proibita […] peccaminosa» (p. 26).
- ...
- La capitale asburgica è descritta da Evola con queste parole: «Non sei più la Vienna regale e imperiale […] la monumentalità tutta e perenne della tua anima di pietra» (p. 50) appartiene ormai al passato. La vita dei viennesi è dominata dall’agitazione perpetua, senza centro e senso, dilaga l’odio per grandezza e aristocrazia. La Vienna descritta da Evola è “città senza qualità”. A Budapest il sentore della trascorsa grandezza è risvegliato in lui dai violini zigani: questa musica, dal tratto magico, è atta a indurre, sullo sfondo della notte danubiana, sentori di una visione del mondo al momento solo sopita. Bellissimo e suggestivo, rileva Scarabelli, il racconto della sua cavalcata notturna nei dintorni della città ungherese, durante la quale il filosofo apprezzò l’illimitatezza e la dolcezza del cielo stellato di fronte al quale: «ciò che era soltanto sentimento si libera e si illumina, e la nostalgia umana dà luogo a una nostalgia più vera e virile, alla nostalgia verso l’infinito» (p. 93). A Belgrado l’acquavite, sorbita nei locali notturni, induce in Evola stati evocatori durante i quali: «sembra che le impressioni delle cose […] ci giungano […] come in una naturale, calma rivelazione» (p. 42).
- ...
- Non diverse furono le esperienze e le impressioni che il filosofo visse a Capri, “isola pagana”, prima che, a muovere dagli anni Trenta, divenisse luogo dell’invasione turistica perpetrata da barbari moderni insensibili alla voce del Mediterraneo metafisico. A Capri, Evola ebbe contezza che la vita dionisiaca metamorfizza la realtà, mostrando che l’uno si dà nella physis, nella molteplicità tragica e abbagliante della natura solare. Evola si confrontò con l’invisibile, con il principio che muove il mondo, anche durante i soggiorni sulle Alpi, nel castello, infestato di presenze, dei Tauferes a Campo Tures.
- ...
- Scianca, nello scritto che chiude il libro, mette in atto un inusitato e interessante confronto tra la descrittiva “notturna” di Evola e quella dei situazionisti. A dire dello studioso, Evola, al pari del primo Debord, in questi scritti ha realizzato un esercizio di psicogeografia: «Non si tratta di immaginare “sintesi” pasticciate tra Evola e il situazionismo, semmai di leggere Evola attraverso il situazionismo» (p. 137). Evola e i situazionisti hanno sviluppato, infatti, una radicale “critica della vita quotidiana” indotta dall’urbanesimo moderno con i suoi determinismi sottaciuti, ma capaci di agire in profondità sull’immaginario collettivo. Per destrutturare il “meccanicismo” della vita moderna, il vagabondaggio urbano, anche notturno, gli incontri casuali nei tabarins hanno svolto, per il tradizionalista e i situazionisti (non casualmente sensibili al mito), ruolo dirimente. Evola, dunque, quale flâneur baudelairiano, latore di una “metafisica dell’episodico” (chi scrive preferisce l’espressione “filosofia del singolare”).
- ...
- Nei locali notturni il filosofo mise alla prova se stesso, l’idea di individuo assoluto, proteso alla conquista della libertà in un processo iperbolico sempre in fieri. È il riferimento a Dioniso a differenziare Evola da Debord. La deriva “etilica” del tradizionalista mira a un: «Io potenziato che integra in sé elementi dionisiaci incardinati in una lucidità superiore, che sa davvero far parlare Dioniso con la voce di Apollo» (p. 150). Il suo dionisismo non è semplice via di fuga dalla vita borghese in funzione compensativa. Il filosofo ha contezza dell’eterna presenza della potestas dionisiaca, dell’origine. I limiti del situazionismo sono superati, nella sua visione, dalla categoria di tradizione (con la “t” minuscola”, come egli la scrisse fino al 1934): lo spettacolo della tradizione, con i suoi miti e riti, è l’antidoto alla società dello spettacolo contemporanea, in quanto radica l’uomo in una comunità di destino.
- ...
- Sappia il lettore che questi articoli di Evola sono rari cammei letterari. La prosa è godibilissima, in alcuni momenti lirica e poetica. Il filosofo ha il tratto tipico dell’“uomo difficile” hofmannsthaliano. Appartenne a quella genia umana che seppe vivere a proprio agio nei locali notturni o sulle vette montane, esemplare rappresentante dell’aristocrazia dello spirito di cui ha detto Péter Esterházy in Harmonia caelestis. Con buona pace della vulgata “evolomane” e dei suoi dogmi.
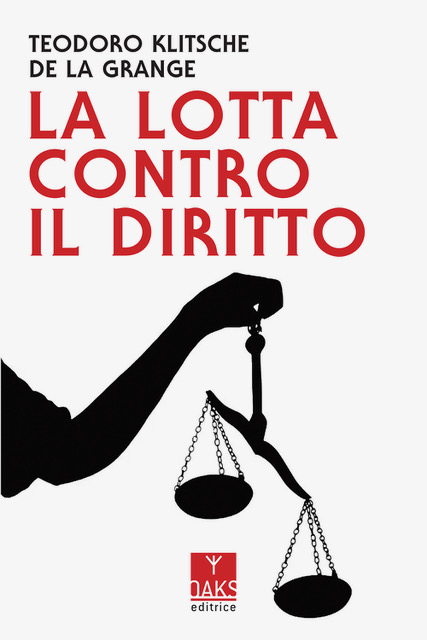
"LA LOTTA CONTRO IL DIRITTO"- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- recensione di
- Giovanni Sessa
- Teodoro Klitsche De La Grange è giurista e tributarista di vaglia, editore e direttore della rivista di cultura politica e di diritto pubblico «Behemoth», nonché autore di un numero assai rilevante di saggi giuridico-politici. È nelle librerie la sua ultima fatica, La lotta contro il diritto, comparsa nel catalogo di Oaks editrice (per ordini: info@oakseditrice.it, pp. 111, euro 12,00). Il titolo del volume, richiama, invertendolo di segno, uno scritto di grande importanza di Rudolf von Jhering, La lotta per il diritto. La ragione di tale scelta è da individuarsi in una constatazione storica non smentibile: la legislazione italiana, in particolare a muovere dalla “Seconda Repubblica” e dagli anni Novanta del secolo scorso, ha, in molti casi, reso praticamente impossibile l’esercizio dell’azione in giudizio dei privati e, con essa, l’attuazione degli stessi provvedimenti giudiziari.
- ...
- De La Grange, nell’incipit del testo, nello sviluppare la sua critica allo stato presente delle cose in Italia (ma non solo), muove proprio dalle tesi di Jhering. Questi sostenne il diritto essere un’attività pratica che vive, pertanto, esclusivamente nella sua concreta attuazione. Il diritto possiede, inoltre, tratto conflittuale, centrato com’é sulla distinzione/opposizione tra lecito ed illecito. Vi sono un diritto obbiettivo e un diritto subbiettivo. Il primo si incardina nell’ordinamento giuridico della vita, nei principi generali mirati alla preservazione dell’ordine, il secondo consta, al contrario, del suo inverarsi verso il basso: «il discendere dalla regola astratta sino ad investire la persona di un diritto in modo concreto» (p. 7). Il diritto privato statuisce la possibilità dell’individuo di agire per realizzare i propri diritti lesi, e la sua azione dà vita, fa essere, realizza il diritto obbiettivo. Agire in tal senso ha, lo riconobbe lo stesso Croce, tratto etico, in quanto contribuisce a mantenere saldo l’ordinamento giuridico vigente che, a sua volta, è condicio sine qua non, di un’ordinata vita comunitaria. A ciò contribuiscono, in modalità differente, tanto la legge ordinaria e costituzionale, quanto la sua “fonte”, il diritto consuetudinario, sedimento della storia e dell’ethos di un dato popolo.
- ...
- Ricorda il nostro autore che, posizione non dissimile in tema, fu sostenuta da Hauriou. Il grande giurista riteneva che ambedue le forme giuridiche, istituzionale e comune, fossero indispensabili a mantenere la pace sociale, essendo questa il risultato di un equilibrio tra “comando” dei governanti e “risposta” accettata da parte dei governati. La legislazione italiana, elefantiaca e contraddittoria, ha creato, nel corso degli ultimi decenni, una situazione di evidente squilibrio che grava, in toto, sulle spalle dei secondi, a tutto vantaggio della Pubblica Amministrazione. Tale: «posizione d’ineguaglianza deriva da una serie di “privilegi” e “disparità” del potere pubblico» (p. 12). In particolare, esistono differenze evidenti e crescenti tra il diritto applicato ai rapporti privati e quello tra PP.AA. e privati. Temi (la giustizia tra diseguali) e Dike (la giustizia tra eguali) sono oggi assai distanti tra loro, chiosa De La Grange.
- ...
- La minorità giuridica dei cittadini è il risultato, ci ricorda l’autore, di un serie di concause, stratificatesi nel tempo. La situazione attuale, in estrema sintesi, mostra una serie di problematicità: 1) L’azione giudiziaria civile è sempre più difficoltosa e costosa; 2) Tutto mira alla tutela della PP.AA. a scapito dei diritti dei singoli cittadini; 3) Anziché “realizzare” il diritto, in Italia si è pensato (senza successo) a ridurre il costo della giurisdizione, facendo ricorso, perfino, a processi-specchietto (Berlusconi) presentati quali esempio di “lotta” per il bene comune; 4) I problemi della giustizia non sono stati risolti in quanto si è ritenuto che essi fossero prodotti da una falsa causa: la litigiosità degli italiani. Una condizione, quella dell’Italia contemporanea, in cui il cittadino vive in uno stato di subordinazione e passività rispetto alle istituzioni. Per questa ragione, il libro di De La Grange è di grande attualità: invita il lettore a lottare per il diritto, unica strada percorribile per riacquistare il rispetto di sé e l’effettiva sovranità politica che, in democrazia, dovrebbe spettare al popolo.
- ...
- In questo senso, sarebbe necessario tornare a guardare con interesse al discorso di Callicle, così come trascritto da Platone nel Gorgia. Questi sostenne, contrapponendosi a Socrate, che l’uomo dabbene dovrebbe reagire all’ingiustizia subita, senza porgere l’altra guancia. In questo modo, provvedendo a difendere se stesso, compirebbe, in egual modo: «un dovere verso la comunanza» (p. 79). D’altra parte, gli attuali reggitori della cosa pubblica, dovrebbero tornare ad ascoltare il consiglio che Emone, figlio di Creonte, re di Tebe, dette al padre nell’Antigone. Emone richiamò il genitore al giusto equilibrio, suggerendogli di tener nel dovuto conto il diritto consuetudinario e tradizionale. In solitudine, infatti, si può regnare solo su una terra deserta, desolata, in quanto il “politico” è, per essenza, fondato sul conflitto tra la molteplicità delle parti. Di tale contesto ebbe contezza Machiavelli, ricorda il nostro autore, il quale, per tale ragione, si prodigò a sollecitare il Principe a un’aurea sovranità: ogni governante dovrebbe tenere sempre in seria considerazione il sentimento e l’umore del popolo del quale è guida e tutore.
- ...
- L’attuale élite di potere sembra aver obliato simili considerazioni. Il nostro ordinamento giuridico, connotato da una fiscalità predatoria e solo astrattamente orientato alla difesa dei diritti, in realtà è lo strumento che sta gradualmente trasformando i cittadini in sudditi, incapaci di chiedere e ottenere per sé giustizia. Lo Stato dovrebbe proteggere, lo rilevò Hobbes, i governati. Per cui, nella situazione attuale: «non c’è alcuna ragione per ubbidire a chi non protegge» (p. 92) e, il più delle volte, è incapace di riconoscere le proprie colpe. Non resta, al fine di un possibile riavvicinamento di governati e governanti che lottare, come suggerisce De La Grange, per il diritto. Una battaglia per la libertà e la sovranità popolare. Cosa non da poco, nel pieno dispiegarsi dell’età della governance.
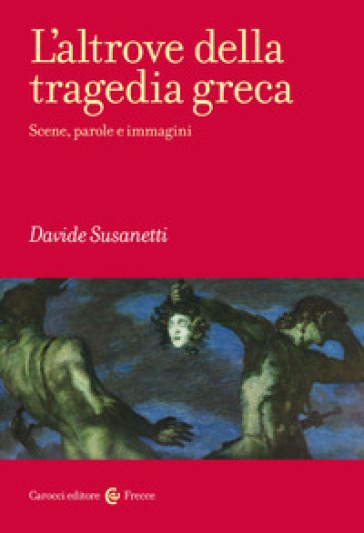
"Quei discorsi d’amore"- Il grecista Susanetti a confronto con il
- Simposio di Platone
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Colli ha sostenuto che il Simposio di Platone é testo sul quale aleggia, prepotente, il “fiore della gioventù”, nel quadro di una visione della vita protesa alla ricerca dell’“intero” attraverso la singolarità corporale. A ricordarlo è Davide Susanetti, grecista dell’Università di Padova, nel suo ultimo libro, Quei discorsi d’amore. Leggendo il Simposio di Platone, nelle librerie per Carocci editore (pp. 183, euro 20,00).
- ...
- Non si tratta, sic et simpliciter, di un volume mirato alla mera ricostruzione storico-filologica di un testo capitale del pensiero europeo, ma di uno scritto cruciale. Le sue pagine pongono il lettore al cospetto del quesito che già fu di Eliot: è possibile: «re-incantare l’orizzonte di una terra desolata?» (p. 8), di un mondo, quello post-moderno, in cui si pensa, per dirla con Badiou, dalla fine? Susanetti, se abbiamo ben inteso, risponde affermativamente alla domanda. È la parresia, il bisogno di affermare il vero, in una dinamica esistenziale animata da nóstos, a consentirci il confronto, qui e ora, con un desiderio assoluto, atto a scioglierci dai condizionamenti dell’Io cosale, che ci fa pervenire all’intero, all’identità con l’origine che da sempre siamo.
- ...
- Lungo tale iter, il Simposio è viatico essenziale. La prosa di Susanetti è “viva”, fluente, mirata, come quella dei dialoghi platonici, a una teatrale messa in scena della “verità”. Da essa si evince che il principio, nella vita, é intrecciato all’“errore”. La modalità scrittoria del grecista è “parola” che dice la: «ripetibile irripetibilità» (p. 11) dell’origine, del principio. Lo attesta la sua esegesi del dialogo, compiuta e organica. Da essa si deduce che, nell’autore, la competenza filologica non é mai disgiunta da un approccio empatico nei confronti delle tematiche trattate. L’ermeneutica di Susanetti è autenticamente filo-sofica, dice l’“unizione” di particolare e universale che: «si danno insieme, trasformandosi l’uno nell’altro» (p. 30). La lettura muove dal prologo del Simposio, inteso quale rinvio ad un “prima” apparentemente perso: «Era il 416 e Agatone […] si era aggiudicato il primo posto alla festa delle Grandi Dionisie» (p. 14). Il poeta tragico invitò i comites ad un simposio, presso la propria abitazione. Il 416 è data di rilievo: soglia che separa un “prima” e un “poi” nelle vite dei convitati, aristocratici che presto sarebbero stati travolti dagli eventi successivi alla conquista ellenica della Sicilia. Socrate si reca verso casa di Agatone in compagnia di Aristodemo, ma poco prima di giungervi, si appartò com’era sua consuetudine. Per andare a “caccia” dell’ arché è necessario che l’anima “si raccolga”, si isoli dal corpo e dal mondo.
- ...
- «Tó sophón […] è qualcosa che ognuno deve raggiungere da sé in quel medesimo stato di raccolta concentrazione» (p. 27). Socrate è uomo “eccentrico”, è atopos. Il suo comportamento allude a un “altrove” che, in realtà, è sempre in noi. Superando la soglia d’ingresso della magione cui è stato invitato, il filosofo testimonia simbolicamente la possibilità di aver accesso al principio. Susanetti ricostruisce con maestria e forza persuasiva, lo sviluppo del dibattito tra i convitati, rilevandone il tratto rituale: «a cui partecipano gli dèi con la loro […] potenza» (p. 31). La capacità evocativa dall’autore, è prossima a quella del “cosmico monacense” Alfred Schuler nella sua presentazione della Caena romana. Susanetti afferma, infatti, che nel sacro banchetto: «Mentre i doni congiunti di Dioniso e delle Muse esercitano l’incanto che è loro […] un’altra forza si rende presente e opera tra i simposiasti: la potenza del dio Eros» (p. 33). In tema, Fedro, che prese per primo la parola, si richiamò a Esiodo. Questi, aveva concesso a Eros la possibilità di determinare il transito dal caos primigenio alla genesi del cosmo. Un Eros omerico, avente a cuore il mondo eroico e l’areté, sigillo della “perfezione” che si conquista nell’azione, in una: «sfida sempre rinnovata con la morte» (p. 43).
- ...
- Pausania intrattenne i convitati sulla duplicità del reale, sostenendo la necessità di cogliere, in tale relatività sofistica, ciò che è “corretto”. Neppure Eros è “uno”, si accompagna ad Afrodite. La stessa genealogia della dea è duplice: a fianco di Afrodite “Urania” vi è sempre Afrodite “Pandemia”, dea anagogica e catagogica in uno. Lo spudaios guarda alla prima. L’Eros celeste: «si scioglie nel nitore dell’ areté e della sophía» (p. 56).
- ...
- Il medico Erissimaco, di contro, rileva la presenza di Eros in tutto ciò che vive, non solo negli uomini. Da qui la duplicità di “salute” e “malattia”. Nei corpi va assecondato ciò che è “buono”, equilibrante, in termini empedoclei e nel senso della sacra medicina di Asclepio, e allontanato ciò che “divide”, “dissolve”: «Metabolé è “ingenerar amore” ove è conflitto» (p. 63), a seconda delle diverse circostanze, servendosi di musiche appropriate, come aveva insegnato Damone. A questi ribatté Aristofane che spiegò l’attrazione erotica, etero e omosessuale, rammemorando il mito dell’Androgine e della sua divisione perpetrata da Zeus. Da allora, il magnetismo erotico induce il superamento dei limiti di un presente segnato da: «una profonda disforia e da una mancanza» (p. 71). Eros è potenza unitiva: i bei corpi suscitano il desiderio della completezza. Al contrario, dall’intervento di Agatone si evince la verità tragica di Eros. Questi esercita: «una signoria straziata e straziante, […] un imperio universale che si intreccia immancabilmente alle derive della […] distruzione» (p. 85).
- ...
- La via alla liberazione erotica, al risveglio, emerge, in piena chiarezza, solo nel discorso di Socrate, che riassume i colloqui da questi intrattenuti con Diotima. Si tratta del sapere misterico-iniziatico che richiede un processo di purificazione. Eros è demone posto nel metaxú, tra umano e divino, è traghettatore nel tempo, in chronos, in un “attimo immenso”, di aion. La nascita e il parto che esso propizia hanno a che fare, tanto con il corpo, quanto con l’anima. La verità dell’amore sta nel perseguire l’a-mors, il senza-morte, che non è dei corpi ma del principio che li anima. Per giungere alla visione finale è necessario attenersi a una prassi ritualizzata, in cui i “discorsi” aprono il processo ma non lo chiudono. Si tratta di un “contatto”, di una: «visione senza contenuto, senza immagine» (p. 107). L’origine è non-ente, non concettualizzabile dal lógos. La parola e la scrittura possono, al massimo, suscitare nostalgia e, attraverso l’anamnesi, sospingere lungo la Via. Questo il senso del Simposio e del libro di Susanetti.
- ...
- La Via è: «Possibilità di una seconda nascita in cui si sente e si vive che l’oltre non è un altrove e in un altro tempo, ma è il medesimo del qui e dell’ora nell’intensità di una dimensione interna ad esso» (pp. 108-109). L’origine e la tradizione non sono passato, ma sono il sempre della vita, la pratica erotico-iniziatica lo mostra in tutta evidenza. Susanetti, con queste pagine, si pone in sequela di coloro che, pur nella mestizia del presente, hanno mostrato la possibilità del tradere, la possibilità di guardare il mondo con sguardo assoluto: il suo lascito è un possibile nuovo incantesimo della vita.
- "AVANTI IL PROSSIMO"
- di
- Teodoro Klitsche de la Grange
- Ha ottenuto una risonanza planetaria il discorso da Monaco di J. D. Vance in cui ha rampognato le classi dirigenti europee. Le reazioni di quella italiana (di centrosinistra) e della stampa mainstream sono state le solite. Chi, riferendosi all’incontro di Vance con i leaders di AFD l’ha ricondotta alla consueta reductio ad hitlerum; i più a una interferenza (ovviamente inammissibile perché non sollecitata da loro); altri al tentativo di far dimenticare analoghi errori della politica USA, e qua siamo al focherello, perché prassi simili sono state poste in essere dalle amministrazioni di Biden ed Obama (salvo altri).
- ...
- A me preme di notare che in quanto affermato da Vance siano enunciate idee che da millenni, o da secoli fanno parte del pensiero politico realista, quello parafrasando Machiavelli, che prende in considerazione la realtà dei fatti e non l’immaginazione degli stessi. Due in particolare.
- ...
- La prima è che l’Europa è in crisi, e che questa è per così dire endogena. Dice Vance: “L’Europa deve affrontare molte sfide, ma la crisi che questo continente sta affrontando in questo momento, la crisi che credo stiamo affrontando tutti insieme, è una crisi che abbiamo creato noi stessi” Questa è dovuta a “come molti di voi in questa sala sapranno, la Guerra Fredda ha schierato i difensori della democrazia contro forze molto più tiranniche in questo continente. E considerate la parte in quella lotta che censurava i dissidenti, che chiudeva le chiese, che annullava le elezioni. Erano i buoni? Certamente no. E grazie a Dio hanno perso la Guerra Fredda. Hanno perso perché non hanno valorizzato né rispettato tutte le straordinarie benedizioni della libertà. La libertà di sorprendere, di sbagliare, di inventare, di costruire, poiché a quanto pare non si può imporre l’innovazione o la creatività, così come non si può costringere le persone a pensare, a sentire o a credere a qualcosa, e noi crediamo che queste cose siano certamente collegate. E purtroppo, quando guardo all’Europa di oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della Guerra Fredda”. In altre parole l’Europa decade perché non crede essa stessa nei propri valori. A chiosare quanto affermato dal vice presidente USA, perché ha oscurato le radici giudaico-cristiane, cioè il fondamento della democrazia liberale, in particolare nella “variante” della dottrina del diritto divino provvidenziale. Nei due capisaldi fondamentali: il rispetto per le decisioni e convinzioni della comunità e la tutela dei diritti di ciascuno, comunque quello di manifestazione della libertà del pensiero. Per cui, sempre a leggere Vance, alla luce di Machiavelli, farebbero molto bene i governi europei a “ritornar al principio”, cioè ai fondamenti dell’ordine politico democratico-liberale e non all’(ipocrita) camuffamento del medesimo.
- ...
- La seconda. Vance ha poi posto un problema di potenza politica. Infatti dice: “Se avete paura dei vostri stessi elettori, non c’è niente che l’America possa fare per voi, né, del resto, c’è niente che voi possiate fare per il popolo americano che ha eletto me e ha eletto il presidente Trump. Avete bisogno di mandati democratici per realizzare qualcosa di valore nei prossimi anni. Non abbiamo imparato nulla dal fatto che mandati deboli producono risultati instabili, ma c’è così tanto valore che può essere realizzato con il tipo di mandato democratico che penso verrà dall’essere più reattivi alle voci dei vostri cittadini. Se volete godere di economie competitive, se volete godere di energia a prezzi accessibili e catene di approvvigionamento sicure, allora avete bisogno di mandati per governare perché dovete fare scelte difficili per godere di tutte queste cose e, ovviamente, lo sappiamo molto bene in America”. E qua Vance ha posto un tema fondamentale del pensiero politico ossia, a sintetizzarlo al massimo, quello dell’obbedienza (del consenso, della legittimità) e del rapporto con la potenza dell’istituzione politica (o nelle “varianti” dei governanti, delle comunità). È intuitivo che un comando che non ottiene obbedienza non è comando reale; quello che la ottiene, ma soltanto con la coazione, dura poco (è instabile). Quindi l’ideale è che il comando sia sempre corrisposto da un certo grado di obbedienza (anche se non perinde ac cadaver). Meno intuitivo è che un governo, poco confortato dal consenso degli elettori (pour richiamandosi alla democrazia) è un governo debole.
- ...
- Scriveva Spinoza: “Il diritto dello Stato, infatti, è determinato dalla potenza della massa, che si conduce come se avesse una sola mente. Ma questa unione degli animi non sarebbe in alcun modo concepibile, se lo Stato non avesse appunto soprattutto di mira ciò che la sana ragione insegna essere utile a tutti gli uomini” e che “non è il modo di obbedire, ma l’obbedienza stessa, che fa per il suddito”; ciò, malgrado non ammettesse un dovere d’obbedienza assoluta, Anche se un monarca come Federico II di Prussia enunciava come fattori di potenza e di sicurezza di uno Stato: esercito, tesoro, fortezze, alleanze” (omettendo così il consenso/obbedienza) è sicuro che senza questa, il potere del governante è ridotto ai minimi termini. L’ordine e la coesione sociale e politica che ne consegue – al contrario - facilitano sia l’esecuzione delle obbligazioni, anche internazionali come, del pari, rendono vane – o limitano – la possibilità di speculare dall’esterno sulle rivalità e conflitti tra i governati e soprattutto sui gruppi in cui si dividono. E pluribus unum non è solo il motto degli USA: è il compito e lo scopo di ogni unità politica vitale.
- ...
- Ma se, al contrario, tale unità degli animi non si realizza, anzi si sviluppano nuove contrapposizioni, a farne le spese è, in primo luogo, la potenza (in senso weberiano) dell’istituzione statale, che vede nullificata o radicalmente ridotta la possibilità che la propria volontà possa essere fatta valere. Il parametro sul quale giudicare la potenza dello Stato è esistenziale e non normativo. La scelta virtuosa, dice Vance, è abbracciare “ciò che il vostro popolo vi dice, anche quando è sorprendente, anche quando non siete d’accordo. E se lo fate, potete affrontare il futuro con certezza e fiducia, sapendo che la nazione è al fianco di ognuno di voi, e questa per me è la grande magia della democrazia… Credere nella democrazia significa capire che ogni cittadino ha la propria saggezza e la propria voce, e se ci rifiutiamo di ascoltare quella voce, anche le nostre battaglie più riuscite otterranno ben poco…. Non dovremmo avere paura del nostro popolo, anche quando esprime opinioni in disaccordo con la propria leadership”. Mentre nelle istituzioni europee a molti “non piace l’idea che qualcuno con un punto di vista alternativo possa esprimere un’opinione diversa o, Dio non voglia, votare in modo diverso o, peggio ancora, vincere un’elezione”. E in ciò Vance non ha fatto altro che seguire non solo il pensiero politico realistico, ma anche la prassi del diritto internazionale (sia classico che post-vestfaliano) per cui soggetto di diritto internazionale, o comunque interlocutore è chi ha il potere, in una comunità; chi lo aveva, anche se titolare legale, ma non ce l’ha più, lo perde. Chi è in “lista di sbarco” come gran parte ella classe dirigente europea, è un interlocutore debole e quindi inutile. Dato che, negli ultimi anni, la gran parte dei paesi dell’U.E. ha visto cambi di governo a favore di sovranisti (lato sensu) e, laddove non è successo, gli stessi sono cresciuti, di guisa che perfino la stabilissima quinta repubblica francese è diventata bastabile, è chiaro che i suddetti governanti non sono ritenuti interlocutori reali. A meno che – quanto meno improbabile – non recuperino il favore popolare. Ma se ciò non avviene non resta che aspettare le elezioni: avanti il prossimo.
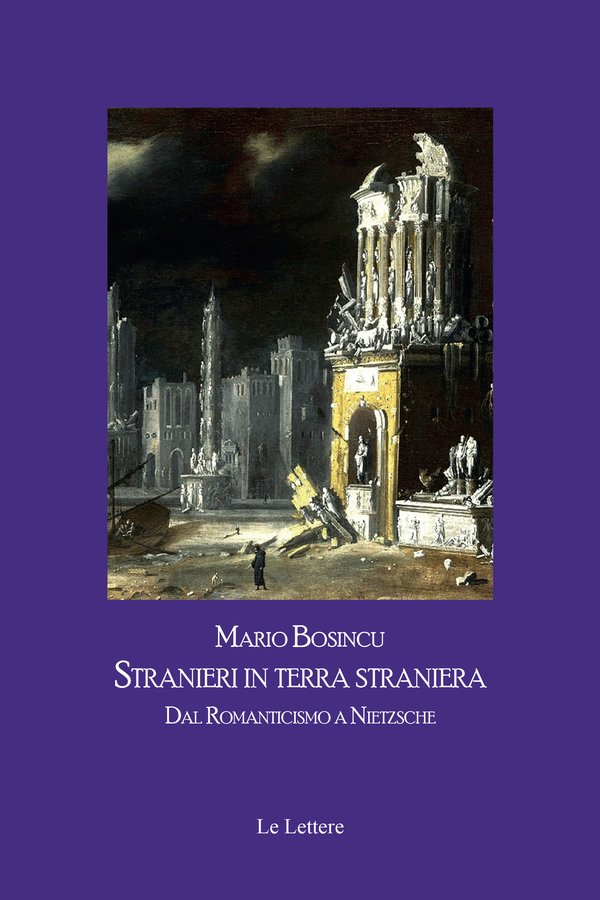
"Stranieri in terra straniera"- Un saggio di
- Mario Bosincu
- rec. di
- Giovanni Sessa
- Mario Bosincu, germanista dell’Universitàdi Sassari, in precedenti lavori aveva messo in luce di essere studioso di livello. La lettura della sua ultima fatica, ha confermato in noi questa impressione. Ci riferiamo al volume, Stranieri in terra straniera. Dal Romanticismo a Nietzsche, nelle librerie per la casa editrice Le Lettere (pp. 377, euro 25,00). Si tratta di un saggio informato, costruito su analisi filologicamente inappuntabili, che non rendono, si badi, il gesto scrittorio e ricostruttivo dell’autore mera esercitazione erudita. La scrittura è, infatti, viva, fluente e, per certi tratti, evidenzia il vivo interesse di Bosincu per le tematiche affrontate, senza che ciò pregiudichi il tratto scientifico del saggio. Il libro, rileva il germanista: «intende far luce su alcune figure esemplari dell’alterità, comparse in ambito filosofico-letterario tra la fine del Settecento e la Seconda Guerra mondiale […] perlopiù, della cultura tedesca» (p. VII). Si tratta di un excursus nel quale, muovendo dalla Romantik, Bosincu compie l’esegesi della proposta filosofico-esistenziale di Nietzsche per approdare, infine, all’interpretazione dello scritto di Friedrich Georg Jünger, Apollo, Pan, Dioniso del 1943.
- ...
- Chi sono i pensatori interrogati da Bosincu? Filosofi e scrittori della Kulturkritik, degli “antimoderni”. La definizione rinvia a una assai vasta congerie di autori che scorsero nella modernità, inaugurata dall’illuminismo, un depauperamento della vita. Questi intellettuali sviluppano: «una modalità di riflessione che fa emergere i tratti patologici della modernità, […] guarda al passato premoderno […] e tratteggia l’ideale antitetico dell’uomo totale» (p. 3). Tra essi va, preliminarmente, ricordato Schiller. Questi coglie, nell’età a lui contemporanea, l’indebolirsi delle facoltà umane a esclusivo vantaggio dell’intelletto analitico, scientifico e strumentale, posto al servizio del Gestell e della ricerca dell’utile economico. L’età moderna è esperita quale epoca del ritorno dei Titani, centrata sulla “potenza” della dismisura e obliante le qualità proprie della persona, dell’individuo persuaso e conciliato con le potestates animanti il cosmo. Al medesimo tempo, gli “antimoderni” scoprono, in forza del lascito illuminista, la nostra storicità, comprendendo che l’uomo dimidiato, l’uomo a una sola dimensione della modernità, ha tratto contingente e può essere superato. Non casualmente, Nietzsche rileva che: «“il poter essere diverso” […] rientra fra gli attributi della “grandezza”» (p. 5).
- ...
- Lo avevano mostrato proprio gli illuministi che, con i loro scritti, avevano realizzato una “colonizzazione dell’immaginario” modernizzante. Sarebbe risultato necessario realizzare un “contro-movimento” mirato alla creazione di una “soggettività” altra, diversa, che rintracciasse i propri paradigmi, i propri exempla nel passato medievale o nella visione del mondo ellenica. Quest’uomo utopico, giammai “utopistico” (i due termini, per chi scrive, hanno valenza non conciliabile) sarebbe stato latore della Kultur (Spengler) in contrapposizione alla decadente Zivilisation. La Romantik e tutti gli autori indagati da Bosincu, sono, per dirlo con Löwy e Sayre, latori di una visione anticapitalista ed esteticizzante, portatori di un codice esistenziale alternativo, come riconobbe Sombart, all’identità borghese. L’uomo nuovo doveva essere costruito: «per mezzo di pratiche orientate verso l’interiorità quali l’esperienza della natura e la lettura, una tecnologia del sé» (p. 13), atta a porre in essere una: «resistenza ethopoietica alla modernità» (p. 14). In tal senso agì, tra gli altri, Baudelaire, con il riferirsi al dandy, individuo capace di fare della propria esistenza un’opera d’arte, per differenziarsi dalle masse e dagli idola introdotti dalla ratio calcolante. Esempio diverso, ma non dissimile, di tale ribellione, è rintracciabile anche negli scritti e nella vita di Thoreau, nel suo ritorno alla wilderness.
- ...
- Gli antimoderni di genio sono uomini soli, stranieri in terra straniera che, nell’isolamento necessario alla pratica filosofica, realizzano la metanoia, il “cambio di cuore”. Le loro opere sono “comunicazione d’esistenza” che, come sostenne Kierkegaard, non volevano rivolgersi al lettore di “Gazzette”, ma avrebbero teso a “prenderlo per il collo”, animate com’erano dall’urgenza di fargli conquistare uno sguardo epistrofico ed assoluto sulla vita. La letteratura interrogata da Bosincu è, da un lato sermo propheticus (la produzione fichtiana è in tal senso esemplare), dall’altro sermo mysticus che, stante la lezione di Maestro Eckhart, persegue lo “svuotamento” del singolo in un iter di conversione “iniziatica”, che giunge al “risveglio”, al tertium datur della coincidentia oppositorum.
- ...
- Modelli di tale modalità scrittoria, riferisce l’autore, possono essere rintracciati in Marco Aurelio e Petrarca. Gli exempla sono quelli tramandati da Tacito, poi testimoniati dagli Eroi di Carlyle. Gli antimoderni, quindi, si configurano quali parresiasti, intellettuali che affermano il vero nell’età del suo oblio, nell’età in cui, per dirla con Badiou, si pensa dalla fine: «Il piacere della distruzione (del moderno) è, al contempo, un piacere creativo!» (p. 103). Nietzsche, del cui pensiero viene ricostruita dettagliatamente ogni fase, sulla scorta di Feuerbach, è convinto che demolire: «l’idea di Dio […] significa […] spezzare il sortilegio che deruba del suo valore l’al di qua» (p. 103), al fine di rinnovare la “fedeltà alla terra”.
- ...
- Ciò che non condividiamo della dotta ermeneutica di Bosincu è il suo giudizio sul contro-movimento degli autori indagati, che viene inscritto nella stessa logica che sorreggerebbe le tesi neo-gnostiche puritane ed illuministe (Voegelin). A nostro giudizio, gli autori di Bosincu, almeno quelli che guardano alla physis ellenica quale unica trascendenza, lo fanno nella convinzione che solo in essa (Bruno) si dia il principio, l’origine: pertanto, sono alieni da qualsivoglia prospettiva dualista e gnostica. È al dualismo cristiano che si può, di contro, imputare di covare in sé germi gnostici, chiarissimi nella svalutazione della natura e del mondo a beneficio del Perfetto, di Dio. Centrale per la comprensione di tale assunto, risulta l’ultimo capitolo del volume dedicato all’opera di Friedrich Georg Jünger. Quello jüngeriano è un “paganesimo dello spirito”, centrato sulla “fraterna antitesi” di Apollo, Pan e Dioniso. Friedrich Georg mostra di aderire a una prospettiva mitica: ritiene che in ogni ente, nell’interiorità dell’uomo e nelle sue attività, agisca un dio. Il divino è palpitante, si fa esperienza, lontano da ogni esito “wotanista”.
- ...
- Per sottrarsi al dominio reificante del moderno, l’uomo deve recuperare la dimensione immaginale: solo in essa è possibile rintracciare l’alito degli dèi, l’eterna metamorfosi animica della physis. A medesime conclusioni giunsero nell’Italian Thought del Novecento Evola, Emo, Diano e Colli. Chi scrive si sente oggi straniero in terra straniera, pur essendo abbagliato, come i pensatori ricordati, dal thauma, dalla meraviglia tragica della vita.